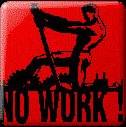
Il ritorno delle Grandi Infrastrutture: il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina
di Alberto Ziparo
Il filone disciplinare legato alle funzioni "ordinatrici e di indirizzo" delle grandi attrezzature territoriali è tuttora rilevante nel campo elaborativo della pianificazione: tuttavia il suo contributo appare meno distintivo rispetto al passato. Sia pure con un "approccio" incrementalista, il paese ha infatti sostanzialmente soddisfatto la primaria domanda di infrastrutture di molte sue parti; peraltro non senza eccessi, per cui si pagano prezzi alti in termini di impatti ambientali e territoriali.
L’attuale esigenza di innovazione del sistema dei trasporti, mira ad accentuarne l’efficacia prestazionale, rispetto ai nuovi assetti del territorio nazionale (Itaten, 1996).
In questo quadro assumono fondamentale importanza le analisi non solo degli impatti, ma anche del senso che i nuovi programmi vanno a configurare per i territori cui si riferiscono. E’ questo il tipo di lettura che nel seguito proponiamo per l’assai discusso progetto di Attraversamento Stabile dello Stretto di Messina.
L’articolo ricostruisce le vicende relative al programma, dall’originario dibattito post-unitario sulla necessità di un collegamento fisso tra la Sicilia ed il Continente, alla redazione delle prime ipotesi di piano nel secondo dopoguerra, all’idea di "Area Metropolitana dello Stretto e Conurbazione con Ponte" contenuta nel progetto ‘80, alle posizioni critiche che, rispetto a tali concetti, sono maturate negli studi più recenti.
Ancora si presentano gli elementi principali del "progetto di attraversamento aereo dello Stretto di Messina" presentato dalla Società Stretto di Messina Spa al governo il 31/12/92 (che ha registrato il parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’ottobre 1997), nonchè le "Osservazioni sullo studio di impatto ambientale", avanzate da Legambiente e da altre associazioni ambientaliste, riprendendo anche recenti lavori di aggiornamento e le posizioni di alcuni urbanisti.
Le immagini più recenti del territorio nazionale ci restituiscono un quadro di relazioni tra insediamenti, infrastrutture e sistema ambientale complicato dalla logica incrementalista - e tutt’altro che pianificata - con cui si è creduto di rispondere alle domande di mobilità delle diverse parti del paese (Itaten, 1996; Secchi, 1995).
Questo, se ha permesso il soddisfacimento sostanziale del "bisogno di traffico" in molte aree, ha favorito una crescita quantitativa e "localmente incrementale" del sistema, rispondente ad approcci parziali, settoriali o occasionali, piuttosto che ad un’organizzazione incentrata su interazioni progettate e innovative tra territorio e trasporti.
L’esito complessivo di tali linee si è scontato spesso, oltre che in tendenze, allo squilibrio - non senza dannosi esuberi - ed alla obsolescenza dell’assetto, in un contributo del sistema di mobilità alla perdita di qualità ecomorfologica del territorio ed anche ad una "caduta di senso" complessivo nell’uso dello spazio.
Di nuovo molte delle ricerche regionali Itaten registrano un acuirsi dei conflitti legati alle nuove domande di spostamento: grande scala contro piccola scala, flussi internazionali versus locali, domande degli abitanti vs. necessità produttive, domande funzionali vs. qualità morfologica: le opposizioni - non soltanto ambientaliste - a molte nuove proposte di infrastrutturazione possono assumersi come indicative di tali processi: si pensi soltanto all’Alta velocità che "attraversa e disastra" sistemi (infra)regionali e locali mentre privilegia i grandi collegamenti continentali.
Gli studi Itaten hanno sottolineato come la necessità di politiche tese al tentativo di composizione dei conflitti citati possa muovere da una visione in qualche modo "innovativa e differenziale" delle reti infrastrutturali, che svolgano in maniera "intelligente" la funzione di servizio ai grandi "corpi territoriali" riconoscibili oggi nel paese.
La verifica delle attrezzature di trasporto, esistenti e previste, alla luce delle linee prospettate dagli "ambienti locali strategici" individuabili dai rapporti fra trame insediative e forme sociali nelle diverse regioni, può costituire un approccio che tende nella direzione di nuove compatibilità tra territorio ed infrastrutture o di una "mobilità sostenibile".
Questo passaggio appare quanto mai necessario nel Mezzogiorno che mentre "ancora subisce gli effetti della arretratezza dei sistemi infrastrutturali primari" continua a pagare - in termini di degrado ambientale, dissesto idrogeologico e deterritorializzazione - il prezzo del fallimento delle politiche dei "poli industriali ed infrastrutturali", che prevedevano di attrezzare, spesso con elementi di dubbia utilità sociale, grande impatto fisico e grande ingombro spaziale, quelli che avrebbero dovuto costituire i terminali del trasferimento "straordinario" di risorse pubbliche al Mezzogiorno. E che si sono spesso risolti, oltre che in ingenti sprechi ed in ritorni di disoccupazione, in cancellazione di economie locali e forti condizionamenti al territorio, fino alla grande e quindi sistematica distorsione nella gestione della cosa pubblica con penetrazioni della criminalità organizzata (allorchè al Sud Tangentopoli incrociava Mafiopoli).
In questo quadro esiste il rischio che il perpetuarsi di vecchie logiche produca nuove aporie: accanto alle operazioni chiaramente necessarie, quali la ristrutturazione della Salerno-Reggio Calabria, il completamento e la riqualificazione delle reti idriche, il consolidamento delle dorsali basso-adriatica e soprattutto jonica, si prospettano infatti nuove "grandi opere" di utilità non acclarata e piuttosto somiglianti con le operazioni più discutibili del recente passato.
Anche per questo è necessario inquadrare la nuova proposta in adeguate logiche di pianificazione economica, territoriale ed ambientale: leggere i nuovi programmi secondo prospettive diverse, che ne denotino gli impatti derivati ed il senso sociale significato.
E’ quanto si tenta di proporre nel seguito per il Progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.
2. La lunga vicenda del Ponte sullo Stretto di Messina.
L’idea del ponte sullo Stretto è tutt’altro che recente: le prime proposte di attraversamento stabile si rintracciano negli atti parlamentari del neonato regno, subito dopo l’unità, allorchè si trattava di prevedere l’ossatura principale della rete ferroviaria nazionale unificata. Dell’originario dibattito sul ponte non resta peraltro che qualche traccia nei resoconti parlamentari di fine secolo: politici ed ingegneri delle ferrovie si accorsero ben presto che l’attraversamento dello Stretto era opera infinitamente più complessa della realizzazione di qualche cavalcavia o anche del passaggio sui fiumi maggiori della penisola.
Dopo il rovinoso terremoto del 28 dicembre del 1908, che rase al suolo quasi interamente le due città, i piani di ricostruzione Borzì (per Messina) e De Nava (per Reggio), pur prevedendo impressionanti tassi di sviluppo urbano, non fornivano più che radissimi riferimenti all’ipotesi di un collegamento stabile tra le due sponde.
Nel secondo dopoguerra la creazione dell’intervento straordinario e la pretesa di rispondere al "sottosviluppo" ed alla "arretratezza" meridionali in termini di trasferimenti di capitali concentrati in grandi opere (dapprima le attrezzature per il primario, poi le infrastrutture, quindi i "poli di sviluppo industriale" e ancora gli "elementi di consolidamento e sviluppo delle armature urbane") rendevano quanto meno più realistico l’approssimarsi di un investimento quale quello necessario per il ponte. Che infatti trovò un primo esito nel "Progetto 80" (programma economico nazionale 1971-75): esso nelle sue "Linee di Coordinamento Territoriale", prevedeva appunto la creazione dell’Area Metropolitana dello Stretto di Messina, da realizzarsi attorno all’attraversamento stabile: una grande "Città dello Stretto". Il concetto risentiva di un approccio rilevante tra urbanisti e pianificatori che si occupavano di Mezzogiorno negli anni Settanta: dopo la delusione dei contesti agrari e delle aree interne, si individuava nella città, grande e quindi "a solida armatura urbana", la nuova pietra filosofale dello sviluppo meridionale.
L’idea di conurbazione dello Stretto con il Ponte, pur trovando qualche consenso in taluni ambienti specialistici, non fu tuttavia molto considerata negli strumenti di programmazione delle due Regioni, che invece proponevano uno sviluppo lineare, ma infraregionale, dei due centri (Messina verso Milazzo e Reggio verso Gioia Tauro e Saline). In controtendenza, però, su pressione del Psi e della destra Dc, i cui esponenti messinesi erano direttamente coinvolti nell’operazione, il governo promosse la costituzione della "Società dello Stretto Spa", con la partecipazione delle istituzioni interessate, cui spettava la redazione di "ricerche e studi atti a verificare la fattibilità di un manufatto di attraversamento stabile dello Stretto di Messina". La società, che avrebbe costituito da allora voce permanente, oltre che di quelli regionali, del bilancio dello stato e quindi delle finanziarie (con portafoglio di alcune decine di miliardi annui) promosse da subito campagne di legittimazione dell’operazione. Essa, mentre solo negli ultimi anni si è potuta avvalere del fatto che il presidente della società è anche proprietario del quotidiano che praticamente monopolizza l’informazione scritta locale, fin dalla nascita iniziò a commissionare studi a università, istituzioni tecniche, scientifiche e culturali locali e nazionali.
Anche per la contiguità con tali gruppi, infatti, gli strumenti urbanistici di Messina e Reggio, redatti in quegli anni, in totale difformità dalle linee di programmazione regionale, sposarono l’idea di città dello Stretto. Un concetto che poi sarebbe rimasto non attuato e quindi messo da parte.
Negli anni Settanta "il Ponte", sostanzialmente assente nel dibattito politico e nelle reali scelte, rimaneva argomento di riflessione e discussione tra gli specialisti. Si riuscì anche ad organizzare un concorso internazionale di idee per la scelta della soluzione tecnica, che si risolse senza vincitori, ma consolidò, attorno all’operazione, la presenza di burocrazie di ricercatori: soprattutto Iri (favorevole all’attraversamento aereo) ed Eni (favorevole al tunnel).
L’avvio degli anni Ottanta, con la crisi fiscale dello Stato e l’ormai evidente, clamoroso fallimento delle politiche di grandi interventi per il sud, sembrava dover rispedire definitivamente il ponte nel "baule dei sogni".
Invece, nella seconda metà del decennio, il rilancio di enormi programmi di opere, poi diventati la fonte permanente di distorsione gestionale e di sottrazione di risorse pubbliche ormai nota come tangentopoli, interessò anche il Progetto del Ponte, che fu infatti riproposto da apposito decreto Craxi, per il quale si riverniciarono i vecchi simboli: i richiami alla "Buda-Pest dello Stretto" (ma gli urbanisti avevano già chiarito che Reggio e Messina a differenza delle due parti della capitale ungherese, soffrivano degli stessi problemi) ed al Golden State Bridge (di cui gli studiosi di San Francisco e Berkeley sottolineano la funzione territoriale, "ma proprio perchè ultimato nel 1938, all’avvio dello sviluppo della civiltà dell’auto").
Il 31 dicembre del 1992 il progetto è stato presentato. L’alleanza tra Iri e Ferrovie ha portato la "Società dello Stretto" a privilegiare l’attraversamento aereo. I molti metri cubi di carta che compongono l’elaborato restituiscono un manufatto impressionante che viaggia tra la Sicilia e la Calabria a circa 70 mt di altezza, sorretto da torri di oltre 350 mt. Sul ponte, cui si accede tramite un enorme groviglio di svincoli e rampe, passerebbero sia i treni a bassa velocità (le pendenze di linea cominciano a salire decine di chilometri prima degli imbocchi) che le auto a velocità limitata (i tempi di percorrenza tra il centro di Reggio e il centro di Messina non si abbasserebbero).
Ma come illustriamo nel seguito, i molti volumi del progetto sono quasi tutti dedicati a dimensionamenti e verifiche degli elementi tecnico-costruttivi. Mancano o sono trattate assai genericamente le problematiche legate ai vari livelli di programmazione e politiche territoriali. Neppure nel recente "Parere" del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici viene per esempio toccato un punto che gli esperti pongono ormai da lustri: è ammissibile, alle soglie del duemila, un unico enorme "collo di bottiglia" tra la Sicilia e la Calabria, per la totalità di merci e passeggeri, quando tra l’altro la riduzione del traffico su gomma è uno dei grandi problemi, o non bisogna puntare piuttosto sulla diversificazione di modi, mezzi e vie di comunicazione tra la Sicilia e il Continente? A questo proposito non è trascurabile (oltre al consolidamento dei sistemi aeroportuali regionali) il fatto che lo stato abbia già speso oltre 40 mila miliardi in vent’anni per realizzare o ampliare nell’area i porti di Milazzo, Messina e Catania da una parte e Saline, Reggio, Villa S. Giovanni e Gioia Tauro dall’altra.
3. Il territorio e l’area dello Stretto
Il concetto di "area dello Stretto" ricevette "decisiva sanzione" normativa e programmatica nel 1965 con la redazione e l’approvazione, da parte del Cipe, del "Progetto 80", il programma economico nazionale 1971-75, con annesse linee di coordinamento territoriale. Redatto da un’equipe coordinata da Giorgio Ruffolo e Luciano Barca, esso, proponendo una funzione riformatrice/redistributiva del piano, inseriva "L’area metropolitana dello Stretto di Messina", tra le aree C3, aree terziarie di riequilibrio e riassetto territoriale.
L’idea poteva farsi risalire da una parte alla struttura informatrice del programma, tesa alle relazioni tra ambiti e nuclei "forti" del paese, dall’altra alla filosofia, che in quella fase tendeva ad affermarsi, che legava alla configurazione "a poli" lo sviluppo delle aree meridionali.
L’ipotesi era costituita dalla creazione di un’area metropolitana che, proprio per essere formata dalla conurbazione tra le aree urbane di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, poteva assumere determinati livelli di consistenza e solidità nella struttura economica, soprattutto terziaria, e nell’armatura urbana.
Un polo di questo tipo sarebbe stato infatti "altamente suscettibile all’induzione di sviluppo sociale ed ambientale, creando le economie di agglomerazione necessarie alla crescita economica di tutta l’area".
L’osservazione che venne subito avanzata rispetto allo scenario prospettato dal "Progetto 80" era quella di reggersi su presupposti che, più che da verificare, erano negati dalle fenomenologie rilevabili negli ambiti territoriali interessati.
Le relazioni, dirette e indotte, tra le due sponde erano infatti in evidente declino a fronte di quelle di esse con i propri ambiti regionali.
"La giustapposizione critica di due aree deboli che perdippiù tendevano ad ignorarsi" si presentava dunque assai problematica.
All’inizio degli anni settanta, i documenti di programmazione, di cui le due regioni si dotavano, sancivano invece la necessità di ricucire i rapporti di Messina e Reggio con gli ambiti più dinamici interni alle due regioni.
Se per la Sicilia nord-orientale ciò non era altro che la prosecuzione di linee programmatiche definite in precedenza e che affidavano al "corridoio" già citato, Milazzo-Messina-Taormina, il ruolo di "asse di ridisegno e di sviluppo economico-territoriale", per la Calabria si era di fronte alla decisiva novità del primo quadro programmatorio espresso dalla neonata istituzione regionale.
Il "programma di sviluppo economico regionale e le linee di assetto territoriale" redatto nel 1976 dalla Regione Calabria, d’intesa con la Casmez ed il Ministero per il Mezzogiorno prevedeva la riorganizzazione del territorio regionale attorno a tre macropoli legati al terziario culturale (Cosenza con la nuova università), al terziario amministrativo (Catanzaro con l’attribuzione degli uffici della Regione) ed al secondario (il Reggino con l’area industriale di Gioia Tauro).
Dell"Area dello Stretto" non c’era sostanzialmente traccia in quel programma. Va sottolineato che il quadro prospettato di una serie di terminali attrezzati per il trasferimento di capitale fisso dall’esterno e per una loro presunta utilizzazione a scala locale, anche in una logica di forte interazione interregionale, fu sostanzialmente rispettato anche nei successivi piani di adeguamento. Anche a fronte di evidenti riduzioni di prospettiva e di ambito delle azioni, che dovevano tener sempre più conto dei fallimenti delle politiche di industrializzazione e di infrastrutturazione proposte per la Calabria, come peraltro per il resto del Mezzogiorno.
La programmazione regionale calabrese, analogamente a quanto previsto da quella siciliana, ha continuato quindi a proporre visioni del territorio regionale caratterizzate da relazioni soprattutto interne, seguitando ad attribuire peso molto relativo alla "città dello Stretto". La fase più recente della pianificazione regionale, sia in Calabria che in Sicilia, segna in qualche modo una svolta rispetto a questo. Sia la proposta di piano territoriale di coordinamento regionale della Calabria che l’ipotesi di piano di sviluppo della Sicilia presentano nuove aperture verso il concetto, che sembrava definitivamente abbandonato, di area dello Stretto. Ciò peraltro non appare giustificato quale elemento decisivo nè dalle politiche regionali attuali, nè dalle scelte della pianificazione locale, tantomeno dalle tendenze in atto nei territori interessati.
Anche alla scala locale, infatti, la pianificazione esistente (invero assai poco cogente rispetto alle pratiche territoriali) sembra essere informata poco o punto dall'idea della realizzazione dell'"area dello Stretto". E' vero infatti il Prg, tuttora teoricamente vigente di Reggio Calabria a trovato quasi un ventennio addietro (1975), era incentrato sugli indirizzi del "progetto 80" ed assumeva quindi la necessità di conformare il nuovo sviluppo urbano alla conurbazione con Villa San Giovanni e Messina; va tuttavia ricordato che tale strumento è stato assolutamente non attuato se non per parti circoscritte e non rilevanti, ed è stato quindi stravolto dalle dinamiche effettivamente realizzatesi.
Recenti studi effettuati da differenti gruppi di lavoro, anche dell'Università di Reggio Calabria, anche in vista di una possibile revisione e rifacimento del Prg, sottolineano invece l'esigenza di ricuciture e di riqualificazione ambientale dell'ambito urbano di Reggio, da realizzarsi attraverso operazioni di riprogettazione ambientale interne al campo, nonchè di rilancio delle relazioni con le aree montane interne. Per quanto riguarda Villa San Giovanni gli strumenti urbanistici hanno sostanzialmente sempre confermato gli indirizzi prospettate fin dagli anni settanta da Giuseppe Samonà, tesi alla definizione delle caratteristiche morfologiche ed ambientali della struttura lineare della città, in un quadro che sottolineava più le distinzioni che gli elementi di continuum sia sulla terraferma, con Reggio Calabria, che verso il mare e quindi con l'altra sponda dello stretto.
Anche per la città di Messina, l'ultima edizione del piano urbanistico rivede decisamente i criteri definiti precedentemente, che assumevano la possibile realizzazione dell'area integrata dello stretto quale elemento caratterizzante il disegno urbano. Il piano attuale, viceversa, muove dall'esigenza di riqualificare, dall'interno, la struttura urbana e di riproporre relazioni equilibrate tra i diversi ambiti e con le attrezzature e le strutture portuali di rilievo (tra cui non è necessariamente previsto l'attraversamento).
Gli ultimi indirizzi relativi agli strumenti di pianificazione delle città dello stretto sembrano peraltro cogliere, in misura accettabile, le problematiche presentate oggi dai territori interessati.
L'obsolescenza dell'idea di area dello stretto, almeno nella sua originale formulazione di "forte conurbazione metropolitana", costituisce quindi anche una conseguenza delle dinamiche evolutive e dei nuovi temi oggi individuabili nel contesto.
Come si accennava, è diffusa nelle varie parti dell'area, la domanda di riqualificazione e di recupero ambientale. Questo sembra oggi di poter muovere da una individuazione di alcune "formazioni territoriali", produttive ed insediative, tuttora consistenti che possano favorire la riprogettazione dei diversi ambiti ritrovando però il significato di un disegno urbanistico che si incentri nuovamente sui valori e le ecologie del territorio. Questa domanda di progetto "a grana più fine" non sembra potere interessare tanto "l'area dello stretto", come ambito "assolutamente integro", quanto con modi necessariamente distinti, le relazioni tra le sue diverse parti. Anche in aree contigue le cui inferenze resteranno notevoli, per qualità e dimensioni, il senso del disegno territoriale deve dunque ricercarsi in un sistema capace di relazionare, non di negare le differenti caratteristiche dei diversi contesti.
Di recente le conclusioni della già citata ricerca nazionale Itaten, ha aggiunto ulteriori spunti critici al concetto.
Le conclusioni dello studio sottolineano che grossa parte dell'attuale degrado ambientale è rapportabile agli effetti di congestione, economica ed insediativa, registratasi nelle ultime fasi sia nell'area direttamente interessata, che nei centri più grossi delle regioni Calabria e Sicilia. Ne potrebbe conseguire che la realizzazione di una macrostruttura come il ponte tenderebbe ad esasperare tali tendenze, specie nell'intorno, con effetti affatto diversi dalla "funzione ordinatrice delle grandi opere", dichiarata dai programmi originari.
L'endemica debolezza della gestione urbanistica acuirebbe ulteriormente gli effetti "di richiamo" della macroinfrastruttura con ulteriore degrado e dissesto irreversibile del territorio.
L'accordo di programma siglato nel 1990 dai tre comuni interessati, d'intesa con le due provincie e le due regioni, parla di necessità di riequilibrio dei rapporti fra le diverse parti del territorio interessato e con l'esterno. Esso individua nell'integrazione del sistema dei trasporti uno strumento di questo, da realizzarsi però con attrezzature tali da favorire e non negare la valorizzazione del territorio e del paesaggio.
L’Area dello Stretto, in definitiva, per sfruttare le enormi potenzialità dettate dalla sua posizione nel Mediterraneo rispetto alle dinamiche previste nelle prossime fasi, deve evitare il rischio di trasformazioni in una " megalopoli del sottosviluppo", insensata, degradata e congestionata, ed invece proporre una "rete di città" fortemente interrelate ma capaci di ripresentare identità proprie ed alti valori socio-morfologici ed ecologici.
Il "Progetto di massima del ponte sullo Stretto di Messina" è stato presentato dalla Società Stretto di Messina Spa al governo il 31/12/1992, secondo quanto previsto in un decreto dell'allora presidente del consiglio Craxi nel 1988.
L'attraversamento aereo dello Stretto di Messina è indicato dall'elaborato quale soluzione tecnica migliore a garantire un collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Il progetto prevede :
a) realizzazione dell'attraversamento tramite ponte sospeso in campata unica, di sezione larga 60 metri, con corsie autostradali e ferroviarie, i cui accessi sono previsti in siti posti in aree contigue alle periferie nord degli abitati di Messina e Villa San Giovanni, sorretto dalle torri poste alle estremità;
b) collegamenti stradali all'aperto ed in galleria, per complessivi 24 chilometri sulle due contrapposte sponde dello Stretto di Messina, nonchè raccordi ferroviari, all'aperto ed in galleria, per complessivi 36,5 chilometri sui due versanti;
c) rampe di dimensioni notevoli per elevare le sedi stradali e ferroviarie del lato calabro e di quello siculo alla quota dell'impalcato del ponte pari a 64 metri sul livello del mare;
d) erezione di due torri di 376 metri e ancoraggi delle stesse con cavi di acciaio attraverso blocchi interrati;
e) opere ed attrezzature di inserimento dell'opera nell'ambiente circostante, la cui problematicità è ben rappresentata dall'altezza delle due torri che supera quelle delle emergenze orografiche dell'area interessata;
f) opere relative a fondazioni ed ancoraggi che comporterebbero rilevanti sbancamenti in aree anche intensamente antropizzate; gli ancoraggi sono infatti costituiti da blocchi in calcestruzzo che raggiungono i 291.000 mc in Sicilia e 230.000 mc in Calabria e necessitano di scavi di notevole estensione planimetrica con profondità fino a 50 metri dal piano di campagna; le torri del ponte alte 376 metri poggiano su coppie di piloni il cui diametro alla fondazione è di 55 e 48 metri, rispettivamente in Calabria e in Sicilia, con cubature complessive di 88.000 e 74.000 mc;
g) elementi di arredo, qualificazione, copertura o schermatura relativi alle rampe di accesso necessarie per raggiungere la quota di 64 metri sul livello del mare alla quale corre l'impalcato;
Nella relazione di sintesi non tecnica presentata dallo Stretto di Messina al par. 5.1.2 p.21 si legge: "nell'ambito delle opere ferroviarie previste sul versante calabrese, riveste un ruolo importante la variante propedeutica di Cannitello della linea storica che si rende necessaria per la realizzazione delle fondazioni della torre del ponte"; nonchè al collegamento previsto sul versante Sicilia di 15,7 chilometri, quasi tutto in galleria naturale.
La descrizione degli elementi principali del progetto prefigura effetti pesantissimi di impatto ambientale.
In questa parte si avanza una lettura sintetica del sistema degli impatti tratti dalle "Osservazioni al Sia del progetto di attraversamento aereo dello Stretto di Messina", redatte da strutture tecnico-scientifiche di Legambiente ed altre associazioni ambientaliste. (Si rimanda allo stesso studio, per una trattazione più approfondita).
Prima di passare all'osservazione di alcuni dei maggiori elementi di impatto individuati ed esaminati dallo studio, è utile sottolineare le rilevanti carenze di tipo metodologico inerenti l'organizzazione dello studio stesso. "In particolare, nonostante gli ingenti finanziamenti pubblici investiti nell'elaborazione del progetto di massima e del Sia, si rilevano i seguenti elementi critici nella strutturazione del Sia:
a) la mancata distinzione tra le diverse scale d'impatto;
b) il coordinamento carente tra le diverse tematiche affrontate;
c) l'uso di metodi inadeguati per l'analisi e per approfondire e valutare gli effetti ambientali;
d) la lettura degli effetti, realizzata soltanto per gli elementi principali del tracciato;
e) la sottovalutazione degli ecosistemi di pregio presenti nello Stretto e di conseguenza dell'intero ambito;
f) la scarsissima valutazione degli effetti indotti dal sistema di attraversamento aereo e di alcuni effetti pure rilevanti;
g) la sottovalutazione degli impatti legati alla sicurezza e alla dismissione;
h) la sottovalutazione degli impatti del cantiere (in tutto 9 cantieri stradali e 5 ferroviari);
i) la mancata valutazione di tutte le alternative e la scorretta metodologia di comparazione di quelle considerate".
Ancora va considerata la sostanziale assenza di adeguati scenari di riferimento economico-territoriali, tali da fornire un quadro logico per la valutazione di compatibilità del progetto. Per quanto riguarda il merito degli effetti di impatto, va notato che tra le priorità vi sono le trasformazioni paesaggistiche e percettive dello Stretto di Messina , un ambiente la cui unicità è nota a scala mondiale.
Il ponte "renderebbe esplicito, ciò che 'appare', ma viene nello stesso tempo 'negato' dalla frattura e dalla distanza.
Questo è forse il tema emozionalmente più forte dell'ambito paesaggistico in questione: la 'tensione' continua tra le due sponde, l'estrema vicinanza, il guardarsi continuo senza toccarsi, senza cioè realizzare l'oggetto della 'tensione'.
"C'è un riferimento alto nella storia dell'arte che forse può spiegare meglio delle parole questa visione emozionale, la creazione di Adamo di Michelangelo nella Volta della Cappella Sistina: il 'dito della paterna destra' (come canta l'inno sacro, si avvicina a quello del primo uomo, ma non lo tocca e l'Anima, immateriale scintilla, passa nel Corpo di Adamo). Rompere questa 'tensione', annullandola con il collegamento del ponte, stravolgerebbe la percezione attuale dello Stretto".
"L'impatto paesaggistico va proiettato almeno su quattro piani:
a) la modificazione della scena dell'insieme dello Stretto;
b) la trasformazione della geografia e della orografia dei luoghi;
c) la modificazione del paesaggio dei versanti;
d) la nuova percezione dello Stretto e l'impatto soggettivo (emotivo e psicologico) e collettivo (socio-culturale) sulle popolazioni interessate".
In particolare "per quanto riguarda la scena dell'intero ambiente dello Stretto, appare più appropriato parlare di trasformazione che di modificazione. L'effetto dell'attraversamento aereo, caratterizzato all'attacco delle due sponde da un sistema di torri dall'altezza di 376 mt, appoggiate su coppie di pilastri il cui diametro alla fondazione è di 55 e 48 metri, rispettivamente in Calabria e in Sicilia nonchè dei collegamenti ai massicci blocchi di ancoraggio, di 291.000 mc in Sicilia e di 230.000 in Calabria e ancora colossali rampe di accesso, in aggiunta agli elementi dell'attraversamento aereo vero e proprio (ingombro longitudinale della struttura sospesa a campata unica, della lunghezza di 3.300 con impalcato corrente, stradale e ferroviario, della larghezza di 60 metri) è quello del ridisegno radicale dello scenario che assume adesso più i contorni della Baia che quelli dello Stretto. L'ingombro prospettico del sistema torri-reticolare-impalcato interessa una superficie verticale di oltre un milione di metri quadrati (circa il triplo dell'area del "quadro ideale" formato oggi dalla linea superficiale del mare, le massime alture sulle due sponde e l'orizzontale immaginaria tangente alle altezze massime) e disegna una sorta di macroparatia verticale che restituisce l'effetto di rottura della continuità del paesaggio, in cui sarebbero distinguibili, a causa del manufatto, un ambito sud ed un ambito nord. Altri elementi del sistema degli impatti principali, sottovalutati o non considerati dal Sia redatto dal proponente, riguardano:
- gli aspetti idrogeologici e la circolazione idrica sotterranea ("manca uno studio più approfondito della situazione strutturale e idrogeologica delle aree interessate") che investe anche l’area dei laghetti di Ganzirri;
- l'incidenza delle attrezzature di suolo sull'ambiente marino;
- l'estrazione di inerti e la posa dei rifiuti: si calcola che per la realizzazione del ponte occorreranno alcuni milioni di metri cubi di inerte e centinaia di migliaia di metri cubi di acciaio: si è individuata l'area del prelievo nella zona etnea, ma non vi è alcuna analisi di impatto dei siti;
- gli aspetti biologici costieri e marini: "la perenne cantierizzazione di rilevanti tratti di costa sicula e calabra prevederebbe inoltre la sottrazione alla fruizione paesistica di una serie di habitat unici nel mediterraneo", senza contare la distruzione/cancellazione di numerosissimi biotopi;
- gli aspetti direttamente naturalistici: "i due versanti rappresentano infatti due realtà biologiche ben distinte con alcune parziali sovrapposizioni. Ciò è vero soprattutto dal punto di vista faunistico. Tale porzione della costa calabrese ed in generale l'intera provincia di Reggio Calabria...rappresenta il "fondo cieco" della lunga catena appeninica e parallelamente il "collettore" naturale utilizzato per spostamenti migratori da centinaia di specie di uccelli. Tale situazione determina una intrinseca fragilità degli ecosistemi terrestri della estrema punta della punta della penisola italiana, sia per il realizzarsi di condizioni dettate da un accentuato "effetto penisola", sia per il ruolo e la funzione che in due periodi dell'anno, primavera ed autunno, esso si trova a svolgere. Sul versante siciliano è esistente, di contro, una situazione biologica in cui l'insularità, con la presenza di alcuni interessantissimi endemismi, e le caratteristiche generali più spiccatamente mediterranee, sono l'aspetto più peculiare, ma anche più delicato".
A fronte di questi specifici fattori si è rilevata un incompleto inquadramento biogeografico dell'area, con uso di metodologie di indagine inconsistenti, e ancora la mancanza di un'analisi puntuale sulle specie vegetali e faunistiche presenti e dei parametri evolutivi in presenza di una macroalterazione quale il ponte.
Rispetto alla vastità e alla gravità degli impatti talune misure di mitigazione proposte risultano infine di irrisoria inconsistenza.
E’ da notare infine come la società "Ponte sullo Stretto" s.p.a. abbia ritirato il SIA originario, a suo tempo depositato presso l’Ufficio VIA del Ministero dell’Ambiente, riservandosi di produrre un elaborato "migliorato"; riferito però sempre allo stesso progetto.
6. Le critiche degli urbanisti
Il recente parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non ha risolto -ed in alcuni casi nemmeno sfiorato- le questioni ricordate nelle pagine precedenti; fornendo peraltro le medesime non risposte già contenute nel progetto e nel Sia del proponente, seppure pedantemente arricchite da motivazioni riguardanti ambiente, urbanistica e sviluppo economico che vanno oltre la "vuota retorica" e travalicano spesso nel puro ridicolo: per esempio la pretesa del prof. Brown, esimio costruttore di infrastrutture, che si improvvisa pianificatore e ribalta la logica che lega domande territoriali e attrezzature, sostenendo che "tutti i piani urbanistici dell'area vanno riformulati in rapporto al progetto del Ponte "così cancellando la complessità di problemi per cui un piano è pensato e trovando pure eco, quanto meno incauta, in qualche amministratore locale.
Gli ingenti investimenti sostenuti, i progetti più o meno assemblati, i pareri costruiti nel tempo non rispondono ad una domanda elementare: perchè si dovrebbe realizzare un'opera con tali ingenti implicazioni? L'unica risposta in grado di cogliersi nella monumentale documentazione del ponte è giocata sul piano dell'organizzazione dei trasporti e ribadisce quanto si è sempre detto nell'ambito dei collegamenti stradali e ferroviari, non tenendo peraltro conto che, dal tempo delle prime proposte ad oggi, si sono realizzati o ampliati nelle regioni interessate sette aeroporti ed una decina di porti e soprattutto che, date le tecnologie attuali e quelle prossime future, l'acqua e l'aria, come la terra, diventano infrastrutture di trasporto: quelli che un tempo erano elementi razionalizzatori ed ottimizzatori di un sistema di trasporto possono allora diventare nel prossimo futuro pericolosi elementi di congestione, pesanti colli di bottiglia. In questo senso vanno analizzate le nuove forme di trasporto in relazione alle prossime tipologie infrastrutturali.
Gli unici elementi di qualche valenza - nel progetto, come nel parere - riguardano la costruibilità: ciò non sorprende guardando alla composizione dei team che hanno elaborato e "valutato" la documentazione, con dominanza quasi assoluta di tecnici delle costruzioni e delle infrastrutture. Ciò che sorprende è lo snaturamento della funzione istituzionale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che nel caso del parere al progetto del ponte doveva verificare gli aspetti tecnici, economici, ambientali e territoriali ed invece - come qualsiasi tecnico o studioso pure disattento può cogliere- ha prodotto un documento giustificativo, teso a legittimare l'operazione.
In un documento diffuso di recente un gruppo di Urbanisti e Territorialisti, in gran parte aderenti ai coordinamenti di ricerca CNR e MURST diretti da Alberto Magnaghi, ha chiesto che si cancelli definitivamente il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera di devastante impatto ambientale, inutile per l’assetto del sud e poco sensata rispetto alle dinamiche economiche e territoriali in atto.
"Il dibattito sviluppatosi nei mesi scorsi ha infatti messo in luce i grandi rischi e gli scarsissimi vantaggi dell’operazione, al di là degli stessi dubbi sulla sua realizzabilità, legati alla sismicità, al costo eccessivo ed alla fragilità delle ipotesi di autofinanziamento.
Perché si dovrebbe costruire un’opera con tali pesantissime implicazioni sull’ambiente? Le argomentazioni sono tutte contrarie al progetto.
Dal punto di vista urbanistico la conurbazione forte di Reggio e Messina attorno a un’attrezzatura così pesante renderebbe insostenibili i livelli di congestione già in atto nell’Area, che tenderebbe a configurarsi come una megalopoli da Quarto Mondo. Laddove l’area dello Stretto può diventare un grande esempio di "città di città", costruita attorno a relazioni attente e intelligenti, ciascuna delle quali deve però ritrovare una propria identità socio-morfologica ed ecologica, in funzione locale e rispetto ai grandi ambiti mediterraneo e continentale.
L’evoluzione della pianificazione territoriale ha evidenziato chiaramente i limiti degli approcci legati alle ‘funzioni ordinatrici e di indirizzo delle grandi opere’: le infrastrutture devono servire l’assetto e lo sviluppo, non determinarlo. Come si fa allora a proporre nel 2000 un modello di sviluppo basato su una grande attrezzatura infrastrutturale, fra l’altro in un Mezzogiorno piagato dagli storici fallimenti dei ‘poli di sviluppo’, industriali e infrastrutturali? E ancora, dal punto di vista occupazionale, cosa succederà quando i cantieri, che pure forniscono lavoro temporaneo per alcune migliaia di persone, chiuderanno? Il Sud è pieno di bacini di crisi da disoccupazione di ritorno. Con la pesante aggravante che, a regime, l’opera renderebbe superflui almeno i 2/3 degli attuali addetti ai traghettamenti.
Per quanto riguarda l’economia della realizzazione va ricordata l’analisi costi-benifici recentemente conclusa da esperti del Ministero dei Lavori Pubblici, che, pur assumendo parametri prudenziali, con basso peso delle variabili ambientali e territoriali e ipotesi alte di flussi di traffico, è risultata nettamente negativa per l’opera. (A. Magnaghi et al., 1998).
Il documento prosegue ricordando il "devastante" impatto ambientale e l’obsolescenza di un sistema di trasporti, legato esclusivamente al ponte a fronte del sistema integrato portuale realizzabile nell’area dello Stretto.
In conclusione sottolinea che "A fronte di tali critiche, i sostenitori del progetto si aggrappano ormai a posizioni fantasiose, talora esilaranti, abbandonando ogni senso del ridicolo. Si invocano infatti i grandi scenari di trasporto intercontinentale, proponendo però la singolare soluzione basata sulla contiguità terrestre e sulla continuità fisica tra Sicilia e Calabria prevista dal progetto (secondo il sottosegretario Pino Soriero, per esempio, per andare da Stoccolma a Tunisi o da Marsiglia ad Algeri... sarebbe utile il ponte sullo Stretto! Forse pensa ad una "campata unica" tra la Sicilia e la Tunisia). Nel prossimo futuro serviranno invece opzioni corrette per le relazioni di mobilità alla grande scala, necessariamente legate ad intermodalità, rottura di carico ed uso dei vettori marittimi ed aerei o semplicemente spostamenti virtuali di merci immateriali come informazioni, finanze, conoscenza.
Ancora si riconosce l’insignificanza di ipotesi di sviluppo territoriale-infrastrutturale legate all’opera, ma la si invoca ugualmente come richiamo turistico.
Il Ponte sullo Stretto è opera poco sensata, come le residue motivazioni che pretendono di avallarlo: il progetto è a sua volta residuo di una concezione quantitativa ed illimitata dello sviluppo e di onnipotenza tecnologica che ha già rivelato devastanti risvolti di esiziale aporia: laddove lo Stretto di Messina è invece un mirabile esempio di potenza del limite, che può trovare proprio nell’identità ecologica e paesaggistica i motivi di un nuovo sviluppo umano" (Idem).
7. Riferimenti bibliografici e documentali
a) Documenti
- Stretto di Messina spa, 1986, "Rapporto di fattibilità" (vol.3 Fenomeni economici ed analisi costi benefici - vol.9 Impatto sul territorio e gli ecosistemi), Messina
- Ferrovie dello Stato spa, 1987, (a cura di Giulio Vinci), "Attraversamento stabile viario e ferroviario dello Stretto di Messina", Roma
- Ponte di Archimede spa, 1984, "Il ponte di Archimede nello Stretto di Messina", (Progetto, fattibilità, traffico), Roma
- SOMEA - Stretto di Messina spa, 1982, "Analisi costi benefici relativi alla realizzazione di un collegamento stabile tra Sicilia e Continente", Messina
- Tecnomare, 1986, "Proposal for a permanent underwater strait connection based on offshore technologies. Strait of Messina", Roma
- Eni (Consorzio per lo Stretto di Messina), 1992, "Attraversamento in alveo dello Stretto di Messina. Progetto di massima". Roma
- Camera dei Deputati - Senato della repubblica, Documenti X Legislatura Seduta del 20/1/1993, Considerazioni sulla fattibilità delle opere di attraversamento (dello Stretto di Messina), Roma
- Stretto di Messina spa, 1992, "Studio di compatibilità ambientale, parte terza: Relazione di sintesi non tecnica del progetto del Ponte", Roma
- Stretto di Messina spa, 1992, "Attraversamento stabile dello Stretto di Messina Progetto di massima", Roma
- Stretto di Messina spa, 1991, Analisi della configurazione attuale e futura della rete plurimodale nel comprensorio dello Stretto di Messina.
- Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici, 1997, "Parere di Compatibilità del progetto di Attraversamento Aereo dello Stretto di Messina", Roma, ottobre
- Legambiente ed altri, 1993, "Osservazioni al SIA del Progetto di Massima del Ponte sullo Stretto", (Gruppo di Lavoro coordinato da Maria Berrini, Lidia Liotta, Alberto Ziparo), Roma
- Legambiente Reggio Calabria, 1997, "Uno sguardo sul Ponte", Reggio Calabria.
- A. Magnaghi et al., 1998, Documento di Urbanisti e Territorialisti sulla questione del Ponte sullo Stretto, Firenze
b) Bibliografia
- M. Alberti,G.Solera, V. Tsetsi, 1994, "La Città Sostenibile", Franco Angeli, Milano
- V. Bettini, 1990, "L'analisi ambientale", CLUP, Milano
- A. Bianchi e M. Vendittelli, 1982, "L'attraversamento dello Stretto", Casa del Libro, Reggio Calabria
- M. Bresso, 1988, "L'economista e gli indicatori ambientali: dalle valutazioni monetarie alle VIA". in "Gli indicatori ambientali: valori metri e strumenti nello studio dell'impatto ambientale", Franco Angeli, Milano
- G. Campione, 1988, Il progetto urbano di Messina, Gangemi, Roma
- A. Clementi, G. Deematteis, P.C. Palermo, 1996, (a cura), Le forme del territorio italiano, Laterza, Bari
- G. Di Cilio, D. Manio, G. Miceli, G. Minniti, 1990, "L'attraversamento dello stretto, problemi e prospettive", Editoriale Mac Aiello, Napoli
- D. Hellmann, G. Schachter, A. Sum, A. Ziparo, C. Zoppi, 1997, "The impact of Mega - infrastructure Projects on urban Development: Boston and The Messina Strait", in European Planning Studies, n.5
- A. Risi, 1995, "Impact evaluation of different technical proposals for a fixed link between Sicily and italian mainland", NUEWP, Boston
- Carlo Secchi, 1992, "Metodologie di valutazione dell’impatto turistico di un attraversamento stabile dello Stretto ", (mimeo) Università di Pavia
- Carlo Secchi, 1997, "Elementi per un’analisi degli effetti economici di un attraversamento stabile dello Stretto di Messina", (mimeo) Università di Pavia
- A. Ziparo, 1994, "Ascesa e declino della città del Ponte" in Urbanistica Informazioni