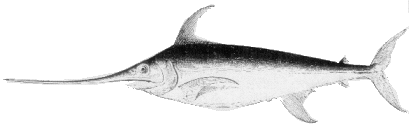
APPELLO ALL'UNESCO*
PER LA PROTEZIONE
DELLO STRETTO DI MESSINA
QUALE PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
DELL’UMANITA’
*UNESCO. INTERGOVERNAMENTAL COMMITEE FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE.
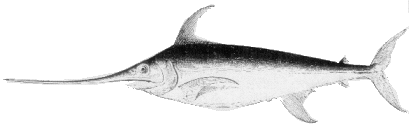
Da molti anni l'UNESCO esercita su oltre 500 luoghi della Terra particolarmente significativi, per la vita del genere umano e per la sua storia culturale, una protezione in nome della umanità intera. Sono luoghi definiti patrimonio dell'umanità ed in nome di questa e delle popolazioni locali, che in essi vivono e si adoperano per custodirli , alle Nazioni Unite viene affidato il compito di salvaguardarne l'integrità e l'esistenza per le generazioni future e di garantirne l'equilibrata fruibilità per quelle attuali.
Molti di questi luoghi insistono nel Mare Mediterraneo ed in particolare lungo le coste o all'interno della Penisola italiana. Essi sono segnati da tracce umane ed artistiche di epoche diverse o mantengono da millenni inalterata la loro fisionomia naturale. Nei confronti di trasformazioni irreversibili messe in atto dall'azione delle società moderne, che talvolta cancellano memoria, storia e paesaggi, e di fronte ai rischi di distruzione delle stesse basi ecologiche e culturali del genere umano, che progetti di sviluppo non controllati da adeguate valutazioni di impatto mettono in campo, la protezione dell'UNESCO può rivelarsi un valido sostegno a quanti - in sede locale o in qualsiasi altra parte del mondo - si oppongono a siffatte azioni. La tutela dell’UNESCO, inoltre, mette in campo risorse, umane, scientifiche e finanziarie, per il mantenimento, il restauro, la protezione e la valorizzazione dei siti iscritti nella lista del "world cultural and natural heritage".
Tra Scilla e Cariddi.
L’origine dello Stretto di Messina può farsi ascendere a circa 2 milioni di anni fa, come conseguenza dell’abbassamento dell’Isola di Sicilia, il suo distacco dalla Penisola e l’innalzamento dell’arco calabro.
Lo Stretto di Messina ha la forma di un imbuto, con imbocco dal lato dello Jonio e l’altra estremità sul Tirreno, largo 16 km. tra capo d’Alì e la punta di Pellaro in Calabria e circa 3 km. fra capo Peloro in Sicilia e Torre Cavallo sul lato opposto. Tra punta Pezzo e Ganzirri la profondità è di 72 m., mentre il fondale raggiunge i 1000 metri nelle acque di Milazzo e supera i 2000 m. nell’area antistante Acireale.
Gli aspetti naturali dello Stretto di Messina, il paesaggio emergente, i fondali marini, la popolazione faunistica e l’ecosistema nel suo complesso ne fanno un luogo unico nel Mediterraneo. Le particolarità morfologiche tipiche ed esclusive di questi fondali – ad esempio – favoriscono lo sviluppo e la riproduzione di alcuni organismi, o di alcune loro caratteristiche bio-morfologiche, che risultano del tutto assenti in altre aree del Mediterraneo. Uno dei principali fattori che ha contribuito alla creazione ed allo sviluppo del particolare ecosistema dello Stretto è la presenza di forti correnti che pervadono periodicamente, con velocità e direzioni diverse, le acque. Questo sistema è conosciuto fin dall’antichità e su di esso è stata costruita notevole parte della mitologia e della cultura Mediterranea. Omero, nell’Odissea, descrive Cariddi, figlia di Poseidone e della Terra, come mostro annidato sopra una rupe nel mare di Sicilia. La leggenda la rappresenta come una crudele rapinatrice che si gettava, furibonda, sopra i naviganti per derubarli di ogni avere. Di fronte a Cariddi era Scilla, altra figura leggendaria e mostruosa, sull’omonima rupe Calabrese. Chi fosse riuscito a sfuggire a Cariddi, avrebbe trovato di fronte a sé Scilla, che ingoia nella sua bocca tremenda uomini e navi. Di Cariddi si narra che tre volte al giorno inghiottisse l’acqua del mare e tre volte la rigettasse. Ebbene questa leggenda altro non è che la descrizione del movimento ciclico delle correnti dello Stretto di Messina. Circa ogni sei ore la corrente inverte la propria direzione intervallando il continuo movimento con pause chiamate "stanche". La presenza di queste correnti – montanti o scendenti - è dovuta a diversi fattori, tra cui la differenza di temperatura tra le acque del Mar Tirreno e quelle dello Jonio che nello Stretto si vengono a mescolare, la differenza di batimetria tra i due fondali, il differente grado di salinità dei due mari. Per merito di tale peculiarità nelle acque dello Stretto di Messina si è creato e continua a svilupparsi un ambiente marino unico e particolare. Organismi marini, come specie particolari di Gorgonie (Paramuricea clavata), organismi parassiti come il "falso corallo nero" (Gerardia Savaglia), organismi vegetali come la Caulerpa e le Posidonie, pesci come lo Zeus Faber (comunemente detto Pesce San Pietro, simbolo di queste acque), il pesce spada ed altri ancora trovano albergo unico nelle acque molto limpide dello Stretto, che grazie alle correnti risultano prive di sedimento che riduca la penetrazione della luce, in modo che i raggi solari possano irradiarsi sino ai 30 metri. Attraversano lo Stretto anche diverse specie di cetacei che, stagionalmente, migrano verso la sponda nord del Tirreno.
 |
 |
 |
Il cielo dello Stretto di Messina rappresenta a sua volta un altro particolare sistema aereo: una sorta di "collo di bottiglia" in cui tutti gli uccelli migratori si concentrano per raggiungere la Penisola e continuare il lungo volo verso nord. Sono più di venti le specie di grandi uccelli che utilizzano questa via migratoria. Tra questi figurano gli uccelli veleggiatori (grandi rapaci e cicogne) che sfruttano le correnti ascensionali che permettono loro il volo, non potendo altrimenti attraversare lunghi tratti di mare. Il più noto e comune è il Falco Pecchiaiolo, che fra aprile e maggio attraversa lo Stretto e di cui si contano tra 10 e 15.000 individui, ma si possono osservare anche specie piuttosto rare come Capovaccio, Pellegrino, Aquila reale, Cicogna bianca e Cicogna nera, per un numero totale di uccelli che può raggiungere i trentamila individui, gran parte dei quali specie protetta. Lo Stretto di Messina è quindi uno dei punti più importanti a livello europeo per la migrazione dei rapaci.
Vi è poi un altro fenomeno, del tutto particolare, che per quanto sempre più raro a causa dell’inquinamento atmosferico è di tanto in tanto ancora visibile quando la temperatura è elevata in presenza di aria afosa, umida. E’ l’effetto ottico chiamato "Fata Morgana", per il quale le rive montuose appaiono sollevate dal mare e le coste, deformate, sono trasformate in fantastiche immagini sul cielo.
Il paesaggio e l’ecosistema dello Stretto di Messina mostrano come natura e cultura possano trovare una relazione non oppositiva. Dalle antiche leggende, ai miti, alla letteratura ed alla poesia recenti questa area ha assunto un significato che permea la cultura e va ben oltre le espressioni locali. Dello Stretto offrono accurate descrizioni – oltre ad Omero – Aristotele, che le accompagna con considerazioni scientifiche e filosofiche, Virgilio (si veda il II Canto dell’Eneide), Lucrezio, Ovidio, Sallustio e Seneca. Dante utilizza la metafora di Cariddi nel canto VII dell’Inferno. Galileo Galilei dedica a Scilla e Cariddi un’ampia parte della "giornata quarta" – sugli effetti dell’acqua e dell’aria - del "Dialogo sopra i due Massimi Sistemi". A quest’area è legata una memorialistica letteraria e scientifica europea che annovera – tra gli altri – i notissimi contributi di Goethe. In ogni caso si tratta di una cultura del rispetto della potenza della natura e della coscienza del limite, i cui richiami risultano particolarmente urgenti nell’epoca attuale. Si tratta di una cultura della bellezza e della ambivalenza. Certamente in essa, e soprattutto nei luoghi che ne rappresentano la "base biologica", convivono elementi contraddittori ed aporie, che vanno riflessivamente recuperati e costituiscono un valore. Lo iato tra la Sicilia e la Calabria continentale, a sua volta, sembra costituire fattore di tensione vitale non soltanto tra mari diversi, ma tra culture e società mediterranee ed europee: il tratto di mare e le correnti mantengono la distanza ed è appunto questa distanza lo spazio dell’incontro tra differenze. Forse – com’è stato ricordato – soltanto l’immagine della Creazione di Adamo, dipinta da Michelangelo, in cui le due dita dell’uomo e del dio si protendono l’un l’altra senza tuttavia toccarsi e tra le quali passa la tensione vitale, può rappresentare la relazione tra ecosistema naturale, identità culturali e società.
L’area dello Stretto di Messina è altresì nota perché ad un livello geologicamente più profondo si confrontano placca egea e placca adriatica, in zona di subduzione ed attività vulcanica. Il territorio è insomma zona sismica ad alto grado di pericolosità e le catastrofi sismiche hanno sconvolto e distrutto a più riprese tanto Messina quanto Reggio di Calabria. Ogni volta i due insediamenti ed i paesi circostanti sono stati ricostruiti. Le popolazioni superstiti alle decimazioni non hanno abbandonato i luoghi. Anche in questi eventi, nel rapporto tra disastro naturale e vita sociale, troviamo tratti di una cultura antica ed al contempo attualissima: la cultura della convivenza con il terremoto, che un tempo è stata – e potrebbe tornare ad essere – cultura della prevenzione e della non rimozione del rischio, dell’imprevisto, del caotico.
L’interesse scientifico che riveste l’ecosistema dello Stretto è altissimo, da molteplici punti di vista, ed impegna costantemente ricercatori, biologi, fisici, naturalisti. Sulle rive dello Stretto, nel 1883, il biologo russo E. Metchnicoff, Nobel 1908 per la medicina, svolge i suoi studi sulle stelle marine e scopre il meccanismo della "fagocitosi" da cui prenderanno il via tutte quelle ricerche che condurranno alla moderna concezione dei complessi meccanismi alla base delle difese immunitarie. Lo Stretto è stato definito "paradiso degli zoologi". Le sue profondità sono state esplorate per la prima volta da Jacques Piccard nel maggio del 1979, producendo risultati conoscitivi che non solo hanno risolto quesiti sulla vita dello Stretto, ma hanno offerto input per affrontare problemi di biologia marina e di idrobiologia in generale.
Da un punto di vista umanistico la natura e la storia di questo sito offrono richiami e suggestioni di natura non soltanto estetica, ma marcatamente epistemologica.
Riteniamo che l'area dello Stretto di Messina - che può dunque essere annoverata a pieno titolo tra i luoghi patrimonio dell'umanità - sia oggi in serio pericolo.
Questa minaccia è rappresentata dal progetto di costruzione di una megastruttura, il Ponte sullo Stretto, che non soltanto sfigurerebbe la fisionomia dell’area, ma trasformerebbe irreversibilmente l’ecosistema.
Chiediamo pertanto che l'intera area, delimitata dai comuni costieri delle Provincie di Reggio Calabria e di Messina che si affacciano sullo Stretto, sia posta sotto la protezione dell'UNESCO.
Il progetto di costruzione del Ponte tra Scilla e Cariddi, qualora si realizzasse, rappresenterebbe la cancellazione fisica dell'ecosistema dello Stretto, già attualmente fortemente compromesso. E, si badi bene, in tal caso non si tratterebbe soltanto di un irreversibile danno ambientale, ma della cancellazione delle basi biologiche e fisiche di un patrimonio culturale antichissimo. Un patrimonio che senza alcun dubbio è componente di rilievo dei "mondi vitali" delle popolazioni mediterranee e contiene tradizioni, linguaggi, simboli e risorse di identità.
Da questo ambiente ha tratto ispirazione, sin dall'epoca omerica, la cultura del Mediterraneo e del mondo intero. La letteratura, il teatro, la poesia, le arti figurative e gli stessi sapere e linguaggio quotidiani. Lo Stretto di Messina è uno di quei luoghi dove la storia resta visibile nella vita di tutti i giorni.
L'espressione "tra Scilla e Cariddi" è luogo comune per molte lingue ed esprime, attraverso il mondo, un medesimo significato. Luogo comune, in questo caso, non sta ad indicare semplicemente un modo di dire, un pregiudizio, una verità probabilmente falsa e non sottoposta a critica riflessiva. Luogo comune è in questo caso ciò che etimologicamente l'espressione indica: un luogo in cui la comunità umana riconosce se stessa, il suo alto riferimento identitario e culturale, la relazione tra storia e natura.
Nella espressione "tra Scilla e Cariddi" è sintetizzato un sapere ancestrale ed attualissimo che indica nel medesimo tempo la drammaticità del dubbio ed il suo valore positivo, la relatività e l'ambivalenza, la saggezza del riconoscimento del limite. Un famoso brano di Theodor W. Adorno riprende la figura di Ulisse fra Scilla e Cariddi per affrontare l’intreccio di mito ed illuminismo, il reciproco ribaltarsi dei termini l’uno nell’altro, che fonda il processo di civilizzazione, i caratteri, le aspirazioni, i desideri e le rinunce, le contraddizioni e barbarie dell’individuo moderno. Il recente lavoro di Massimo Cacciari sul senso dell’Europa (L’Arcipelago, 1997) riconosce nel mare il luogo della relazione, del dialogo, del confronto tra le molteplici isole che lo abitano, tutte dal mare distinte e tutte dal mare intrecciate, nutrite ed "arrischiate". Ed anche qui, con la metafora dell’arcipelago torna il mito di Scilla e Cariddi. Non c’è cammino nell’arcipelago senza Scilla e Cariddi (in altri termini l’arcipelago europeo esiste in forza di tale duplice pericolo) e questa idea non è quella di un ritorno alle origini, ma piuttosto e continuamente di un "nuovo inizio".
Il progetto del Ponte di Messina non è antico come questa cultura, ma trova tracce nella storia del Mezzogiorno d'Italia sin delle sue ripetute invasioni, dall'epoca di Carlo Magno, fino alla unificazione d'Italia ed alla più recente assemblea Costituente. Ogni volta alla ribalta sono saliti personaggi che in nome di un malinteso senso del progresso si proposero di sfidare l'antico fato omerico, disposti ad affrontare - senza cera alle orecchie e senza legature all'albero, qui ancora usando la metafora greca - il canto delle Sirene. Ogni volta limiti tecnici, eventi sismici, giustificati timori e moderazione nella valutazione, sobrietà e realismo, fecero sì che non si procedesse nemmeno ad una vera progettazione. La saggezza prevalse sulla hybris e la retorica incosciente e demagogica. E tuttavia va riconosciuta la radicata aspirazione delle élite culturali e di larga parte della popolazione siciliana ad un collegamento stabile tra l’Isola, il Continente e l’Europa: il contenuto simbolico, ben più che pratico, di questa aspirazione tende a ribaltare non tanto l’insularità della cultura e della società siciliana, quanto piuttosto la immagine di una condizione di marginalità e di esclusione. Questo simbolismo esprime una forte aspirazione europea ed al contempo insulare dei siciliani, il rifiuto giusto che quest’isola sia considerata "la palla al piede" del continente. La volontà di contare. E tuttavia l’idea di un ponte che attraversasse lo Stretto con strade carrozzabili ha preso moderna consistenza in una fase del processo di industrializzazione, caratterizzata dallo sviluppo della motorizzazione, che oggi si avvia alla sua tarda maturità e che mostra pienamente contraddizioni, promesse non mantenute ed effetti perversi. Anche da un punto di vista simbolico l’idea del Ponte - metaforicamente coinvolgente, ma concretamente legata ad una mentalità tardo-industriale – finisce per essere obsoleta di fronte alle nuove possibilità tecnico-scientifiche della comunicazione e della circolazione ed al riemergere del valore culturale dell’ambiente e della identità locale non integralista, come risorse propulsive, fonti di crescita umana, di sviluppo e di relazione.
Nonostante ciò, oggi – a differenza dei decenni trascorsi - ci troviamo di fronte ad un progetto, già in parte formalizzato, che attende dalle istituzioni nazionali e dal Governo l'autorizzazione per lo studio esecutivo.
Nel 1981 venne istituita la Società "Stretto di Messina" - Spa concessionaria pubblica dell’Iri, con partecipazioni di Anas, FFSS, Regioni Sicilia e Calabria - cui fu affidato il compito di progettare un collegamento stradale e ferroviario tra la Calabria e la Sicilia. Sul finire del 1997 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici approvò il progetto di massima, accompagnandolo tuttavia con una serie di perplessità e sostanziali richieste di informazioni e studi supplementari che riguardano aspetti geofisici, geotecnici, sismici ed anche economici. Ferrovie dello Stato ed Anas espressero invece perplessità più sostanziali valutando il progetto incompleto e quindi non suscettibile di valutazione. L’Anas inoltre sottolineò come l’autostrada Salerno-Reggio Calabria – che condurrebbe da Nord al Ponte – non soltanto si riveli inadatta a subire ulteriori incrementi di carico, che in ogni caso si riflettono sulla velocità di percorrenza, ma come sia sostanzialmente immodificabile per almeno 180 km. costituiti da gallerie e ponti, che ne impediscono l’allargamento.
Nonostante ciò il progetto venne presentato pubblicamente come definitivo e ne seguirono numerose interrogazioni parlamentari, prese di posizione, pressioni per una approvazione definitiva. Attualmente il progetto di massima è stato rinviato dal Governo – dopo ampio dibattito in Senato – all’esame del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), che dovrà esprimere una valutazione entro, presumibilmente, il luglio del 1999.
Altrettanto numerose, anche se meno sostenute dai mezzi di informazione, sono state le prese di posizione contrarie a questo progetto. Dal mondo politico, all'associazionismo - in particolare ambientalista e non profit - fino al mondo accademico, le opposizioni al progetto del Ponte di Messina hanno puntato l'accento su molteplici questioni, tra loro interrelate, che ne giustificano una definitiva cancellazione.
L'eventuale realizzazione del Ponte si rivela, oltre che dannosa, inutile e pericolosa.
Rimandiamo ai molti documenti prodotti da associazioni culturali, ambientaliste e da studiosi per una più puntuale disamina di queste ragioni. Ci limitiamo qui a richiamare i principali argomenti:

Questa immagine virtuale del Ponte, diffusa dalla "Società Stretto di Messina Spa", in realtà non rende conto della sfacciata imponenza dell’opera (escludendo il paesaggio circostante, di molto sovrastato dalle torri di 360 metri) e dell’impatto sull’ecosistema marino ed aereo dello Stretto. La simulazione fotografica offre una immagine "trasparente" del Ponte, quando invece il coacervo di funi che sostengono la campata è molto più denso e costituisce una vera e propria paratia – una sorta di porta sciancrata – al centro dello Stretto, dividendolo in due aree separate.
Il modello di sviluppo economico e sociale. L'argomentazione, che concorda sul rilancio del ruolo del Mezzogiorno d'Italia e delle sue Isole nell'ambito del mercato e degli scambi mediterranei, pone l'accento nel rilevare i forti limiti degli approcci legati alle funzioni ordinatrici e di indirizzo di grandi opere, che piuttosto che servire ed accompagnare lo sviluppo delle energie e delle risorse endogene, vorrebbero illusoriamente determinarlo. Viene anche sottolineata l'obsolescenza di un progetto che individua principalmente nel trasporto terreste e su gomma (peraltro fortemente inquinante, dispendioso in consumi energetici e congestionante in termini di viabilità) lo strumento per gli scambi commerciali e la mobilità delle persone, a fronte delle nuove potenzialità offerte dalle infrastrutture portuali e dalle tecnologie integrate di trasporto marittimo, aereo e multimodale. Se da un punto di vista tecnologico il Ponte può apparire – in forza della lunghezza della campata centrale – opera avanzata, in realtà si rivela alquanto obsoleto e quindi scientificamente arretrato come mezzo funzionale adatto alle esigenze del nuovo millennio. Si sottolinea, per contro, come la salvaguardia riflessiva di quest'area possa offrire invece la possibilità di trovare proprio nella identità ecologica e paesaggistica i motivi di un nuovo sviluppo umano, sostenibile, equilibrato ed autopropulsivo. Il Mediterraneo è già in pericolo per il forte inquinamento che proviene da tutta Europa attraverso i grandi fiumi. Questo mare è stato, da sempre, crocevia non soltanto di traffici, ma soprattutto di civiltà. Esso non è tuttavia una strada che può essere consumata e ricostruita, almeno entro certi limiti. Non è soltanto luogo di transito. Esso non è uno spazio vuoto da occupare. Pensare al Mediterraneo come "area-sistema" in senso proprio vuol dire coglierne le peculiarità e salvaguardarle, almeno, negli aspetti più significativi e delicati. E’ questo il caso dello Stretto di Messina. Pensare e progettare ancora lo sviluppo in termini esclusivamente e tradizionalmente "urbani" e "prometeici" significa essere fuori dal nostro tempo, ancorati ad una modernità industrialista che mostra la sua drammatica obsolescenza tanto sul piano economico, che su quello politico e culturale.
L'economia della realizzazione. Pur volendo utilizzare parametri che non tengano conto alcuno delle pur fondamentali variabili ambientali - nella loro piena accezione - l'analisi costi-benefici, svolta in questo caso da esperti del Ministero dei Lavori Pubblici, è risultata nettamente negativa per l'opera. Dal punto di vista occupazionale la spesa da mettere in campo appare produrre effetti proporzionali di scarso rilievo: in larga parte si tratterà di occupazioni temporanee in fase di cantiere e nel complesso si stima una spesa complessiva di circa 9.000 miliardi, per un costo di circa un miliardo per posto di lavoro. Dal punto di vista delle economie di tempo nell'attraversamento dello Stretto - tanto rispetto alle attuali modalità di traghettamento, che soprattutto rispetto ad ipotizzabili e molto meno costose innovazioni ed ad ipotesi di potenziamento del medesimo - il risparmio appare assai ridotto e si prevede la frequente chiusura del Ponte in caso di venti e piogge. Anche le valutazioni di fattibilità economica più positive ed ottimistiche – come quella di recente elaborata dal Mediocredito Centrale – prevedono teoricamente un recupero economico nell’arco di quindici anni. Il costo previsto per il pedaggio sarebbe in ogni caso superiore a quello del trasporto marittimo. A fronte di questa prospettiva è una condizione della viabilità autostradale e ferroviaria – da Palermo a Messina e da Salerno a Reggio Calabria – assolutamente carente, incompleta, pericolosa e di non facile ammodernamento. A proposito della Salerno-Reggio è già stato segnalato come la presenza di tunnel e ponti (che occupano circa 180 km.) renda praticamente impossibile ogni ipotesi di allargamento e quindi di incremento della velocità di traffico. L’accesso al Ponte finirebbe, sic rebus stantibus, per rappresentare un ennesimo "collo di bottiglia" in cui si cumulano gli esiti di ripetute congestioni di traffico e si vanifica ogni possibile vantaggio in termini di tempo. Per contro va sottolineato, come peraltro suggerisce l’Unione Europea, il risparmio – sia economico che ambientale – che si realizzerebbe adottando un criterio multimodale di trasporto e sfruttando il cabotaggio costiero, che già da ora consente tempi minori rispetto ai Tir, costi monetari ed energetici di gran lunga inferiori. Il Ponte, in ogni caso, sarebbe un tipico investimento ad altissima intensità di capitale ed a bassa intensità di lavoro, oltre che di dubbia efficienza economica, in un’area che soffre di alti tassi di disoccupazione.
Il rischio sismico. L'area in cui è situato lo Stretto di Messina è nota come zona sismica ad alto grado di pericolosità, ai confini tra placca egea e placca adriatica, in cui si concentrano attività vulcaniche e terremoti. Nel 1693, nel 1783 e nel 1908 a Catania, Messina e Reggio Calabria si sono verificati devastanti terremoti, l'ultimo dei quali ha fatto registrare una magnitudo pari al 7mo grado della scala Richter (la più elevata dell'ultimo secolo in Italia). La cadenza degli eventi sismici citati è pari ad una media di 90 anni. Occorrerà dunque prevedere e prevenire un nuovo sisma. Il progetto del Ponte assicura una resistenza del manufatto a sismi pari a 7,1 gradi della scala Richter. Può questo calcolo di previsione giustificare la fattibilità dell'opera? (Per una valutazione in proposito esiste una ampia letteratura scientifica nazionale ed internazionale). Perché sfidare - ad onta delle cautele raccomandate da esperti e sul finire del decennio internazionale delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi naturali - la concreta possibilità sismica? Non è forse più opportuno, invece di rimuovere il rischio sismico dalla storia culturale, politica e scientifica di queste zone, rilanciare una "cultura del terremoto" e della sua prevenzione? Anche da questo punto di vista l'invito delle Nazioni Unite appare quanto mai opportuno, così come sarebbe opportuna la cancellazione del progetto.
L'impatto sociale e la protezione militare dell'area. E’ ragionevolmente ipotizzabile – contrariamente a quanto sarebbe invece auspicabile – che la megastruttura, tanto nella fase di realizzazione che in quella operativa, possa provocare effetti disaggregativi e disorganizzativi in un contesto sociale già fortemente minacciato. Squilibri distributivi, elevati tassi di disoccupazione, forti ed attivi interessi illegali e criminali, scarsa capacità di regolazione istituzionale ed universalistica, bassa efficienza amministrativa caratterizzano il contesto sociale e politico. L’accelerato degrado ambientale, particolarmente intenso negli ultimi decenni, è anche il risultato della concomitanza di tali fattori, in cui spinte endogene e condizionamenti esogeni si intrecciano. Di fronte a nuovi ed indubbi fenomeni di cambiamento e di inversione della tendenza, appaiono necessari interventi diffusi, mirati e coordinati, volti alla riqualificazione puntuale del tessuto socioeconomico e tali che accompagnino processi di dinamizzazione delle molteplici spinte individuali e collettive in atto. La concentrazione e la centralizzazione di risorse e capacità rispetto ad un unico, mega-intervento non sembra andare in questa direzione, anzi contraddice le più sensate logiche della pianificazione territoriale ed economica. Occorre poi sottolineare come il Ponte non risponda alla domanda di occupazione, non soltanto per l’elevatissimo investimento per unità lavorativa, ma per gli effetti drammatici che la disoccupazione di ritorno mostrerà, una volta finita l’opera.
E' in base a questi motivi che oggi rinnoviamo l’appello al Governo Italiano perché si cancelli definitivamente il progetto del Ponte di Messina, e chiediamo alle Nazioni Unite ed al massimo organismo culturale, l'UNESCO, di assumere sotto la sua protezione l'area dello Stretto di Messina in quanto bene intangibile e patrimonio dell'umanità.
|
|
Testo per la discussione redatto da Osvaldo Pieroni, docente di Sociologia dell’Ambiente presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica, Università della Calabria.
© 16 giugno 1998.
Sulla base di questo testo si è costituito un nucleo promotore per il Comitato "Tra Scilla e Cariddi", che intende farsi carico della produzione di studi e documentazione necessari per sostenere l’appello all’UNESCO, oltre che – naturalmente – della raccolta di adesioni a sostegno della proposta.
Fanno parte del Comitato promotore "Tra Scilla e Cariddi": Legambiente, WWF, Rifondazione Comunista (Calabria e Sicilia), Verdi, Cric, Torre di Babele, Comitati di Base di Messina, Alberto Ziparo (Università di Firenze), Osvaldo Pieroni (Università della Calabria).
Tra le prime adesioni segnaliamo: Serge Latouche (Università di Parigi, XI), Quirino Ledda, Giovanni Pandolfi (Vice Pres. Consiglio Regionale Basilicata), Nico Marcantoni (WWF Basilicata), Nadia Scardeoni ("Mezzocielo", Palermo- Comp. Comitato Scientifico Educazione&Scuola), Fulvio Beato (Cattedra di Sociologia dell’Ambiente, Univ.La Sapienza, Roma), Paolo Jedlowski (Univ. Della Calabria), Le Redazioni di Basilicata, Puglia e Calabria di "OraLocale", Il Centro Interdipartimentale di Women’s Studies "Milly Villa" (Università della Calabria), l’Associazione Internazionale delle Donne per la Comunicazione "Mediterranean Media".
Le adesioni possono essere inviate tramite e-mail a: o.pieroni@unical.it
oppure ai seguenti: ambiente@netonline.it , oralocale@hotmail.com , torredibabele@ecn.org
Tramite fax alla Redazione di "OraLocale": 0984/401199.