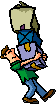
Entriamo in una BOTTEGA di Commercio Equo-Solidale...
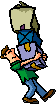
"Solo quelli che sono cosi' folli da pensare di cambiare il mondo....lo cambiano davvero"
Dall'Olanda, dove nacque negli anni 60 la prima bottega del
mondo, partì un movimento così vitale da riuscire, in pochi anni, a creare centinaia di
botteghe in tutta l'Europa centrale.
La diffusione delle botteghe del mondo ebbe caratteri diversi e fu promossa da vari
soggetti sociali.
Il fenomeno si è manifestato solo nella seconda metà degli anni ottanta, ma dove al
contempo si è registrato un entusiasmante sviluppo, in particolare in Spagna ed in
Italia. In questi due paesi il fair trade, sia come fatturato che come numero di botteghe,
ha fatto registrare negli anni '90 un vero e proprio boom: da poche decine di botteghe a
120 in Spagna e quasi il doppio in Italia, da poco più di un milione di Euro di fatturato
alla fine degli anni '80, a circa 6 milioni di Euro per la Spagna e 15 per l'Italia alla
fine degli anni '90.
Certo, siamo ancora lontani dai risultati che si registrano in Germania dove sono presenti
oltre 700 botteghe del mondo, 5000 gruppi di sostegno ed un fatturato che, relativamente
alla GEPA, la più importante centrale d'importazione dei prodotti del commercio equo,
arrivava al 1998 a circa 90 milioni di Euro. Complessivamente, oggi, sono circa 4000 gli
world shops presenti in 15 paesi europei.
Una rete che è cresciuta ad un tasso medio annuo del 20% nell'ultimi decennio, si va
estendendo ad altri paesi ed aree e che rappresenta, soprattutto, uno dei più rilevanti
tentativi di "demercificazione" nell'era della globalizzazione, di recupero del
valore sociale della produzione, di creazione di un legame sociale forte tra i produttori
del sud ed i consumatori del nord.
Al di là dei numeri, della crescita quantitativa, ciò che più conta nell'attività
delle botteghe è l'aver creato uno spazio dove i prodotti hanno qualcosa di più da
comunicare che un prezzo di vendita.
Proviamo a fare una visita ad una bottega del mondo ed a entrare nelle
storie di vita, nel duro lavoro, nelle reti sociali che stanno dentro i prodotti che
vediamo esposti.
![]() Che cosa c'è nelle botteghe?
Che cosa c'è nelle botteghe?
Quando si entra in una "bottega del mondo" si rimane immediatamente colpiti
dalla bellezza dei colori, dalla varietà delle forme, dalla molteplicità degli oggetti
dell'artigianato di tre continenti. Un mondo in gran parte sconosciuto, perché anche chi
ha viaggiato nei paesi del sud ha comprato
spesso oggetti per i turisti, pensati e calibrati secondo modelli e colori che piacciono
agli "occidentali", ma nulla hanno a che fare con il patrimonio artistico
locale.
Ma ciò che sorprende il visitatore è che questi prodotti non vengono propagandati dai
volontari della bottega per il rapporto "qualità-prezzo", per gli sconti
eccezionali, per la convenienza, quanto per il significato di cui sono portatori.
Improvvisamente, il potenziale acquirente scopre che dietro una statuetta, una borsa, una
collana, un foulard, un pacco di caffè o tè c'è una storia: da dove nasce, chi l'ha
prodotto, con quali materie
prime, con quale tipo di organizzazione sociale. Storie di uomini, di donne, di persone
disabili, di comunità agricole, di associazioni di artigiani, che si presentano
attraverso delle brochures o che si trovano nel librone dei progetti che è presente in
ogni bottega.
Abituati a guardare solo al prezzo delle merci, o al leggere al massimo il made in..., la
maggioranza dei consumatori rimane stupita o, più spesso, indifferente.
A primo acchito, infatti, solo pochi visitatori sono attratti da questa potenzialità di
conoscenza e di relazione sociale che gli si offre. Solo l'abilità nel comunicare del
volontario e/o lavoratore della bottega può colmare questo vuoto. Per questo nelle
botteghe non ci può stare una persona qualsiasi, in quanto la vendita di un prodotto del
commercio equo ha un senso - e crea una coscienza critica - solo nella misura in cui il
consumatore comprende che non sta comprando una merce qualsiasi, ma un prodotto, frutto
del lavoro di uomini e donne reali, che vivono in un determinato luogo e hanno tanti
problemi (di discriminazione etnica, emarginazione, sfruttamento, guerre, ecc.), ma anche
tanta voglia di riscatto.
![]() Prodotti con una storia
Prodotti con una storia
Lo sforzo del commercio equo è quello di trasformare i consumatori in acquirenti, cioè
in persone capaci di mettersi in ascolto per "acquisire", cioè entrare in
sintonia con le storie che questi prodotti contengono.
Acquistare un maglione peruviano, ad esempio, significa contribuire alla lotta di
centinaia di donne incarcerate ingiustamente dal regime di Fujimori. Comprare i bicchieri
blu, ad esempio, significa acquistare un prodotto delle donne maya del Guatemala, che
resistendo a minacce e aggressioni, sono riuscite a mettere su una cooperativa, Copavic,
che lavora il vetro riciclato. Così quando si comprano gli anacardi si scopre che vengono
dall'Honduras e sono prodotti da una cooperativa di donne, che oltre a trasformare le pasa
(i frutti di anacardio), fanno corsi di alfabetizzazione e hanno creato un'area
comunitaria per la coltivazione di ortaggi per il consumo interno. Ancora cooperative di
donne in Filippine che producono zucchero di canna integrale che lottano per sopravvivere
alla terapia intensiva del F.M.I. (Fondo Monetario Internazionale) che ha prima indebitato
e poi affamato questo paese, con il sostegno dell'ex-presidente Marcos. Ancora donne
filippine del Coordinamento donne "Grabriela" - per ricordare Gabriela Galaug,
rivoluzionaria filippina, uccisa dagli spagnoli nel secolo scorso - una organizzazione che
conta oltre 50.000 aderenti e che, fra l'altro, ha dato vita a due associazioni:
"Silang" per la raccolta delle banane, "Nagaisa" per la lavorazione e
trasformazione. Così viene prodotta, in un'isola del sud delle Filippine la "banana
chips", un prodotto nuovo che ha riscontrato il favore del pubblico europeo. Se il
nostro ipotetico visitatore si gira da un'altra parte, trova decine di strumenti musicali
diversi, insoliti, curiosi. Per alcuni fa fatica a capire come possano suonare, produrre
delle armonie, altri gli sembrano più degli oggetti del rigattiere che dei veri e propri
strumenti musicali. Da dove viene, si domanda, quel xilofono fatto di zucche e legno?
Viene dal nord-ovest del Camerun ed è prodotto da "Prescraft" un'associazione
patrocinata dalla chiesa presbiteriana, che oltre che xilofoni, produce tamburi, flauti
traversi ecc. E questi prodotti nascono dalle mani di persone colpite da diverse
disabilità, per i quali questo lavoro è la sola alternativa alla morte per fame o alla
morte civile (l'elemosina). Quello che è veramente straordinario è che molti dei
progetti che hanno dato i migliori risultati siano stati promossi da persone con diverse
invalidità.
È il caso di Bombolulu, una cooperativa di 270 disabili - che producono della ottima
bijotteria - nata per volontà dell'associazione kenyota disabili, con il sostegno
iniziale dei "Peace Volountaires Corps". Così, Silence, in India, una
cooperativa con più di 100 addetti, di cui l'80% sono sordomuti, che produce bastoncini
d'incenso e collanine molto apprezzate dai clienti delle botteghe del mondo. Oppure in
Nicaragua, dove "l'Organizzazione rivoluzionaria disabili di guerra", nata
durante la guerra che i contras (leggi C.I.A.) avevano scatenato per abbattere il governo
sandinista, ha creato il "Taller de Ceramica por la Paz" che ha dato vita a
piatti, tazze, ecc. di ceramica dipinta con i colori naturali del Nicaragua.
![]() Caffè e tè etici
Caffè e tè etici
Se ci spostiamo nel settore alimentare troviamo il caffè Uciri che ci parla degli
indigeni del Messico, di come 11.000 contadini si sono organizzati per contrastare il
micidiale meccanismo della speculazione, sia degli intermediari-usurai locali che delle
imprese multinazionali, che fa oscillare i prezzi del caffè in base alla logica perversa
dei "derivati finanziari" che ignorano i milioni di contadini che possono morire
di fame se il prezzo crolla. Fra le scatole di tè andiamo a vedere, per esempio, cosa si
nasconde dietro "il tè alle erbe Himai". Un cartoncino accanto ci
racconta:" il tè Himai fa parte dei prodotti della Gorka Ayurved Company (Nepal),
nata da un progetto della ONG (Organizzazione Non Governativa) francese C.I.D.R e divenuta
autonoma nel 1992. I prodotti provenienti dalla G.A.C. si collocano nell'ambito delle
piante medicinali, nel filone della tradizione ayurvedica. L'ayurveda, che fa parte dei
Veda, è una scienza antichissima. Le sue radici risalgono a 5.000 anni fa e la prima
enciclopedia, manoscritta su foglie di palma, al VII secolo a.C., età d'oro della storia
indiana.
Un'altra scatola di tè - Darjeeling Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe - un'altra
storia indiana: secondo la leggenda locale è stato Daruma, un monaco buddista, che
cercando la tranquillità, ha scoperto il tè Darjeeling di Ambootia, la regione del
mitico Yeti. Si racconta che nel
1861, a causa di una forte ed improvvisa gelata, lo Yeti volesse distruggere tutta la
regione di Darjeeling, ma un uomo saggio lo bloccò offrendogli una calda tazza del tè di
Ambootia. Lo Yeti ritrovò l'armonia, si calmò e ritornò nel regno delle montagne
himalayane.
Centinaia di prodotti, migliaia di storie che s'intrecciano, si saldano, si trasformano in
forme e colori, si materializzano in un grandissimo ventaglio di prodotti diversi.
Migliaia di contatti, di viaggi, di incontri tra le organizzazioni del nord e del sud, per
far nascere un progetto, per inserire un prodotto all'interno del circuito del commercio
equo e solidale.
Ci vorrebbe un'enciclopedia per raccontare le vicissitudini, le speranze, le delusioni che
stanno dietro questi prodotti che troviamo nelle botteghe. Ed è veramente difficile
comunicare questa ricchezza di rapporti, di relazioni tra culture diverse. Siamo talmente
immersi nel mondo delle merci, di questi oggetti senz'anima e senza storia che fanno parte
del nostro quotidiano, che facciamo un grande sforzo a riconoscere il valore dei prodotti
del fair trade. Le ATO's hanno fatto un grande sforzo nel fornire documenti, depliants,
video cassette, per "informare e formare" il consumatore occidentale, ma molta
strada resta da fare. Anche il fatto di esporre delle tabelle con la formazione dei prezzi
dei singoli prodotti, uno scandalo per le regole del mercato capitalistico, non suscitano
ancora quella presa di coscienza che sarebbe necessaria. Prendiamo, per esempio, lo
"schema prezzo trasparente" del tè Himai.
![]() La formazione del prezzo
La formazione del prezzo
Fatti, numeri, dati concreti con cui il fair trade si confronta ogni giorno. Anche questo
è un modo per far crescere una coscienza critica.
Anzi, potrebbe costituire un'ottima base di partenza per l'insegnamento delle materie
economiche, nelle scuole quanto nelle Università, per far uscire la scienza economica
dall'estetica alienante della formalizzazione e far fare a tutti i conti con la realtà.
Una realtà complessa, spesso pesante, che ti pone non poche domande. Balza subito agli
occhi, infatti, il fatto che la quota del prezzo che va alle botteghe è superiore a
quella dei produttori. Malgrado i produttori nepalesi percepiscano nella rete del fair
trade quasi tre volte quello che gli offre il mercato "normale", rimane questa
evidente contraddizione. Ciò è dovuto al fatto che le botteghe del mondo hanno dei
piccoli fatturati e quindi quel margine serve a coprire le "spese vive", ma
questa contraddizione rappresenta anche uno forte indicatore che ci mostra chiaramente il
baratro economico che divide il nord dal sud del mondo. Anche quando attraverso il
commercio equo riusciamo a pagare il doppio il caffè di un contadino centroamericano il
suo reddito annuo passa da 500 a 1000 dollari, e quindi il suo guadagno settimanale da 10
a 20 dollari, cioè quanto un lavoratore non qualificato in Europa guadagna in 4 ore... Al
termine del suo breve giro il nostro visitatore avrà ricevuto tante suggestioni, avrà
forse capito che dietro lo scambio - del suo denaro con un oggetto - si nascondono tante
storie, tante difficoltà e tante speranze.
Probabilmente se ne andrà via con più domande che certezze perché avrà capito che il
"prezzo equo" ancora non esiste, ma vale la pena di cercarlo.
![]() Il mercato internazionale
Il mercato internazionale
Se il commercio equo fosse consistito solo nel fatto di pagare un po' di più i produttori
del sud del mondo non avrebbe fatto molti passi in avanti, non sarebbe arrivato a
coinvolgere qualcosa come 1.200.000 produttori del sud che rappresentano, considerando il
nucleo familiare medio, qualcosa
come 7 milioni di persone che vivono più dignitosamente grazie a questa rete
internazionale.
La forza del fair trade è consistita in primo luogo nell'aver creato delle nuove
relazioni sociali tra produttori del sud e compratori del nord.
Relazioni complesse, qualche volta conflittuali, ma che si collocano nell'arcipelago
dell'economia sociale o civile con una forte innovazione rispetto alla storia del
movimento delle cooperative (di consumo, di produzione e lavoro ecc.). La differenza
rispetto a queste esperienze consiste innanzitutto nell'approccio "globale",
nell'aver creato dei network internazionali che sono costitutivi dell'attività del"
fair trade", mentre le pur importanti esperienze storiche del mondo delle cooperative
avevano sempre una base locale ed un legame, attraverso le federazioni, nazionale.
Inoltre, rispetto alle forme mutualistiche del passato, il legame internazionale fa sì
che il fair trade non si limiti a creare spazi di mercato alternativo rispetto a quello
capitalistico, ma continui a
giocare un ruolo di denuncia e di coscientizzazione attraverso la partecipazione
/promozione di campagne internazionali per la difesa dei diritti dei lavoratori del sud.
Pertanto, è corretto affermare che il fair trade rappresenti uno dei tentativi più
significativi di rispondere alla sfida del capitalismo globale attraverso la creazione di
spazi di lavoro e consumo alternativi.
In termini quantitativi si può stimare, al 1998, in circa 0.7 miliardi di dollari il
fatturato del fair trade a livello mondiale che, se confrontato al valore degli scambi di
beni e servizi a livello internazionale, pari a 6500 miliardi di dollari al 1998, ci
dà un rapporto di 0,00008. Vale a dire: per ogni 100.000 dollari di scambi che passano
attraverso il mercato capitalistico ce ne sono 8 che passano attraverso il fair trade. Una
goccia nel mare del mercato capitalistico? Non esattamente. Se entriamo nel merito dei
6500 miliardi dollari degli scambi internazionali troviamo che: almeno
400 miliardi di dollari sono dovuti al traffico di droghe (vedi rapporto ONU 1997), circa
100 al traffico di armi e rifiuti tossici, e una cifra grande ma non quantificabile è
dovuta al commercio di sostanze inquinanti e nocive per l'uomo e per l'ambiente, nonché
al recente traffico di clandestini. Se poi passiamo a considerare l'impatto occupazionale
del commercio internazionale scopriamo una cosa veramente incredibile. Se applichiamo il
coefficiente fatturato/occupazione del fair trade al
commercio internazionale troviamo che con i suoi 6500 miliardi di dollari dovrebbe dare un
impatto occupazionale pari a 10 miliardi di posti lavoro, più del doppio di tutta la
popolazione della terra in età di lavoro!
Come è noto, la realtà del commercio internazionale è ben altra: sono circa 370 milioni
i posti di lavoro "legati" allo scambio internazionale su scala mondiale e di
questi, considerata la prevalenza degli scambi nord-nord e il diverso rapporto
capitale-lavoro nelle aree periferiche, abbiamo che circa 220 milioni di occupati li
possiamo localizzare nel nord sviluppato e circa 150 milioni nelle aree periferiche.
Considerando questi dati si evince che il rapporto, in termini di impatto occupazionale
nelle aree del sud del mondo, del fair trade rispetto al commercio internazionale è di 1
a 150. Un peso marginale, ma non irrilevante! Ma è soprattutto sul piano qualitativo che
il commercio etico rappresenta un fatto estremamente significativo per le condizioni di
vita dei lavoratori delle aree periferiche. Innanzitutto, sul piano salariale le
condizioni dei lavoratori collegati al fair trade sono nettamente migliori di quelle dei
lavoratori che sono dipendenti di imprese locali o di filiali di imprese multinazionali
che, va ricordato, da sole controllano circa il 50% degli scambi internazionali. Inoltre,
le cooperative o comunità collegate con il fair trade ricevono un credito all'ordine che
gli consente di acquistare la materia prima, le sementi ecc. per avviare la produzione.
Questo è un fatto di estrema rilevanza per i produttori del sud del mondo.
Dalle storie di vita raccontate dai protagonisti del fair trade, vale a dire i circa 800
partner commerciali di 45 paesi del sud (considerando solo quelli che lavorano con
l'European Fair Trade Association) emerge un fenomeno decisamente inquietante: la
diffusione e il peso dell'usura.
Spesso la chiusura di piccole unità produttive locali è determinata più che dalla
concorrenza sui prezzi all'esportazione dal peso micidiale dell'usurario che la fa da
padrone in sistemi dove sono totalmente assenti i canali del credito bancario.
Infine non va sottovalutato il fatto che negli accordi con i partner commerciali del sud
viene da diversi anni introdotta una clausola sociale che prescrive di destinare una quota
del fatturato (mediamente intorno al 5%) per migliorare le condizioni di vita della
comunità, villaggio, quartiere, ecc. È evidente che questa opportunità è condizionata
da una gestione efficiente delle imprese sociali del sud che a sua volta è legata ad una
domanda "etica" dei consumatori del nord.
Tratto da: http://www.ulysse.net/verde/guida2/finanza/
Leggete il resto su www.tatavasco.it (sezione Commercio Equo)