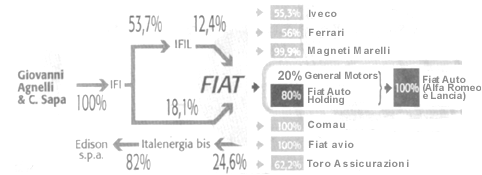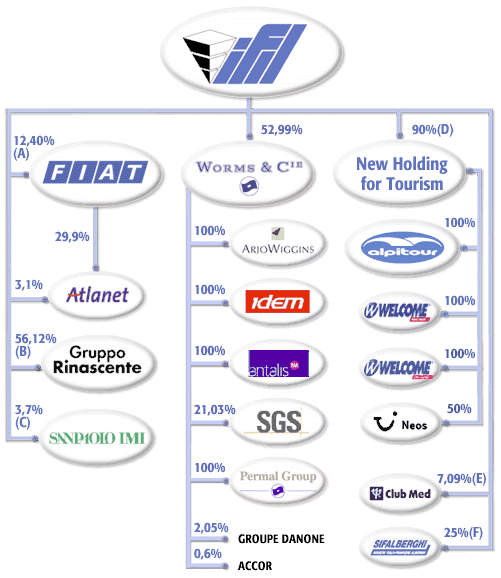La crisi della Fiat e le risposte
possibili .
Perché
la Fiat è in crisi. La reazione operaia. I limiti delle risposte della
politica e del sindacato. Di Michele Corsi. 2 novembre 2002.
I
tagli della Fiat Il
9 ottobre la FIAT chiede lo stato di crisi (passo necessario per accedere
ad ammortizzatori sociali parzialmente a carico dello stato, quali cassa integrazione
straordinaria e mobilità) e presenta un piano che individua 8.100 esuberi
(11.000 a giugno) di cui 500 in mobilità (quelli più vicini
alla pensione) e il resto in cassa integrazione a 0 ore da dicembre, su 36.000
dipendenti di FIAT auto che lavorano negli stabilimenti italiani (1). Particolarmente
penalizzate Arese e Termini Imerese i cui stabilimenti sono destinati alla
chiusura. Difficile
le stime dell'indotto coinvolto. Secondo La Repubblica (11/10) solo
a Torino questo coinvolgerebbe circa 73.000 addetti per 1.200 aziende per
un totale di esuberi compreso tra gli 11.000 e i 15.000. Gli
antecedenti L'accordo
tra Fiat e General Motors del 2000 prevedeva l'acquisizione da parte di GM
del 20% della Fiat auto, con una opzione di acquisto obbligatoria su richiesta
Fiat ("put") da parte di GM del restante 80% a partire dal 2004.
All'epoca, Fiat e gran parte dei quotidiani parlarono di accordo "storico"
che avrebbe creato splendide sinergie e rilanciato l'auto italiana. Poi
a maggio di quest'anno ecco la doccia fredda della "rivelazione" dell'enorme
debito Fiat (2) e l'inizio della negoziazione con le banche creditrici, che
termina a fine luglio con un "patto anticrisi" che prevede la cessione da
parte di Fiat di una serie di "asset" e un prestito fortemente condizionato.
Il patto deve consentire alle banche esposte di "accompagnare" la Fiat sino
al momento in cui eserciterà il put, cioè cederà il settore
auto alla GM (3). Dobbiamo
precisare per comprendere la dinamica della vicenda che Fiat Auto è
solo una parte dell'impero Agnelli. Qui di seguito uno schema semplificato,
che esclude le partecipazioni Ifil (4): La
dinamica recente della crisi Giorni
prima dell'annuncio di stato di crisi circolavano le prime cifre sugli esuberi.
La reazione iniziale del governo e delle forze politiche era stata piuttosto
blanda, ma non quella del mercato: l'8 ottobre il titolo torna ai livelli
dell'85, la media mensile delle perdite del gruppo è di 140 milioni
di euro. Il Corriere della Sera dopo l'incontro tra l'amministratore
delegato Galateri e il ministro delle attività produttive Marzano (successivamente
emarginato dalla estione della crisi) avvenuto l'8, si precipita (con la penna
di M.Gaggi, il 10) ad escludere qualsiasi "salvataggio a spese del contribuente",
ma, al massimo, incentivi alla reindustrializzazione, senza "veti" alla chiusura
di stabilimenti. Ma
la reazione operaia, soprattutto a Termini Imerese (in quella Sicilia dove
il Polo ha portato a casa il 100% degli eletti alle politiche), ma anche ad
Arese e poi gli scioperi in Piemonte, spingono la destra "regionale" ad un
balletto teso a mostrare ai "propri" operai, che si cerca di tutelare i loro
interessi a scapito dei colleghi delle altre regioni. Fini e Cuffaro diventano
i difensori di Termini, la Lega di Arese e Ghigo di Mirafiori. A quel punto,
l'11 ottobre interviene Berlusconi dicendo che nella crisi Fiat il governo
"farà la sua parte". Incomincia così una fase complessa della
crisi dove si intersecano vari disegni e opposti interessi, e che durerà
qualche giorno, ma che è di estremo interesse per comprendere le dinamiche
del capitalismo. La
Fiat comincia a pressare la General Motors perché anticipi l'opzione
di put che dovrebbe esercitare a partire dal 2004. La Fiat vuole liberarsi
del settore auto che trascina verso il basso il resto del gruppo che invece,
come vedremo, va bene. Il presidente Fiat Paolo Fresco l'11 ottobre dichiara
al Wall Street Journal che la questione della cessione dell'auto a
GM non è "se" ma "come, quando e a che prezzo". La dirigenza Fiat,
dato che vuol disfarsi dell'auto, non ha alcuna intenzione di metterci dei
soldi, e in tutti i casi se lo facesse comprometterebbe il resto del gruppo:
il 18 ottobre Standard & Poor's ha dato un giudizio A (quindi positivo)
su Ifil condizionato però al non esborso di capitali aggiuntivi nel
"pozzo" Fiat auto. Negli
ambienti governativi intanto comincia ad essere ventilata l'idea di una entrata
dello stato nel capitale Fiat (vari commentatori parlano di "modello
Volkwagen") (5) insieme alle banche creditrici e alla stessa GM. Il Governatore
della Banca d'Italia dà il suo via libera (Fazio: "l'intervento pubblico
non e' peccato", 15 ottobre) così come Monti, commissario alla concorrenza
a Bruxelles durante una telefonata con Berlusconi (il 14: "a patto che lo
stato si comporti come un investitore privato"). Come risulta chiaro nell'incontro
del 13 ottobre tra Fiat e Berlusconi, ciò che il governo vuol portare
a casa è la garanzia della prosecuzione della produzione a Termini
Imerese. Secondo La Repubblica (14 ottobre) Fresco sarebbe stato disponibile
ad una cessione a costo zero della Fiat auto allo Stato in cambio della autorizzazione
a dieci nuove centrali elettriche per rafforzare Italenergia, colosso elettrico
(controlla Edison) in mano Fiat. Il governo pressa comunque, con Fini, perché
"anche la Fiat faccia la sua parte", cioè metta soldi del resto del
gruppo (o asset, si parla della Ferrari o della partecipazione in Hdp). Ma
GM fa presto conoscere il suo pensiero: il 15 dichiara che eventuali cambiamenti
di controllo in Fiat farebbero decadere immediatamente l'opzione di acquisto.
Lo stesso giorno svaluta enormemente la quota Fiat detenuta. Secondo il New
York Times (citato dal Corriere del 17) "il motivo di una svalutazione
cosi' forte del 20% di Fiat Auto è per abbassarne il prezzo nel caso
GM debba acquistarne il restante 80%". Accelerare l'acquisto del resto non
sarebbe conveniente per GM: perché gestire in prima persona una dolorosa
ristrutturazione, quando la Fiat può ben fare il lavoro sporco? Anche
il crollo del valore dell'azienda non sarebbe un dramma: il patto stabiliva
l'obbligo di acquisto, ma il prezzo sarebbe stato quello del momento in cui
l'opzione veniva esercitata. Infine: GM non ha interesse che lo Stato entri
nel capitale: sa bene che questo avverrebbe solo dando come garanzia la non
chiusura di stabilimenti considerati non produttivi. Di nuovo il New York
Times: "sull'ipotesi di un intervento del governo italiano in Fiat Auto,
gli analisti osservano che in linea di principio la GM è contraria
perché renderebbe più difficile influire sulla sua gestione
a beneficio dei propri azionisti." E
veniamo a un ulteriore attore della vicenda: le banche. Il loro interesse
non coincide con quello di GM: se la Fiat va a rotoli, GM la rileva gratis,
ma loro ci rimettono i crediti. Per questo le banche creditrici premono perché
la Fiat venda degli asset del gruppo (mentre lo stato vorrebbe nello scambio
appropriarsene per sé) in modo da diminuire il debito. La divertente
locuzione che utilizzano quando propongono alla Fiat la dismissione del Toro
Assicurazioni è: "allargare il perimetro delle cessioni" (23 ottobre).
Le banche vogliono che si arrivi al momento della cessione alla GM in una
situazione in cui la Fiat possa "vendere bene", perché i proventi poi
andrebbero in gran parte girati a loro per ripianare il debito: l'interesse
dei creditori è di "accompagnare il nostro maggior debitore verso l'alleanza
con gli americani della GM" (Corriere, 17). Le banche sono a loro volta
sotto pressione: l'agenzia di rating Fitch ha messo sotto osservazione le
sei banche creditrici, e tutte e sei il 23 ottobre cadono in Borsa. Sia le
banche che la Fiat dunque, dopo alcuni giorni in cui ognuno aveva giocato
il proprio gioco, si ritrovano dalla stessa parte della barricata: il put
rappresenta la loro ancora di salvezza, dunque l'intervento dello stato sarebbe
dannoso perché farebbe saltare l'accordo con GM, si deve tirare fino
al 2004 "risanando", perché solo così si può vendere
bene agli americani. Il
16 dunque i giochi sono fatti, e si chiude la breve parentesi dell'ipotetico
intervento pubblico. Banche e Fiat vanno dal ministro del Tesoro Tremonti
a comunicare che il piano industriale (che Tremonti afferma di non conoscere,
trattandosi in effetti di un semplice programma di tagli) è l'unica
strada da percorrere e che non vi è alcun bisogno di intervento statale.
A questo punto il governo si tira indietro. Non ha alcuna convenienza economica
e nemmeno politica ad entrare nella partita: non servirebbe ad evitare i tagli,
e favorirebbe degli azionisti i cui vantaggi comunque verrebbero poi ceduti
a GM. Il 17 il governo dichiara che non interverrà finché la
Fiat non presenterà un piano industriale senza chiusure e la palla
torna, non a caso, all'inutile Marzano che può permettersi anche qualche
provocazione: "con i 2,3 miliardi di euro versati dal mio ministero alla Fiat
dovremmo essere gia azionisti" (17 ottobre). Il 19 ottobre il Corriere
può tirare un sospiro di sollievo e titolare: "lo stato resterà
fuori dal capitale. Si può voltare pagina". Lo stesso giorno Galateri:
"non c'è altro in corso salvo il put. E il put fa parte di un discorso
che si potrà aprire dal 2004 al 2009. ma che non ha legami con il risanamento
di Fiat auto. il cui piano di rilancio va avanti a prescindere da qualunque
tipo di investimento". Naturalmente
il piano di "rilancio" con addirittura 20 nuovi modelli nel 2004
è roba buona per i polli: nel 2004 i resti della Fiat verranno mollati
a GM, e punto. Le
lotte in corso L'accordo
tra Fiat e banche a luglio aveva lasciato sul terreno 3.000 esuberi, con un
accordo infame firmato da Fim e Uilm che giuravano su un piano industriale
che si è rivelato, a soli due mesi di distanza, una bufala. La
reazione operaia ha preceduto le dichiarazioni ufficiali della Fiat. Già
il 4 ottobre c'erano scioperi ad Arese e a Mirafiori, il 7 a Termini Imerese
con blocco dell'autostrada. Fim, Uilm e Fismic ferme ad aspettare le "comunicazioni
ufficiali". Con
lo stato di crisi dichiarato si intensifica la mobilitazione operaia. Il 9
a Termini c'è una manifestazione di 10.000 persone e lo stesso giorno
dopo l'incontro con la Fiat i tre sindacati di categoria proclamano 4 ore
di sciopero per il giorno dopo. Poi l'11 sciopero unitario in tutte le fabbriche
Fiat (si fermano anche Melfi e Pomigliano, non toccati dalla cassa). L'RSU
di Melfi propone di rinunciare a un turno per "darlo" a Termini. La mobilitazione
è più vivace ad Arese e a Termini, meno a Mirafiori, in una
città depressa da due decenni di cassa integrazione e riduzione di
personale. Il 14 l'Alfa di Arese sciopera di nuovo (e come sempre blocca l'autostrada)
e il 17 gli operai di Termini vanno in massa a Roma dove bloccano strade,
metro, stazioni. Lo stesso giorno Fim, Uilm e Fiom indicono lo sciopero generale
di categoria per il 15 novembre di 4 ore e 8 per il gruppo Fiat. Il 28 di
nuovo sciopero unitario a Termini e Mirafiori. Queste
lotte hanno chiaramente spinto il governo a compiere quel tentativo di intervento
di cui abbiamo parlato sopra: se non avesse sospettato di poter pagare un
prezzo politico troppo elevato per la sua indifferenza, non si sarebbe preoccupato
affatto del problema. Ma queste lotte non sono state sufficienti ad incidere
in profondità nei rapporti di forza con l'alleanza, fatta di interessi
incrociati, tra Fiat, GM e banche. Per capire il perché dobbiamo compiere
una digressione. La
crisi della FIAT e le sue ragioni Sui
mass media si sono date le più svariate spiegazioni sugli "errori"
della Fiat. Si va dal "partito" Pininfarina seccato che la Fiat non si sia
servita di lui e che sostiene che "la Fiat avrebbe dovuto puntare tutto
sul design", a Fazio che ha criticato la contabilità Fiat, ecc.
Ed anche a sinistra c'è il partito dei cercatori di "errori" della
dirigenza Fiat: tra i tanti, Revelli che critica il fatto che la Fiat si sia
globalizzata in ritardo ("La globalizzazione stracciona") mentre Andrea Fumagalli,
sempre sul Manifesto, il 1° novembre critica l'assenza di una
"politica industriale". Non
condividiamo nessuno di questi punti di vista. Più precisamente non
condividiamo l'ipotesi dell'"errore". Esso suppone un retropensiero: che se
nel capitalismo le aziende non compissero "errori" e magari disponessero
della mitica "politica industriale" non ci ritroveremmo con crisi, esuberi,
ecc. Non sappiamo come si chiami una società senza tagli, licenziamenti,
dismissioni, concorrenza spietata, ecc. Sappiamo solo che non si chiama capitalismo,
e non è, per ora, su questo mondo. Molto
più semplicemente la Fiat ha fatto una scelta, l'ha fatta molti anni
fa, e l'ha fatta in base all'unica logica e all'unica morale che il capitalismo
conosca: il profitto. La Fiat ha già da tempo compiuto la scelta di
uscire dall'auto, perché il settore presentava una concorrenza internazionale
inarrivabile per l'Italia, e i profitti ricavabili avevano un'entità
inferiore a quella di altri settori. Dov'è l'errore, dal punto di vista
capitalista? A noi pare invece molto logico. Alcuni
dati e alcuni commentatori intelligenti ci aiuteranno a dimostrarlo. Nel '90
la quota Fiat nel mercato italiano era del 52% (con Lancia e Alfa), oggi è
al 31%. In Europa si è passati dal 14% all'8%. Un calo dunque che percorre
tutti gli anni novanta. Giuseppe Turani su La Repubblica dell'11 ottobre
ci ricorda che nel 1989 la Fiat aveva raggiunto il suo apogeo con il 10,7%
di utile corrente sul fatturato. L'uscita di Vittorio Ghidella da Fiat Auto
segna simbolicamente l'inizio della fuoriuscita dal settore e l'inizio del
declino dell'auto Fiat. Romiti infatti punta decisamente sulla diversificazione.
Alessandro Penati scriveva sul Corriere prima dell'accordo con GM:
"in un mercato a crescente concorrenza come quello dell'auto, dove pochi colossi
si contendono a livello mondiale spazi sempre più ristretti, la Fiat
presto si troverà a un bivio: immettere nuove risorse nel settore automobilistico,
mantenendone il controllo; oppure uscirne, per investire in settori più
promettenti. Ma Fiat non è un'azienda come le altre: sarebbe indelicato
parlare di vendita. Prepariamoci dunque a una più digeribile 'alleanza
strategica'". La
Fiat aveva 130.000 dipendenti nell'80, calati a 90.000 a metà anni
ottanta, poi a 50.000 a inizio dei 90 (12.000 quadri e impiegati vennero buttati
fuori tra il '93 e il '94) per arrivare ai 36.000 di oggi. Tutto ciò
corrisponde alla scelta ben precisa di mantenere l'azienda in una china di
"produttiva decadenza": di non investire, ma di ridurre le spese all'osso,
un'operazione di "spolpamento" dell'azienda per ricavarne risorse da gettare
altrove, finché dura. Operazione del resto nella quale la Fiat è
esperta: ha fatto così con l'Alfa Romeo acquistata nel 1986 (nei fatti
regalata dallo Stato) pur di non vederla cedere alla Ford e l'ha progressivamente
smantellata, lo stesso era accaduto con Lancia ed Innocenti. Secondo
Eurobusiness (citato da Ezio Mauro su La Repubblica del 18 ottobre):
"negli ultimi sei anni Volkswagen ha speso 21 miliardi di euro per studiare
i nuovi modelli, Renault 10,4, Bmw 10, Fiat appena 4,5." Per Riccardo Gallo
ex vicepresidente dell'Iri e oggi consulente di Antonio Marzano, nella gestione
della Fiat degli ultimi anni "si è pensato molto a migliorare l'efficienza:
la produttività è aumentata molto. Basti pensare che il valore
aggiunto per addetto nel 2001 è stato di 82.000 euro, superiore a quello
di Ford, Psa, Chrysler e Renault. Ma a impoverirsi è stato il ciclo
industriale". (Corriere Economia del 21 ottobre). Mentre
disinvestiva nell'auto, la Fiat acquisiva altrove. Solo negli ultimi anni:
nel '99 Case, Kobelco e Pico e nel 2001 è entrata alla grande nel settore
elettrico. Montedison, oggi controllata da Fiat con il 24,6%, è la
seconda azienda del comparto dopo l'Enel. E l'indiscrezione riportata da Repubblica,
che abbiamo riportato sopra, sulla contropartita chiesta da Fresco a Berlusconi
(il permesso alla costruzione di dieci nuove centrali) è oltremodo
significativa. Naturalmente
in questo disegno di "errori", dal punto di vista capitalista, la
dirigenza Fiat ne ha fatti. Penati ad
esempio sul
Corriere le rimprovera di non aver dismesso prima e subito
il settore auto. E per come stanno andando le cose è chiaro che i manager
del gruppo devono aver sbagliato a calcolare bene i tempi. Ma si tratta di
errori sui tempi: in poche parole se questi "errori" non
ci fossero stati, Fiat Auto sarebbe già stata venduta prima
e i suoi operai sarebbe già da un pezzo a spasso, perché questa
era la decisione strategica presa dai suoi proprietari sulla base delle prospettive
di profitto. La
Fiat dunque, al pari di qualsiasi azienda capitalista, si fonda sulla ricerca
del profitto, del suo profitto, e da quel punto di vista ha compiuto,
dieci anni fa, la scelta giusta. Solo che si tratta di una scelta, come tutte
quelle dettate dal profitto, che non coincide affatto con gli interessi degli
operai. I due interessi, quello capitalista e quello operaio, sono contrapposti
e non c'è alcuna "gestione illuminata" da parte dei manager,
nessuna splendida "politica economica" che potrebbe conciliarli.
La cronaca che abbiamo fatto sopra dei giorni tra l'11 e il 16 ottobre, dimostra
che ogni attore nella disputa capitalista ragiona secondo i propri precisi
interessi dettati appunto dalla prospettiva del profitto, e secondo questa
logica, la gran parte delle azioni sono obbligate. La sinistra e i sindacati
dunque non possono sperare di cavarsela cercando di suggerire ad Agnelli &
C la maniera migliore per fare il capitalista, perché Agnelli &
C lo sanno già, purtroppo. Si deve agire in maniera tale da inceppare
e sconfiggere quella logica. Ma è ciò che, sinistra e sindacato,
come vedremo, hanno difficoltà a portare avanti. L'assenza
della politica E
qui veniamo ad una prima ragione per cui la dirigenza Fiat ha potuto impunemente
portare avanti la sua strategia negli ultimi dieci anni e nell'ultimo mese:
la totale assenza dell'opposizione. Nel centrosinistra Rutelli e la Margherita,
semplicemente, non hanno detto nulla. Immaginiamo che per loro le decisioni
prese dal gotha dell'economia non siano da discutere. Alla fin dei conti però
li comprendiamo: che gliene importa? Mirafiori non è certo la loro
base sociale, e neppure Termini Imerese, i loro referenti sociali sono altri.
Quella
che lascia sbigottiti è, come sempre, la maggioranza DS, che, invece,
ha larga parte della sua base sociale tra quegli operai. Chiamparino, che
per tutta la prima fase della crisi, non si è nemmeno fatto vedere
ai cancelli Fiat, è stato eletto anche da loro. Eppure Fassino è
riuscito solo a balbettare ai primi di ottobre di un polo Fiat-Opel e per
la sola semplice ragione che immaginava fossero questi i disegni di Agnelli.
Ma quando è risultato chiaro che non lo erano, o non lo erano più,
ha lasciato perdere e quando è andato a Termini Imerese non è
riuscito a dire una sola parola sensata che non fosse l'auspicio che la fabbrica
non chiudesse. Ma sul come impedirlo: nulla. Per il resto Fassino si
è preoccupato solo di affossare la possibilità di un intervento
pubblico che si era aperta tra l'11 e il 18 e che abbiamo descritto sopra.
Ecco cosa diceva ai giornali il 16: "il compito dell'esecutivo non può
essere quello del notaio, ma non per questo dev'essere quello di socio". Qualcuno
ha capito se Fassino aveva in mente un'idea? Noi no. E, supponiamo, nemmeno
i suoi elettori. I quali, dal punto di vista politico, gli unici personaggi
che hanno visto agitarsi (come abbiamo visto in modo vacuo e opportunista)
sono stati quelli di destra. Non
ci convince nemmeno l'ipotesi Fiom di un'entrata dello stato o delle regioni
nel capitale Fiat, magari insieme a GM e banche. La semplice acquisizione
di un pacchetto di azioni non garantirebbe affatto il rientro del disegno
di decadenza pilotata del settore auto, visto che il pallino rimarrebbe sempre
in mano a chi cerca profitto senza spendere soldi. La probabile fuoriuscita
di Gm inoltre, determinerebbe un notevolissimo investimento di denaro da parte
statale, che, a quel punto, non si vede perché dovrebbe lasciare la
gestione ad altri. E non capiamo cosa ci vuol dire Epifani quando afferma
che "sono favorevole a un ingresso dello stato ma solo come elemento di garanzia
dell'interesse generale che dovrebbe servire ad accompagnare un processo di
ricapitalizzazione" (La Repubblica 14 ottobre). Ci pare anche
questa un'affermazione estemporanea senza valenze pratiche. L'unica
proposta ragionevole in realtà è stata quella avanzata da Fausto
Bertinotti: la nazionalizzazione della Fiat. E non capiamo perché ci
sia stata gente che l'ha trovata divertente. Non è una proposta rivoluzionaria,
ma l'unica percorribile se si vuole salvare la Fiat. Infatti la Fiat auto,
come abbiamo visto sopra, va ad essere chiusa, perché sarà consegnata
già ultraridimensionata alla GM. Quindi è solo strappando
dalle mani delle banche, della GM e della stessa Fiat la gestione del suo
destino, che questo potrebbe mutare. Nel '76 Carli aveva pensato di trasferire
la Fiat, sommersa di debiti, all'IRI. Potremmo dire con ironia: realizziamo
il sogno di Carli! L'alternativa è solo una: credere sul serio al "piano
industriale" della Fiat. Del resto: basta trovarlo! Rifondazione
ha presentato un emendamento alla finanziaria in cui chiede l'acquisto della
Fiat al prezzo simbolico di un euro. Anche questa iniziativa è stata
presa come uno scherzo. E invece non lo è affatto. Lo stesso Galateri,
ridimensionandolo abbonantemente, afferma che in 25 anni la Fiat ha ricevuto
da aiuti dello stato 4,5 miliardi di euro, senza contare la cassa integrazione
e il regalo dell'Alfa Romeo. Secondo la Borsa la Fiat vale meno di 4 miliardi
di euro (La Repubblica 19 ottobre). Beh: lo Stato non farebbe altro
che riprendersi i suoi soldi. Penati sul Corriere del 21 ottobre: "oggi
probabilmete Fiat sarebbe felice di vendere l'auto al valore simbolico di
1 euro, con qualche miliardo di debiti in dote". E la ragione per cui non
lo fa è semplicemente dovuta alla speranza che, tagliando e ridimensionando,
la GM qualche soldino nel 2004 glielo dia. Inoltre:
in tutta la vicenda della gestione della crisi che abbiamo raccontato sopra
stupisce come la Fiat non solo abbia tenuto nascosti i suoi piani ai sindacati,
ma persino al governo e alle banche (che se ne sono pubblicamente lamentate
prima della pace di metà ottobre). Ebbene: come è possibile
che la sinistra ammetta che il destino di vita di decine di migliaia di persone
sia segreto? Come minimo si dovrebbe esigere la totale pubblicità
dei libri contabili, delle manovre, degli accordi, dei verbali, della Fiat.
Ciò va contro gli interessi Fiat? Vero, ed esattamente per questo va
a favore degli interessi operai. Quello
che manca agli operai per prima cosa dunque, è una proposta di fuoriuscita
dalla crisi. E questa non può che essere una: strappare la Fiat
dal controllo di chi ne sta pilotando la fine. I
limiti della tattica sindacale Su
La Repubblica l'11 ottobre Eugenio Scalfari scriveva: "la crisi Fiat
rischia di provocare un'esplosione di rabbia sociale estremamente pericolosa
che andrà a sommarsi ad altre incertezze già presenti nella
società italiana: una disoccupazione giovanile endemica nel Sud, pensioni
d'anzianità a rischio, tutele fragili o addirittura inesistenti, servizi
sociali senza un soldo da spendere." Duole constatare che sino ad ora questa
esplosione non c'è stata. La dirigenza Fiat, le banche e il governo
non stanno dormendo sonni agitati, e Berlusconi, dopo il 16, si è potuto
permettere di ritirarsi dalla vicenda perché la rabbia sociale non
era poi così violenta da impensierirlo. C'è qualcosa nella tattica
sindacale che non va. Non
ci occuperemo ovviamente di Fim e Uilm, delle quali non scriviamo nulla per
non incorrere in qualche denuncia. Ci pare però che la tattica della
Fiom abbia dei limiti. Essa ha dato senz'altro sfogo alla voglia degli operai
di lottare, ma non sta articolando una lotta per vincere, perché
per vincere bisogna far male all'avversario. Ci spieghiamo, prima però
una premessa. Il
31 ottobre il Consiglio di Amministrazione del gruppo Fiat ha registrato il
record delle perdite della Fiat auto (tra luglio e settembre: 340 milioni
di euro), ma tutti gli altri settori vanno bene: l'Iveco ha dato il
14% in più di ricavi e l'8,3% di vendite in più, Fiat Avio ha
aumentato l'utile operativo di 154 milioni di euro nei 9 mesi di quest'anno.
Alessandro Penati sul Corriere riferisce che nella difficile congiuntura del
primo semestre di quest'anno le attività industriali (auto esclusa)
comprendenti aviazione, macchine agricole e per costruzioni, autocarri, automazione,
servizi alle imprese, componenstica hanno prodotto 30 miliardi di ricavi e
600 milioni di risultato operativo (dati annualizzati). Penati calcola che
con parametri europei (25% del fatturato o 11 volte gli utili prima delle
imposte e degli oneri finanziari) queste attività valgono circa 7 miliardi.
Ci sono poi 7 miliardi di partecipazioni (Italenergia, Fidis, Ferrari, ecc.),
3,5 miliardi di attivita liquide, 18,7 miliardi di crediti finanziari, ecc.
Insomma: "immaginando che l'auto sia ceduta a costo zero, il totale delle
attività è 36,2 miliardi di euro". Mica
male. Se pensiamo poi all'Ifil allora troviamo interessi nella carta (Burgo),
nella grande distribuzione (Rinascente, Auchan), nel turismo, nella finanza… Cosa
vogliamo arrivare a dire? Che ci sembra comprensibile ma inutile fare scioperare
gli operai di Termini Imerese e di Arese, perché tutto sommato, se
lavorano o no, ad Agnelli poco importa. Agnelli deve essere colpito dove
guadagna. Paradossalmente, ma non tanto: si deve bloccare l'Iveco per
salvare Termini. Si deve fare come in Germania quando in occasione del contratto
non vengono fatte scioperare tutte le fabbriche, ma solo alcune, strategiche,
che ne bloccano a catena altre. E gli operai coinvolti vengono risarciti con
casse di resistenza. La Fiom e la Cgil hanno la possibilità concreta
di farlo, devono però mettersi nell'ottica di far perdere dei soldi
ad Agnelli. E ce n'è anche per quelli che operai Fiat non sono. Il
movimento no-global ad esempio potrebbe momentaneamente sospendere le sue
agitazioni contro MacDonald e le campagne contro Nike e affini e concentrarsi
sulle aziende che vanno bene degli Agnelli: boicottare la Rinascente
ad esempio, o Alpitour. Non
vediamo all'orizzonte altre alternative. Dispiace, ma anche quella prospettata
dalla segreteria del SinCobas con un intervento su Liberazione (29
ottobre) ci pare debolina: partecipare in massa al Forum Europeo di Firenze
per "euopeizzare le lotte". Ma che vuol dire? E' uno slogan consolatorio,
privo di risvolti concreti. Vorremmo sapere quanti sono gli operai di Termini
che andranno a Firenze. La
domanda è una sola: si vuol vincere o no? Se si vuol far testimonianza
si continui pure a scioperare senza obiettivi in testa e senza far danni veri
e lanciamoci pure in infiammati discorsi nei seminari di Firenze. Ma se si
vuol vincere si deve colpire Agnelli nel portafogli, perchè solo colpendo
sul serio il profitto anche gli altri attori, GM, banche e governo, saranno
costretti a intervenire. Altrimenti non cederanno. NOTE (1)
Gli esuberi sarebbero così distribuiti: Mirafiori (Torino)
1.000
(su 9.900 dipendenti) e 350 tra Comau e Magneti Marelli (da luglio 1.700 lavoratori
di Fiat Auto e 300 di Comau), Cassino (Roma) 1.200 (su 4.500 dipendenti),
Arese (Milano) 1.000 (su 2.000), Termini Imerese (Palermo) 1.800 (su 1.900
dipendenti). Non sono toccati i 5000 lavoraotri di Pomigliano d'Arco (Napoli)
e i 5000 di Melfi (Potenza). (2)
al 30 giugno i debiti finanziari lordi erano di 32.900 milioni (3)
il
piano anticrisi si fondava su quattro punti: impegno a ridurre da parte di
Fiat entro l'approvazione del bialancio 2002 l'esposizione finanziaria netta
a 3 milardi di euro dai 6,6 originari anche attaverso dismissioni (alcune
già operate
il 40% di Europ Assistance andata a Generali, la Teksid alluminio andata a
Jp Morgan e al fondo Questor, il 34% della Ferrari a Mediobanca),
la disponibilità a sacrificare altri asset in caso di scostamento dagli
obiettivi, cessione alle banche del 51% di Fidis (società di credito
al consumo), rifinanziamento da 3 miliardi erogato subito dalle banche a garanzia
di un aumento di capitale di pari importo da varare entro un triennio. Il
prestito è così ripartito in milioni: 650 Banca Intesa, 625
Unicredito, Capitalia 425, Sanpaolo 400, Montepaschi 300, Bnl 300.
Le banche hanno
rilevato a un prezzo generoso il 14% di Italenergia, portando così
la quota Fiat
al 24,6%. La Fiat ha così incassato 1.700 milioni di euro che sono
andati a ridurre il debito (cioè sono andati alle banche). (4) (5)
Nel capitale Volkswagen il Land della Bassa Sassonia detiene il
13,7% con
golden share che le dà diritto di veto (per scoraggiare investitori
stranieri