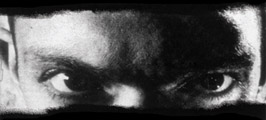

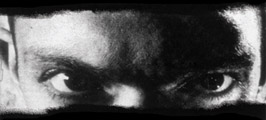

Lo spazio locale è oggi il terminale delle contraddizioni più intense del nostro tempo. L’alterazione dell’ambiente compromette il futuro e l’integrità dei corpi dei singoli; lo spazio pubblico nazionale si dissolve, diviene una dimensione immaginaria senza esser più uno spazio dell’immaginario. L’unico potere sociale che ancora forma a sua immagine e suo destino i territori è quello economico. È chiaro, quindi, che l’azione del cambiamento estremo si colloca in dinamiche nuove e profonde, molecolari, ed in altre geografie.
Come cambiare, pur essendo privi di potere? Non ci interessa prendere il potere; governare è già un atto di asservimento e la sua attitudine a disciogliere la radicalità delle intenzioni è ben sperimentata.
Nella dirompente crisi di legittimità delle istituzioni democratiche europee, che l’Italia ha forse anticipato, cosa dà ancora alle forme di potere la legittimazione ad operare su delega della popolazione? Essa è data dall’ipotesi che di esse si possa fare un buon uso, che siano anche una chance di poter fare ciò che ai singoli sarebbe impedito dalla grandezza delle cose. La crisi italiana dimostra però irrefutabilmente che vi può essere, insieme, una grande necessità di fare ed una fantasiosa invenzione di "riformatrici" forme di potere senza che si giunga a risultati significativi, od anche solo a produrre un surrogato di ciò che potrebbe realizzare la ragionevole e libera associazione dei singoli attraverso le comunità: la questione è quella delle forme di convivenza e della scelte degli obiettivi sociali e non la palingenesi per mezzo di legge elettorale semimaggioritaria a doppio turno, o meno.
Nelle fasi di crisi la possibilità di fare, e di non fare, insieme a quella di distruggere spiazza le istituzioni intermedie e rifluisce, caricandole di potenza, da una parte nelle collettività locali (come ad esempio durante le rivolte municipali, rurali o urbane, avvenute prima dell’industrializzazione), nelle quali ci si deve pur organizzare e per le quali l’autonomia risulta una necessità per viver bene, per restituirsi la voce e partorire discorsi. Dall’altra, ridà forza ai sovrapoteri (come ad oggi si legge in trasparenza nel concetto di globalizzazione), al comando dell’economia e degli ingegneri sociali.
I passaggi di crisi, ed a ben guardare ogni momento può caricarsene, mostrano sempre chances di cambiamento, specifiche ed originali. Le nostre collettività sono oggi certamente ricche, intelligenti delle cose e competenti a sufficienza per porsi la questione di come giungere all’autogoverno: una scelta possibile per rompere la crisi proprio nel suo mezzo, arrestarla ed uscirne su una via nuova. Governo di sé che vuol dire controllo delle risorse e delle mete sociali, promozione dei singoli e dei beni comuni, radicamento della politica nei discorsi e nella compresenza tra cittadini.
A costruire qualcosa del genere riteniamo sia necessario un processo federativo a base municipale; e pertanto l’opzione che facciamo nostra nel conflitto politico è quella di una forma federale la cui unità di base non sia un territorio micronazionale (ad esempio quello regionale), o dalla scarsa carica di cittadinanza, con pura funzione rappresentativa; bensì la titolarità dei poteri e la fonte del diritto sia riferita ad un territorio umano e definito in base a ciò (il Comune, pensiamo all’etimo...) che si possa dare un "sapiente squilibrio" di democrazia diretta e rappresentativa, di potere fatto e potere-che-si-fa.
Il nostro invito è rivolto alla società in atto, nelle sue forme associative e cooperative, perché venga a costruire un utile dualismo dei poteri non procedurale ma essenziale, non recluso nella tripartizione del potere liberale, e che ponga da una parte quello costituito e dall’altra quello democratico e diretto, entrambi in inevitabile concorrenza, ma il primo legittimato solamente dalla piena vitalità del secondo.
Se è vero che nel Comune, nello spazio comune e relazionale più immediato, vi è la chiave per decidere della buona vita, è ugualmente nel territorio, attraverso le sue risorse materiali ed immateriali, che si svolgono i nuovi processi produttivi. Essi non fanno solamente uso di ciò che vi è presente, ma anche di ciò che vi si può attivare: l’intelligenza diffusa, la cooperazione tra i singoli e tra i gruppi, forme d’autotutela per imprese che vengono (più o meno correttamente) percepite come beni comuni. Quindi esse, le imprese di comunicazione e servizio alle persone, di sviluppo sociale, culturale ed ambientale, di forma associativa o cooperativa, ed anche le imprese for-profit che abbiano fatto una scelta di collaborazione con la collettività hanno la legittimità per essere dei tasselli di una democrazia diretta adatta ai tempi. Il modo in cui una tale costellazione di soggetti singolari e collettivi riuscirà a darsi luoghi in cui discutere (consulte, forum o altro) e coalizioni per cooperare e confliggere (coordinamenti autorganizzati, consorzi d’imprese politiche e sociali) è lasciato all’immaginazione attuale, ma anche ad i ricordi più ricchi e allo stesso tempo incompiuti che dalla storia è possibile estrarre, a forza.
Pertanto, sembra porsi nuovamente un interrogativo consueto per l’antagonismo sociale, in questo caso in relazione ai poteri locali: e cioè, collaborare o sabotare? Non è sufficiente negare ogni collaborazione per garantirsi una prassi ragionevolmente sovversiva, né, al contrario, può bastare forzare le differenze tra poteri vicini e lontani, per evitar di cadere nei meccanismi coattivi comuni ad entrambi. Fuori da questa paralizzante alternativa, può costituire una strategia mettersi sulla via che costruisce le istituzioni della democrazia diretta. Inserirsi nel potere locale, vicino, che più si avvicina al "poter fare" e sviluppare forme e processi di democrazia di base, diretta e continua. Forme che possano inventare nuove figure nella tradizione delle autonomie sociali e le cui linee di forza siano: