
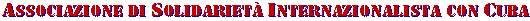

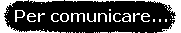

|
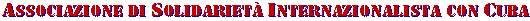
|
|
|---|---|---|

|
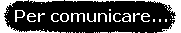
|
|

I - OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1 - Nella «Presentazione» dei Lineamenta, il cardinale Jan Schotte esprime la speranza che questi suscitino numerose osservazioni e suggerimenti. Indica che, alla fine del testo, si trova un questionario, allo scopo di agevolare questo compito, aggiungendo tuttavia: «Queste domande pertanto, e non il testo dei Lineamenta, devono essere la base di tutte le risposte. In tal senso, tutte le osservazioni devono fare esplicito riferimento alle domande formulate».
Stupisce il fatto che non il testo dei Lineamenta proposto alle Chiese e comunità delle Americhe, ma solo il questionario debba essere preso in considerazione. Nei Sinodi precedenti, come quello sulla Vita Religiosa, l'accento era posto sui Lineamenta e il questionario alla fine era intimamente legato al corpo del testo. È a causa di divergenze tra coloro che hanno preparato i Lineamenta e coloro che hanno posto le domande che ora questi elementi appaiono del tutto dissociati? Si invita persino il lettore, per lasciare interamente da parte i Lineamenta, a concentrarsi soltanto sulle domande e senza nemmeno fare riferimento al testo in sé e alla sua numerazione! Qual è la relazione tra l'uno e l'altro elemento e quale allora il ruolo dei Lineamenta?
2 - La nota aggiunta alla «Presentazione», a pagina 3, giustifica il titolo di Assemblea Speciale per l'America e non di Assemblea Panamericana o Intercontinentale, con l'argomento che si intende trattare i problemi comuni all'America del Nord, Centrale e del Sud e ai Caraibi, senza voler ignorare le differenze culturali, sociali e storiche che li distinguono. Questa prospettiva impedisce, d'altro canto, di identificare l'elenco non solo delle convergenze, ma anche delle differenze, delle tensioni e dei
conflitti che esistono tra Nord e Sud. Alcuni di questi problemi ci sono da lunga data, come i conflitti commerciali, la discussione sul commercio delle armi e il traffico di droga, l'embargo di Cuba, la presenza di basi militari a Panama, Cuba, Porto Rico, o l'appoggia alle dittature negli anni '70, gli interventi militari e le guerre di bassa intensità in America Centrale che hanno finito per opporre, su questo e altri temi, gli Stati Uniti ai Paesi a sud del Rio Grande (confine tra USA e Messico, ndt).
- OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
3 - Il Concilio Vaticano II, a proposito dell'istituto del Sinodo, afferma: «Questo Sinodo, rappresentando tutto l'episcopato cattolico, allo stesso tempo è un segno che tutti i Vescovi sono partecipi in comunione gerarchica della sollecitudine per la Chiesa Universale (CD 1022)». È espressione della sollecitudine dei vescovi per tutte le Chiese e valido aiuto al Pastore Universale della Chiesa (CD 1022): «Come legittimi successori degli Apostoli e membri del Collegio Episcopale, i Vescovi sappiano essere uniti tra di loro. Si dimostrino solleciti di tutte le Chiese, giacché per divina istituzione e comando, ognuno di essi, insieme con gli altri Vescovi, è responsabile della missione apostolica della Chiesa» (CD 1023).
In un evento come il Sinodo, che riunirà vescovi dalle Americhe, convocati dal Papa, essi eserciteranno, in modo concreto ed eccelso, la collegialità (LG 51-56), come successori del Collegio Apostolico, nel magistero e nel governo pastorale (CD 1020-1021).
Perché i Lineamenta evitano accuratamente ogni e qualsiasi riferimento a questo esercizio della collegialità episcopale, in comunione con il Romano Pontefice? Mai la collegialità viene evocata come motore e radice dell'attività sinodale e come cammino per la comunione e la solidarietà nelle Americhe. Perché nel testo non si parla delle Conferenze episcopali come luogo privilegiato per conseguire, nella Chiesa, la «comunione episcopale», o delle Conferenze episcopali e del CELAM come strade concrete per raggiungere la sospirata solidarietà tra le Chiese, uno degli obiettivi principali di questo Sinodo?
4 - Il Sinodo costituisce un aiuto reciproco tra le Chiese e un aiuto da parte di queste al Romano Pontefice. Esaminando le citazioni che supportano le proposizioni dei Lineamenta, constatiamo che le 79 citazioni del documento, contenute in 74 note a piè di pagina, sono così distribuite:
3 dei Padri della Chiesa: Sant'Agostino (17), Leone Magno (23), Lettera a Diogneto (37); 19 del Concilio Vaticano II (9 da LG, 4 da GS, 4 da UR, 1 da SC); 3 del Catechismo della Chiesa Cattolica; 6 della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede; 1 della Congregazione per l'Educazione Cattolica; 1 della Pontificia Commissione «Iustitia et Pax»; 1 di Pio XII; 1 di Giovanni XXIII; 4 di Paolo VI; 39 di Giovanni Paolo II; 1 del Comunicato dei Vescovi responsabili delle Commissioni dottrinali delle Conferenze episcopali dell'America Latina - Guadalajara - Messico (6-10 maggio 1996).
5 - Di queste citazioni, 19 sono prese dal Concilio Vaticano II, metà (39) dal magistero di Giovanni Paolo II, altre sei dai suoi diretti predecessori, Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI e altre otto da organismi della Curia romana, per un totale di 53 su 79, ossia due terzi del totale. Soltanto una citazione fa riferimento al comunicato di una recente riunione dei responsabili delle Commissioni Dottrinali delle Conferenze Episcopali dell'America Latina. Fa impressione anche la scarsa attenzione dedicata alla grande tradizione dei Padri della Chiesa, ricordata appena tre volte.
6 - In un documento che vuole riflettere le questioni urgenti nella vita delle Chiese dell'America Latina e dei Caraibi, degli Stati Uniti e del Canada, perché non ascoltare la voce di queste Chiese nel ricchissimo magistero dei suoi vescovi, delle sue conferenze episcopali e delle grandi Conferenze Generali dell'Episcopato Latinoamericano che hanno segnato la vita e la storia delle Chiese del continente negli anni del post-concilio? Perché non lasciare avvicinare al documento il clamore degli impoveriti, il grido degli esclusi, degli indigeni, degli afroamericani, dei contadini senza terra, dei disoccupati, delle donne, dei pensionati, dei giovani e di tante e tante voci fatte tacere? Sarà che non si deve prestar orecchio al loro clamore? Sarà che la voce di nessuna Chiesa del continente è considerata adeguata ad esprimere le sofferenze e le angustie, le speranze e le ansie dei popoli del continente? Si tratta di una deliberata squalifica del magistero episcopale canadese, nordamericano, caraibico e latinoamericano, anche in momenti tanto solenni e decisivi come Medellín, Puebla, Santo Domingo, a favore di un unico magistero e di una unica voce qualificata, quella del Romano Pontefice e degli organismi della Curia che occupano più dei due terzi delle citazioni? Non si tratta, in sostanza, della negazione della funzione e del magistero del collegio episcopale, mai citato nei suoi pronunciamenti nel testo dei Lineamenta? Che cosa andranno a fare le Chiese al Sinodo, se già nella preparazione la loro voce è ignorata e il loro magistero soppresso? Se non è questa l'intenzione, qual è la ragione di questa deliberata marginalizzazione ed esclusione della voce e del magistero delle Chiese del continente? Quando Giovanni Paolo II, nella sua enciclica «Ut unum sint», supplica che lo si aiuti a ripensare la funzione del primato nella Chiesa, affinché possa essere aiuto e non ostacolo all'unità tra le Chiese cristiane, fa parte di questa necessaria revisione il recupero della figura petrina come parte del collegio apostolico, nel rispetto della uguale dignità e responsabilità degli altri vescovi, nella universale sollecitudine per le Chiese e nel profondo rispetto per la dignità e la responsabilità delle Chiese locali. È del resto ciò che afferma la «Ut unum sint»: «Quando la Chiesa cattolica afferma che la funzione del Vescovo di Roma corrisponde alla volontà di Cristo, essa non separa questa funzione dalla missione affidata all'insieme dei vescovi, anch'essi 'vicari e legati di Cristo' (LG, 27). Il vescovo di Roma appartiene al loro "collegio', ed essi sono i suoi fratelli nel ministero».
Non è offendere tutte le Chiese del continente e i loro pastori abbassare la loro voce e sopprimere l'espressione della loro fede, della loro esperienza e dei loro aneliti?
7 - Non sarebbe il momento per le Chiese dell'America del Nord, dei Caraibi e dell'America Latina di rispondere, con audacia e profezia, alla chiamata del Vescovo di Roma a ripensare l'esercizio della funzione petrina, assumendo in profondità la responsabilità collegiale che le unisce al Papa, nella comune sollecitudine per la Chiesa del continente e per la Chiesa universale? Un'espressione ben concreta di questa necessaria profezia è mantener viva la tradizione delle precedenti conferenze episcopali del continente, che insieme al Papa, furono pienamente deliberative. Per Medellín, Paolo VI venne al Congresso Eucaristico di Bogotà, pronunciando in quell'occasione, come gesto conclusivo della sua visita, il discorso di apertura della II Conferenza. Alla fine di questa, (Paolo VI) si aggiunse al magistero dei Vescovi Latinoamericani, approvando e raccomandando le Conclusioni di Medellin. Lo stesso ha fatto Giovanni Paolo II, aprendo le Conferenze di Puebla e Santo Domingo, e approvando allo stesso modo le loro conclusioni. Non sarebbe un servizio a tutta la Chiesa se il Sinodo d'America, in piena comunione con il Vescovo di Roma, ma anche nel rispetto dell'autonomia e della dignità delle Chiese locali e della collegialità episcopale, fosse pienamente deliberativo e non solo consultivo? In più, dal punto di vista ecumenico, questo atteggiamento segnalerebbe, concretamente, la volontà espressa da Giovanni Paolo II, di camminare verso un dialogo più profondo con le altre Chiese cristiane, intorno al ministero petrino dell'unità, esercitato in maniera sinodale. Solo nel quadro di una maggiore sinodalità e collegialità saranno create le condizioni concrete per una maggiore comunione ed unità tra le diverse Chiese cristiane. Sarebbe un passo indietro se il Sinodo d'America rompesse con la tradizione, già consacrata nel continente, delle Conferenze Generali dell'Episcopato, con carattere deliberativo e non di Sinodi, solo consultivi. Questo cambiamento aiuterebbe anche a ripensare i Sinodi che, secondo l'originaria ispirazione conciliare, erano stati sognati come passo verso una direzione più sinodale e collegiale della Chiesa tutta. Il desiderio espresso da molte conferenze episcopali che i sinodi siano deliberativi, fu presentato da dom Aloísio Lorscheider nell'VIII Sinodo dei Vescovi, svoltosi nel 1990, dal 29 settembre al 29 ottobre.
8 - Con Medellin, Puebla e Santo Domingo, si è aperta la feconda prospettiva di chinarsi sulla storia e di recuperare la memoria dell'evangelizzazione passata, come passo imprescindibile per analizzare il presente e delineare le responsabilità future in questo ambito. Afferma Medellin: «La Chiesa ha cercato di comprendere questo momento storico dell'uomo latinoamericano alla luce della Parola che è Cristo, in cui si manifesta il mistero dell'uomo. Questa presa di coscienza del presente si rivolge al passato. Nell'esaminarlo, vede con gioia l'opera realizzata con tanta generosità ed esprime la sua gratitudine a tutti coloro che hanno tracciato i solchi del Vangelo nei nostri Paesi e che sono stati attivamente e caritativamente presenti nelle diverse culture, specialmente in quelle indigene». Puebla afferma: «La Chiesa ha ricevuto la missione di portare agli uomini la Buona Novella. Per realizzare efficacemente questa missione, la Chiesa sente il bisogno di conoscere il popolo latinoamericano nel suo contesto storico, nelle sue diverse, circostanze» (P. 3). I Lineamenta abbandonano questa prospettiva e non vi è un accenno neanche alla storia delle relazioni tra le Chiese del continente, sia in eventi sinodali, come i Concili Provinciali del periodo coloniale o il Concilio Plenario latinoamericano (1899), sia nei suoi organismi nazionali, le conferenze episcopali, o continentali come il CELAM (Consiglio Episcopale Latinoamericano), fondato nel 1955; e neppure alla già lunga storia di contatti tra gli episcopati dell'America del Sud e dei Caraibi con quelli del Nord, awiati su richiesta di d. Heider Cámara e con l'appoggio di Pio XII. Ai vescovi nordamericani d. Helder scriveva, alla fine degli anni '50: «Ciò che chiediamo è la vostra comprensione, è di studiare insieme i problemi che non sono semplicemente problemi latinoamericani, ma problemi di tutte le Americhe». Il primo incontro ebbe luogo nella Georgetown University of Washington, il 2 e il 3 novembre 1959, presenti sei vescovi dell'America Latina, sei degli Stati Uniti e sei del Canada, oltre all'inviato della Santa Sede, mons. Samoré. Un attento osservatore nordamericano commentava l'evento: «L'incontro di Georgetown è stato, di fatto, la pietra basilare per gli anni di sforzi ecclesiali interamericani che sono sbocciati negli anni '60 e che sono continuati negli anni '70». In Canada, l'Episcopato creò una Commissione Episcopale Canadese sull'America Latina (CECAL), incaricata di mantenere i contatti con l'episcopato latinoamericano attraverso il CELAM, oltre a dirigere una Pastorale Collettiva (13/01/1960) per i fedeli che trattava la cooperazione apostolica tra Canada e America Latina. Negli Stati Uniti fu creata dalla Conferenza episcopale una Segreteria per l'America Latina (Secretariat of Bishop's Committee for the Church in Latin America NBCC). A loro volta, la crescente presenza di immigrati latinoamericani e caraibici di lingua castigliana (messicani, cubani, dominicani, portoricani, rifugiati centroamericani, emigranti sudamericani) ma anche di lingua francese e creola (Haiti) e portoghese (Brasile) in seno alla Chiesa cattolica degli Stati Uniti, così come l'influenza pastorale e teologica delle Comunità di Base, della pastorale sociale e della teologia della liberazione venute dal Sud, hanno trasformato profondamente il volto della Chiesa cattolica negli Stati Uniti e, in misura minore, in Canada. Un impatto analogo ebbero i documenti delle Conferenze Generali dell'Episcopato latinoamericano riunite a Medellin, Puebla e Santo Domingo, sempre con la presenza di membri delle Conferenze episcopali degli Stati Uniti e del Canada. Ma non solo i grandi incontri di Medellín, Puebla e Santo Domingo hanno lasciato il loro segno. La Chiesa degli Stati Uniti ha prestato attenzione alla pastorale, alla teologia e al magistero delle Conferenze Episcopali latinoamericane, su temi tanto diversi come il rinnovamento pastorale e l'ecumenismo, l'ordine politico e la liberazione, la vita economica, il problema della terra, le aree urbane, la riforma agraria, i rifugiati, il traffico di droga, la guerra, il dialogo e la riconciliazione in America Centrale, la pace mondiale e le armi nucleari.
Questa storia fa parte del processo di riflessione e dei legami che si sono intrecciati tra Nord e Sud del continente. Non meno importante è stata l'effettiva solidarietà stabilita con l'invio di missionari diocesani e religiosi e missionarie, volontarie e volontari laici per le Chiese del Sud e con la realizzazione del fondo di aiuto per le Chiese dell'America Latina. Oggi queste Chiese contraccambiano, inviando operatori pastorali per assistere i loro immigrati e teologi e pastoralisti per i centri di animazione missionaria del Nord. -
8 - Sarebbe deplorevole che il recupero della memoria storica fosse eliminato dai documenti preparatori dell'Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per le Americhe. Nell'ambito della prassi, la CEHILA (Commissione di Studi di Storia della Chiesa in America Latina) ha stabilito una feconda cooperazione tra storici degli Stati Uniti, dei Caraibi e dell'America Latina, per scrivere insieme una Storia Generale della Chiesa in America Latina e nei Caraibi, includendo un volume sugli 'ispanici' negli Stati Uniti.
III - OSSERVAZIONI SPECIFICHE
9 - I Lineamenta si aprono con un denso capitolo dedicato all'incontro con il Cristo vivo oggi, presentato a partire dagli scritti di San Luca (Marco non è mai citato, Matteo una sola volta, Giovanni sei e Luca trentuno. Gli Atti degli Apostoli, anch'essi di Luca, sono citati altre trentuno volte). L'encomiabile insistenza sulla prospettiva cristologica corre il rischio di lasciare nell'ombra l'ineludibile carattere trinitario della fede cristiana e la cruciale importanza che assume la figura dello Spirito Santo, in questo fine secolo. È sufficiente guardare al movimento carismatico all'interno della Chiesa cattolica e delle Chiese sorte dalla riforma e all'assoluta centralità dello Spirito Santo nei movimenti e nelle Chiese pentecostali. Malgrado alcuni accenni allo Spirito, tipici della tradizione giovannea e lucana, resta l'impressione di un certo Cristo-monismo nella presentazione dell'annuncio cristiano.
10 - Nel corso degli ultimi anni, la Chiesa latinoamericana e caraibica è andata percorrendo, attraverso ricche esperienze ed una riflessione approfondita, i cammini di inculturazione del vangelo, della catechesi, della liturgia e della teologia e del modo di essere Chiesa-comunità, in mezzo ai popoli e alle culture del continente, in modo particolare quelle indigene e quelle afroamericane. Santo Domingo collocò, tra le priorità pastorali per gli anni a venire, accanto all'opzione preferenziale per i poveri, accanto al nuovo protagonismo dei laici, questo arduo processo di inculturazione del vangelo e della Chiesa nella moderna cultura urbana e dei mezzi di comunicazione di massa e nelle culture native e afroamericane del continente. La parola appare in molti dei discorsi del Papa, nei suoi incontri con gli indigeni dell'America Latina, nelle encicliche, come la 'Redemptoris Míssio', nei documenti della Santa Sede come quello su «Fede e inculturazione» della Commissione Teologica Internazionale, e quello sull'inculturazione della liturgia, nei documenti preparatori e nelle conclusioni del Sinodo Africano così come nell'esortazione post-sinodale di Giovanni Paolo II, «Ecclesia in Africa», relativa a quel Sinodo. Provoca sconcerto il fatto che i Lineamenta adottino, per esprimere questo movimento di incarnazione rispettosa del vangelo nelle culture, un nuovo concetto, quello di acculturazione (numeri 43, 45, 62). Il termine inculturazione, oltre alle sue radici nelle scienze sociali e antropologiche, ha già ottenuto qualificazione teologica e corso ecclesiale. Del resto, i due concetti non coincidono. Riconosciamo che il termine inculturazione può risultare strano nella tradizione sociologica nordamericana, ove regna l'«acculturation», ma il suo utilizzo nel campo missiologico, pastorale e teologico suggerirebbe di mantenerlo, poiché ha già ottenuto uno statuto proprio consacrato in documenti del magistero latinoamericano, africano, asiatico e pontificio.
11 - Dal punto di vista metodologico, i Lineamenta abbandonano una delle grandi intuizioni del Vaticano Il, chiaramente espressa nell'introduzione alla «Gaudium et Spes». Questa propone che la Chiesa si chini sui segni dei tempi in un ascolto attento e amorevole, per scoprire qual è il servizio che le viene chiesto: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, soprattutto dei poveri e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo» (GS 200). Il Concilio trasforma i 'segni dei tempi' in un 'topos' teologico, attraverso il quale Dio ci parla e ci interpella: «Per svolgere questo compito (del servizio agli uomini di oggi e alla loro salvezza), è dovere permanente della Chiesa scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. Bisogna, infatti, conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico» (GS 205).
I Lineamenta abbandonano questa metodologia, a favore di una proposta cristologica preliminare a qualsiasi ascolto di questi segni dei tempi nel continente, definendo in anticipo il messaggio che deve essere annunciato, senza interrogarsi su coloro che lo riceveranno e sulla realtà in cui si trovano immersi. Ciò impedisce di esercitare la saggia pedagogia di Paolo nell'areopago di Atene, nel cercare nell'orizzonte dei suoi uditori, nella loro pratica culturale, nella loro riflessione filosofica e nella loro letteratura le aspettative lì collocate da Dio. Paolo cerca nell'esperienza religiosa, nella filosofia e nella letteratura greche una strada e la porta di ingresso per l'annuncio evangelico (At 17, 16-31). Quest'attenzione non gli ha mai impedito di annunciare nei momenti opportuni e inopportuni «il Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani» (1 Cor 1, 23).
I Lineamenta ripetono questa inversione pregiudiziale, trattando dell'incontro con Cristo, ma anche dei processi di conversione, di comunione e di solidarietà contemplati nei punti 2, 3 e 4 del documento. Esprimono ancora un'incomprensibile repulsione verso il contributo che le scienze economiche, sociali e politiche potrebbero portare nella comprensione dei fenomeni e delle sfide della realtà che interpellano i cristiani e le Chiese nel loro compito di evangelizzazione liberatrice (n. 66). Non è questo il linguaggio del Concilio, che saluta con gioia tutti i contributi delle scienze, della tecnica e dell'ingegno umano, nell'impresa di conoscere la realtà dei segni dei tempi e di rendere comprensibili i meccanismi che impongono fame, miseria e disperazione a gran parte dell'umanità. Il Concilio non disprezza, analogamente, il contributo delle scienze e della tecnica, per ridurre la sofferenza umana e garantire lo sviluppo delle persone e dei popoli. La forte insistenza sul punto di vista dell'etica e sul riferimento al vangelo che orientano la parola della Chiesa, non la dispensa assolutamente da questa articolazione armoniosa e critica con le scienze, la tecnica e l'esercizio dell'attività politica, economica, sociale e scientifica, a favore degli uomini e del loro benessere umano e spirituale.
12 - Da questo disprezzo risulta lo scarso valore e la limitata portata delle analisi presentate nel documento. Sarebbero più evangeliche per il fatto di essere imprecise ed errate? Valga come esempio il numero 25 che parla candidamente di «sistemi economici organizzati d'accordo con meccanismi di interscambi commerciali in base a prestiti e interessi che generano debiti enormi e impediscono lo sviluppo dei popoli». In nessun punto del documento si dà un nome preciso all'attuale congiuntura economica, in cui è passata a regnare sovrana la cosiddetta "economia di mercato' sotto la proposta egemonica del neoliberismo e la dittatura degli accordi economici imposti dal FMI, dal BIRD e dal sistema finanziario internazionale. I termini "mercato", "neoliberismo' ed altri ancora che indicano in modo preciso il sistema economico che si è introdotto a livello mondiale, gettando nella disoccupazione, nell'esclusione, nella miseria e nella disperazione grandi masse latinoamericane e caraibiche, non appaiono mai nel documento.
13 - La mancanza di un'analisi più precisa fa anche sì che si disconosca completamente la spinosa questione della terra che riguarda le popolazioni indigene e la vita e la morte di milioni di contadini e di lavoratori rurali senza terra. Il tema della terra è stato oggetto di centinaia di documenti e di lettere pastorali di vescovi e di interi episcopati del continente, e occupano un posto centrale nelle riflessioni pastorali di Medellin, Puebla e Santo Domingo.
14 - Dal punto di vista ecclesiale, quando si parla di agenti tanto dì conversione, come di comunione e di solidarietà, sono indicati la famiglia, la parrocchia, le comunità religiose, i movimenti laicali, la Chiesa particolare in sé e, in relazione con altre Chiese particolari (22) o il focolare domestico, la parrocchia, la scuola, l'università (25) o ancora la famiglia, la vita consacrata, i sacerdoti, i laici (32), i teologi (33), i vescovi (36), i laici (38).
In questo elenco vi sono alcune incomprensibili omissioni Non si fa cenno delle centinaia di migliaia di comunità ecclesiali di base, Chiesa dei piccoli e dei poveri, sorretta dalla parola di Dio letta e celebrata comunitariamente, con serietà, fede, vita ed impegno sociale e politico, in cui si celebra in maniera sempre più inculturata. Esse non si confondono semplicemente con le parrocchie. Paolo VI le saluta nell'Evangelii Nuntiandi come «speranza della Chiesa» in America Latina nel processo di evangelizzazione del continente (EN 58). Puebla le indica come elemento di comunione, partecipazione, solidarietà e ricerca di giustizia, evangelizzazione e missionarietà della Chiesa (P. 617-629) e Giovanni Paolo Il ripete gli stessi concetti nella sua enciclica Redemptoris Missio,
«Un fenomeno in rapida crescita nelle Chiese giovani, promosso dai Vescovi o anche dalle Conferenze Episcopali, a volte come opzione prioritaria della pastorale, sono le comunità ecclesiali di base (CEB, conosciute anche con altri nomi), che stanno fornendo buone prove come 'centri di formazione cristiana e di irradiazione missionaria. (... ) Tali comunità decentralizzano e contemporaneamente articolano la comunità parrocchiale, alla quale restano sempre unite; si radicano negli 'ambienti semplici dei villaggi, divenendo fermento di vita cristiana, di attenzione agli l'ultimi", di impegno nella trasformazione della società.
Il singolo cristiano fa in esse un'esperienza comunitaria, in cui si sente proprio un elemento attivo, stimolato a offrire la sua collaborazione per il bene di tutti. In questo modo, esse diventano strumenti di evangelizzazione e di primo annuncio, proprio come fonte di nuovi ministeri; in quanto animati dalla carità di Cristo, offrono un'indicazione circa il modo di superare divisioni, tribalismi, razzismi» (n. 51).
15 - Non sono nemmeno menzionate, in alcun punto, tutte le pastorali che hanno tentato di essere, nel post-Concilio, risposte creative e coraggiose alle nuove sfide della realtà: la pastorale della terra, della donna emarginata, degli indigeni, dei bambini e delle bambine di strada, dei senza tetto, dei senza terra, la pastorale operaia e della gioventù, degli immigrati, la pastorale dei neri e dei nomadi. Nulla di tutto ciò è visto come agente di conversione, di comunione e di solidarietà.
Viene anche sistematicamente ignorata la ricchezza della testimonianza, giunta molte volte sino al martirio, della vita religiosa inserita negli ambienti più poveri, in piccole comunità di condivisione e solidarietà. Non si parla dei laici nelle loro organizzazioni come catechisti e delegati della parola, come animatori di centri di diritti umani, come partecipi delle responsabilità ecclesiali nelle CEB, nei consigli parrocchiali e diocesani, nel Consiglio Nazionale dei Laici, attivi nei movimenti e nelle iniziative apostoliche all'interno della Chiesa e della società.
16 - Si disconoscono, così, accanto agli individui, le loro organizzazioni che, strutturate, permettono di agire e di intervenire. Accanto alla famiglia, non sono ricordati ì movimenti familiari. Quando si parla dei giovani, non si menzionano le pastorali della gioventù o i movimenti giovanili. Quando si parla dei religiosi e delle religiose, sono omesse le Conferenze nazionali dei religiosi e delle religiose, così come la CLAR (Conferenza Latinoamericana dei religiosi); quando si parla dei teologi non si fa cenno del loro servizio pastorale e della loro funzione ecclesiale. Si sfiora appena il tasto del dissenso rispetto al magistero (33). Non sono ricordate le loro organizzazioni nazionali (nel caso del Brasile, la SOTER) o continentali (la sezione latinoamericana dell'Associazione Ecumenica dei Teologi del Terzo Mondo - ASETT) e la loro produzione teologica al servizio della Chiesa e dell'evangelizzazione. Quando si parla dei vescovi (36), in nessun punto si parla di ciò che li unisce e che permette loro di organizzarsi per prestare un servizio efficace e vivere, dal punto di vista teologico e pastorale, la loro collegialità: le Conferenze Episcopali e il CELAM.
17 - Nell'evocazione della santità nel continente, avrebbe potuto essere conferito un rilievo particolare alla santità del martirio degli ultimi decenni che ha riguardato a volte Chiese intere, come il Quiché guatemalteco, in cui laici e laiche, catechisti e delegati della parola, sacerdoti e religiose hanno tutti mescolato il loro sangue nella testimonianza del vangelo, della giustizia e della pace. In altri luoghi, la violenza ha ferito pastori accanto alle loro pecore, come l'arcivescovo Oscar Romero in Salvador e il vescovo Enrico Angelelli in Argentina, p. Rodolfo Lukenbeim con l'indio Simone, Bororo, in Brasile. La Chiesa di Roma, fondata sul sangue degli apostoli Pietro e Paolo, considera i suoi martiri a sua maggior gloria e non ha esitato a collocarli, prontamente, 'nel canone delle sue celebrazioni eucaristiche. L'America Latina attende il riconoscimento di questi suoi martiri, come l'eredità più preziosa dei suoi anni di sofferenza e di speranza. Essi sono i semi vivi della nuova evangelizzazione. I loro nomi meritano di figurare a fianco di quelli che si dedicarono alla prima evangelizzazione o che si santificarono negli altri campi delle virtù cristiane. Lì non dovrebbero mancare i nomi di coloro che si sono impegnati per la giustizia e la difesa della vita degli indigeni come Bartolomeo de las Casas, Antonio de Montesinos e tanti altri, ricordati a Puebia (P. 3). All'elenco che contempla nomi di santi e beati in Canada, Stati Uniti e Paesi ispanici del continente (n. 43) non si dovrebbe dimenticare di aggiungere i nomi di coloro che diedero testimonianza di santità in Brasile, come i beati José de Anchieta e Madre Paulina.
18 - Perché non riconoscere l'emergere, nel continente, di una riflessione teologica preoccupata dei poveri e della loro liberazione e che ha meritato due Istruzioni da parte della Santa Sede (Libertatis Nuntius - 6 agosto 1984 e Libertatis conscientia - 22 marzo 1986), quella teologia della liberazione che è stata considerata dal Papa, nella lettera ai Vescovi del Brasile, «non solo opportuna, ma utile e necessaria»? Negli ultimi anni, si è sviluppata anche una teologia femminista latinoamericana della liberazione, così come una teologia india, una teologia nera caraibica, nordamericana e latinoamericana.
19 - Non si è dato riconoscimento, nei Lineamenta, del ruolo cruciale svolto dalla lettura popolare della Bibbia. Essa è stata alimento nella vita delle comunità di base, del popolo cristiano in generale. Ha aiutato a veicolare sempre più la pietà popolare negli elementi essenziali della fede, a partire dalla vita di Gesù e dall'esperienza delle prime comunità, attraverso la frequentazione dei profeti e della lettura orante dei salmi. La Bibbia è stata anche la strada reale per l'incontro tra i cristiani di diverse Chiese e strumento originario nel percorso ecumenico.
20 - Il paragrafo dedicato alla donna (n. 39) avrebbe potuto ben restituire loro la parola, in un esercizio umile di ascolto di ciò che esse hanno da dire alla Chiesa; in un'accoglienza attenta dei loro doni, carismi e ministeri nella vita della Chiesa, nella celebrazione gioiosa delle meraviglie che Dio ha operato, attraverso esse, a favore del suo popolo e della sua Chiesa. Non dovrebbero disporsi, la gerarchia e i membri maschili della Chiesa al dialogo e alla ricerca paziente di riforme di quei punti nel loro agire, nel loro pensare e nel loro sentire, che non rendono giustizia alla dignità e al valore delle donne e all'eguaglianza fondamentale voluta da Dio per i suoi figli e le sue figlie? Non è chiamata, la Chiesa, a rivedere l'esercizio del potere e la concezione dei ministeri, in una grande apertura allo Spirito che continua ad agire nella storia? Il modo in cui è redatto questo paragrafo dei Lineamenta riflette più l'attaccamento al passato e alla lettera che allo spirito liberatore di Gesù e del vangelo e all'impegno verso il futuro dell'umanità e della Chiesa.
21 - I . bei numeri dedicati all'ecumenismo (42, 47, 63) restano come giustapposti a quelli dedicati al fenomeno delle 'sètte' (18, 28, 33, domanda 8 del questionario). Non si sarebbe dovuto evitare questa parola caricata di significato peggiorativo e di un certo disprezzo per la fede religiosa dei loro seguaci, sostituendola con qualche concetto equivalente, come quello di 'nuovi movimenti religiosi"? Non si sarebbe dovuto approfondire ciò che porta tanti cattolici a entrare in queste nuove Chiese? Non si sarebbe dovuto instaurare anche con i movimenti e le Chiese pentecostali un dialogo umile e rispettoso, nonostante le difficoltà esistenti?
22 - Nell'ambito ecumenico, poteva essere ricordata, a fianco del CCC (Carìbbean Council of Churches), nei Caraibi, la feconda esperienza del CONIC (Consiglio Nazionale delle Chiese Cristiane), in Brasile e nel campo evangelico, ma anche profondamente impegnato nel, dialogo ecumenico con la Chiesa cattolica in America Latina e nei Caraibi, il CLAI (Consiglio Latinoamericano delle Chiese).
23 - Nel numero 53 dei Lineamenta, quando vengono trattati i problemi sociali più urgenti e le loro cause, sono menzionati, benché mai utilizzati, alcuni dei documenti importanti della Chiesa latinoamericana: Medellin, Puebla, Santo Domingo; della Conferenza nazionale dei vescovi degli Stati Uniti, le lettere pastorali «Giustizia economica per tutti: la dottrina sociale cattolica e l'economia degli Stati Uniti» (1986) e «Principi morali e politici per la riforma del sistema del welfare» (1995), e della Conferenza episcopale del Canada: «I costi umani della disoccupazione» (1980). È un peccato che si lavori con una memoria unilateralmente selettiva, tralasciando di ricordare altri documenti di fondamentale importanza della Conferenza episcopale degli Stati Uniti. Documenti importanti per il metodo, per la rilevanza dei temi affrontati e per il coraggio delle affermazioni. Dal punto di vista metodologico è stata scelta la via della consultazione ampia e pubblica, sottoponendo il testo a successive redazioni che andavano includendo critiche, suggerimenti e diversi contributi al dibattito. Nel bel mezzo della corsa agli armamenti del governo Reagan, la Conferenza episcopale lanciò il dibattito sul disarmo, compreso il totale bando delle armi nucleari come eticamente inaccettabili per la coscienza cristiana. Roma prese le distanze dalla posizione dei vescovi nordamericani facendo dichiarare dal portavoce del Vaticano che questa era la posizione dei vescovi nordamericani e non della Santa Sede. Subito dopo, anche l'episcopato francese si pronunciò sul tema delle armi nucleari, difendendo la legittimità della Francia di possederle, nell'attuale contesto internazionale di «ricatto nucleare», come forma di «difesa della sua sovranità e dei suoi valori culturali e spirituali». Al tempo stesso, i vescovi francesi esortavano «tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà a cercare la pace per mezzo del dialogo e della comprensione umana». Questa posizione ricevette un non indifferente appoggio romano. La seconda lettera dell'episcopato nordamericano non menzionata nei Lineamenta aveva come tema le donne. Nella fase di discussione iniziale del documento, più di 75.000 donne avevano già inviato le loro risposte e i loro suggerimenti. Il modo democratico di affrontare temi urgenti, facendo appello alla partecipazione di tutti i cristiani e le cristiane e alla società in generale, può costituire una maniera proficua di progredire nelle questioni ecclesiali controverse ed essere ben più efficace della censura al dibattito e alla libera discussione. D'altra parte, il documento sulle donne è già, di per sé, una eccellente agenda per la discussione della tematica femminile nella Chiesa. Un terzo documento dell'episcopato nordamericano sul debito estero del Terzo mondo continua ad essere particolarmente rilevante per i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi e meriterebbe di essere incluso nelle fonti per l'elaborazione dei Lineamenta, o almeno di essere ricordato tra i contributi importanti per la ricerca della pace, della giustizia, dello sviluppo e del superamento delle ineguaglianze tra i popoli.
1) Questo documento cerca di suscitare osservazioni e suggerimenti per l'elaborazione dell'Instrumentum laboris del Sinodo, che si celebrerà dall' 8 novembre al 7 dicembre del 1997 a Roma. Il nostro obiettivo principale deve essere consigliare i nostri vescovi nella interpretazione dei Lineamenta affinché possano intervenire nelle differenti istanze di partecipazione alla preparazione del Sinodo.
2) In generale possiamo dire che i Lineamenta rivelano un orientamento nella Chiesa e una Teologia che è seriamente contraria al Concilio Vaticano Il e alle Conferenze dell'Episcopato latinoamericano a Medellín, Puebla e Santo Domingo. È necessario, per amore della Chiesa, prendere coscienza di questo problema e riferirlo ai vescovi. Nonché dare alcuni suggerimenti per poter a lungo termine superare questa situazione.
3) Il documento propone 4 temi di importanza fondamentale per la vita delle Chiese: 1 - l'incontro con Gesù Cristo vivente, 2 - il cammino per la conversione, 3 - comunità e 4 - solidarietà. Ogni tema è affrontato in una parte del documento. In generale possiamo dire che la prima parte dedicata a Gesù Cristo è positiva: buon fondamento biblico, si accentua la dimensione escatologica della Chiesa, centrata sulla resurrezione di Gesù, si evidenza il ruolo dello Spirito e della parola di Dio e, inoltre, il linguaggio è inclusivo (uomini e donne). È carente invece la dimensione del Gesù storico e del Regno di Dio; manca anche la relazione Chiesa-mondo. Mi sembra che, nonostante queste carenze, si possa lasciare questa prima parte come intesa fondamentale e rielaborare i temi della conversione, della comunione e della solidarietà da altri punti di vista.
4) Per quanto riguarda il metodo: il documento in generale trascura gravemente le mediazioni socio-politiche finalizzate all'analisi della realtà. Si sta pagando molto caro il fatto di aver abbandonato il metodo tradizionale della Chiesa latinoamericana: Vedere - Giudicare - Agire. Si cerca di analizzare la realtà storica unicamente attraverso i concetti di peccato-conversione, comunione e solidarietà, cadendo in una pericolosa tendenza fideista, quasi gnostica e fondamentalista. Il metodo è astratto, deduttivo e non permette di arrivare a conclusioni costruttive di orientamento pastorale.
5) Riguardo le fonti: il Concilio Vaticano II viene citato solo 7 volte direttamente e 11 indirettamente (con l'uso del "confronto"), Giovanni Paolo Il viene citato 20 volte e 19 sono i riferimenti indiretti; 6 volte compare la Congregazione della Dottrina della Fede, 3 il catechismo romano, ecc... Tuttavia, al di là delle statistiche, il Documento si allontana chiaramente dal Concilio Vaticano II, addirittura gli è contrario. È cosa buona utilizzare documenti del papa Giovanni Paolo II. Dovremmo fare un uso più scrupoloso di tutti i documenti del papa, specialmente della Tertio Millennio Adveniente e dei suoi documenti sociali. Non si citano una sola volta i documenti della tradizione della Chiesa latinoamericana (Medellín, Puebla, Santo Domingo). Se ne fa solo una lista al punto 53.
6) Ecclesiologia: qui si manifesta l'errore profondo del documento. L'ecclesiologia è verticistica e giuridica. Si ignora l'esistenza della Chiesa come Popolo di Dio, con il suo dinamismo profetico e la sua organizzazione in comunità di comunione. Ai punti 20 e 21 abbiamo la seguente scala gerarchica: Dio - Gesù Cristo - Chiesa - vescovi e «tutti gli altri membri del Popolo di Dio, presbiteri, religiosi, religiose e laici». Vige un riduzionismo spiritualista della vita cristiana e si svalorizza la presenza della Chiesa nel mondo (cfr, per esempio, il punto 22). Altrove si valuta positivamente il ruolo dello Spirito Santo nella Chiesa (punto 35). Non si riconosce l'esperienza delle Comunità di Base (CEBS) in America Latina. Sono nominati i martiri (43), però non sono riconosciuti i martiri attuali e vivi nella memoria del Popolo di Dio. Il modo di trattare le sètte è pericoloso (punto 61: non si scosta molto dal fondamentalismo musulmano di fronte alle minoranze cristiane nei Paesi arabi).
7) Ermeneutica biblica: si cita abbondantemente la Bibbia e questo è molto positivo, però l'ermeneutica non ha come soggetto il Popolo di Dio e non si realizza all'interno di un movimento profetico e kerigmatico nella Chiesa.
Si fa un uso teologico-accademico della Parola. Siamo molto lontani dalla Dei Verbum e dall'ultimo Documento della Pontificia Commissione Biblica sulla interpretazione della Bibbia nella Chiesa (aprile 1993).
8) I problemi sociali e strutturali sono menzionati positivamente. Tuttavia vige una visione troppo moralista dei problemi (manca la mediazione socio-analitica); si sottolinea correttamente la causa morale degli squilibri economici e sociali, però questo non dispensa da un'analisi profetica delle strutture e del peccato sociale, come fanno i profeti dell'Antico Testamento, e l'Apocalisse nel Nuovo Testamento (cfr capitoli 12/13/17 e 18). Si cercano soluzioni «non prima di tutto sociologiche e tecniche, ma evangeliche» (66). Giusto, però a condizione che non si metta la Chiesa al riparo dal mondo moderno cadendo in un fondamentalismo che abbandona gli strumenti scientifici e moderni necessari per una pratica profetica e pastorale adeguata. È assente il tema di Santo Domingo «La promozione umana, una dimensione privilegiata della Nuova Evangelizzazione» (Santo Domingo 159 e ss) e tutta la ricchezza accumulata nel continente della cosiddetta «Pastorale Sociale». Al punto 25, dove si menzionano le strutture sociali, non si dice nulla della globalizzazione e della ideologia neoliberista (qualcosa al punto 54).
9) Pastorale della Chiesa: si riduce alla trasmissione di fede e dei valori morali, alla dichiarazione di principi e postulati, a far conoscere i documenti della Chiesa, alla educazione migliore possibile dei ministri e dei laici, ecc... Tutte cose necessarie, ma non è una pastorale ecclesiale. Si ignora la pastorale come pratica della fede della Chiesa, con opzioni, strategie, organizzazioni specifiche e con orientamenti teologici e spirituali. Mancano le opzioni pastorali, così ricche e feconde della Chiesa latinoamericana, così come furono definite a Santo Domingo.
10) Non si affrontano i temi concreti della relazione dell'America Latina con gli Stati Uniti e il Canada, le emigrazioni verso il Nord; il mondo ispanico negli Stati Uniti; il mercato della droga nel Nord che incrementa la produzione di droga nel Sud, i mezzi di comunicazione dei Paesi ricchi del Nord, con la loro propaganda di violenza, di razzismo, di erotismo e di consumismi distruttivi, il problema del debito estero, delle multinazionali, della globalizzazione del mercato, del neoliberismo, ecc ...
Temi per le nostre riviste latino-americane
1) Riscattare la struttura teologica di base del Concilio Vaticano II, specialmente l'ecclesiologia (Lumen Gentium e Gaudium et Spes) e l'ermeneutica (Dei Verbum). Una sintesi da presentare come normativa, una realtà minima che non possiamo abbandonare, a rischio di peccare contro lo Spirito Santo.
2) Riscattare ciò che appartiene più propriamente alla migliore tradizione della Chiesa latino-americana, specialmente delle conferenze di Medellín, Puebla e Santo Domingo. Proprio questo deve essere il nostro apporto al dialogo con le Chiese del Nord.
3) Ricapitolare i documenti di Giovanni Paolo Il dell'ultima decade. Specialmente i punti più rilevanti per la situazione della nostra Chiesa. Questo magistero pontificio è trattato male nei Lineamenta.
4) Elaborare una Cristologia di base, che raccolga la tradizione teologica dell'America Latina. Riprendere soprattutto la Prima Parte dei Lineamenta (che è positiva) e da una nuova visione teologica rielaborare concretamente i temi del Sinodo della conversione, della comunione e della solidarietà.
5) Metodo Teologico: riflettere sui contenuti della rivelazione e della fede utilizzando mediazioni socio-analitiche; fare un'analisi profetica della realtà che non sia riduttiva, né fondamentalista.
6) Un articolo approfondito su globalizzazione e ideologia neoliberiste.
7) La dimensione pastorale della Chiesa latinoamericana. Recuperare le opzioni pastorali della Conferenza di Santo Domingo (e alcune anteriori).
8) Fare un'autocritica della riflessione teologica latinoamericana degli ultimi 30 anni, anche alla luce dei documenti pontifici e degli stessi Lineamenta. Questo ci aprirebbe meglio al dialogo e alla riconciliazione.
9) Importanti temi attuali:
Teologia della Liberazione della donna
Vangelo e Culture
Chiesa e Modernità
Lettura Comunitaria della Bibbia
Teologia dei Giovani
Ecumenismo
CEBS, Martiri, Profetismo, Religione Popolare, ecc.
10) Non tralasciare di fare un resoconto dei testi più positivi e profetici dei Lineamenta. Ce ne sono e possono essere molto importanti per il dialogo.