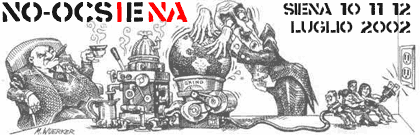[ Il Social Forum Amiata Fiora sull'acqua ]
[ HOME PAGE ] [ PROGRAMMA ][ APPUNTAMENTI ] [ I DOCUMENTI ] [ LINKS ]
NON SOLO ACQUA
Accompagnato dall'emblematico silenzio della stampa locale e da quello
delle varie Amministrazioni Comunali, anche in Provincia di Grosseto il
processo politico che porterà alla privatizzazione dell'acqua sta
arrivando al capolinea. Entro la fine del 2002, il 40% del pacchetto
azionario della s.p.a Fiora -attuale gestore unico del Sistama Idrico
Integrato di un territorio di 7.144 kmq nel quale vivono 352.000
cittadini, tutti quelli della provincia di Grosseto e 24 della provincia
di Siena- sarà ceduto ad un unico soggetto privato.
L'acqua, patrimonio dell'umanità, bene primario irrinunciabile, sarä da
quel momento considerato alla stregua di un qualsiasi altro prodotto,
una merce da cui trarre profitto, il cui valore, trasformato in prezzo,
sempre piu'vedremo comparire ed oscillare nei listini delle
contrattazioni di Borsa.
Chi ha deciso tutto cio', quale è stato il percorso `democratico' che ha
portato a simili conclusioni e, soprattutto, qual'è la visione sociale
che ha determinato decisioni di questo tipo?
Nonostante le odierne giustificazioni di alcuni amministratori di
centro-sinistra, non vi è stata, e a tutt'oggi non c'è, nessuna
direttiva Comunitaria che ha determinato o imposto gli scenari attuali.
E' stata invece approvata nel 1994 dal governo di centro-sinistra una
disposizione (la Legge Galli) -approvata all'unaninità dal Parlamento-
la quale, anche se formalmente definisce l'acqua un diritto e un bene
collettivo, di fatto, attraverso la prescrizione della costituzione
della società di capitali per gli organismi di gestione delle risorse
idriche, ha indicato la direzione di marcia verso la liberalizzazione
del mercato.
Una porta aperta a favore di quelle privatizzazione del servizio
pubblico acqua che oggi, il governo Berlusconi nell'art. 35 della
finanziaria del 2002 , ha prontamente recepito.
Che tutto cio' non sia una semplice interpretazione, lo si deduce
chiaramente dal disegno di Legge n.4014 del Maggio 1999, a firma
dell'allora presidente del Consiglio D'Alema.
Partendo dalla cosiderazione di come ``l'attuale assetto si caratterizza
per il rilievo con cui viene considerato il profilo della funzione
sociale dei servizi pubblici locali....sottovalutamdo pero' la valenza
economica e imprenditoriale dei servizi di erogazione di energia e gas,
di gestione del ciclo dell'acqua, dei rifiuti'', la nuova legge si
propone tra i suoi obbiettivi ``la creazione di un mercato aperto alla
concorrenza, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e
parità tra soggetti pubblici e privati, nel quale possono esprimersi
appieno le migliori capacità imprenditoriali''.
Sarà forse per questa illuminante progettualità sociale che, sempre a
partire dal 1999, sarà proprio la Toscana ad aprire ai capitali privati
la gestione dell'acqua. Un modello di riferimento per le future scelte
del centro-destra.
In sostanza già oggi, 37 Comuni della provincia di Siena e Arezzo, hanno
affidato la gestione dell'intero ciclo dell'acqua ad una miltinazionale
francese - la Lyonnaise des Eaux- la stessa che, in Argentina, ha
conquistato l'appalto dell'acqua potabile di Buenos Aires, alzando
enormememnte i prezzi e tagliando le forniture a centinaia di migliaia
di cittadini impossibilitati a pagare il servizio.
Imbottigliati nell'A.T.O
Il 15/12/2001, la Conferenza dei sindaci dei comuni dell'A.T.O 6
(circoscrizioni territoriali che hanno l'acua in comune, sono gli
organismi con cui la Regione Toscana ha suddiviso il territorio
accorpandolo in Ambiti Territoriali Ottimali), ha sottoscritto un
``accordo di programma'' con il quale impegna l'attuale gestore unico
-il Fiora spa- ha indire entro 12 mesi una gara per la cessione del 40%
delle azioni ad un soggetto privato. Il rimanente 60%, rimanendo
`pubblico', sarà suddiviso tra i Comuni senesi e grossetani che dell'Ato
6 fanno parte.
Possiamo immaginare come, a livello locale, queste decisioni siano state
prese.
Superficialmente, in zona cesarini, Giunte e consigli comunali, per non
rimanere fuori dal gioco, approvano protocolli d'intesa kilometrici e
apparentemente solo tecnici. L'intravvedere future possibili
monetizzazioni, è quanto basta loro per contribuire a fornire
quell'apporto al degrado profondo della vita politica e amministrativa
di queste comunità, ancora una volta fuori gioco.
Questo quanto meno è cio' che è successo nel nostro specifico: nessun
Consiglio Comunale si è aperto all'esterno, nessuna assemblea è stata
convocata, fosse solo per sentire il punto di vista della popolazione a
riguardo.
Il fatto è che la privatizzazione dell'acqua, in un contesto locale e
globale di mercatizzazione dell'intera vita umana, è un affare troppo
`sicuro' e lucroso per essere oggetto di dispute partecipative. Il
percorso che in base a questi piani condurrà alla privatizzazione,
contiene del resto, già nei suoi passaggi procedurali e nelle forme
concrete di attuazione, un deficit di democrazia significativo:
già nello stato attuale, la sostanza del gestore Fiora spa, prevede una
quota azionaria in proporzione alla popolazione di ogni singolo comune.
I comuni piu' piccoli sono evidentemente penalizzati, pur essendo quelli
dove sono dislocate le maggiri risorse idriche.
un collegio ristretto (Collegio di vigilanza sull'accordo di programma)
formato dai Sindaci di Grosseto, Siena e Massa Marittima, elaborerà il
bando e le procedure di gara, effettuerà la gara e stilerà la
graduatoria finale. In pratica, spetterà a questo collegio
l'individuazione e la scelta del privato che entrerà nella nuova società
per azioni.
I consigli comunali dovranno ``approvare l'accordo di programma, la
determinazione delle quote azionarie e la scelta del socio privato. Nel
caso di mancata approvazione, il Collegio procederà all'esclusione dei
comuni inadempienti dalla società di gestione ed attribuirà ai rimanenti
le loro quote''.
Un'analisi del ``Piano d'Ambito''nel quale sono delineate le strategie
d'intervento e il piano di investimenti dell'ATO 6, getta una ulteriore
luce sulla filosofia complessiva che muove il nuovo organismo.
Le linee guida sono cosi' sintetizzate:
-Integrazione delle fonti di approvigionamento ed incremento progressivo
correlato alla richiesta.
-ottimizzazione delle fonti di approvigionamento.
-riduzione graduale delle perdite, dal valore complessivo del 46%, al
valore medio del 21%.
Modulato su un arco temporale di 25 anni, il Piano d'Ambito,
individuando nella fatiscenza delle reti distributive una delle aree di
criticità maggiormente rilevanti (attualmente il volume complessivo
dell'acqua prelevato dalle diverse fonti risulta pari a circa 51.866.000
mc/anno; l'acqua fatturata all'utenza pari a circa 27.820.000 mc/anno),
enfatizza l'urgenza delle opere di ammodernamento e manutenzione delle
condotte idriche e cio', richiedendo una notevole mole di investimenti,
necessita dell'apporto di capitali.
Queste, assieme alla scelta già dal primo esercizio, di ``non ricorrere
al finanziamento esterno'' sono tra le principali motivazioni
dell'apertura al mercato del Fiora spa.
Il piano economico finanziario prevede infatti un capitale di
costituzione di 30 miliardi (in lire). I conti sono presto fatti.
Ipotizzando nel primo anno di gestione una offerta di acqua per l'intero
comprensorio di 50 milioni di mc al prezzo medio di 1935 lire al mc, si
realizza un introito di 100 miliardi. Stando a queste proiezioni (i dati
sono dell'Ato) l'apporto del socio privato è quantificabile in 12
miliardi (40% del capitale di costituzione), un contributo decisamente
esiguo ma comunque decisivo, questo si, per realizzare, a partire dal
primo anno di gestione, un bel rientro di denaro al capitale investito.
Una ottimizzazione economica perfetta, un bel modo di attrarre i
capitali e le capacità imprenditoriali nell'affare acquifero!
Viene da pensare che il contributo di 12 miliardi da parte del socio
privato, sarà indirizzato alla costruzione della nuova sede dell'ente
gestore, per la cui realizzazione è previsto uno stanziamento di 7
miliardi, a fronte di un investimento di 15 miliardi finalizzato alla
riduzione delle perdite.
Certo, niente a che vedere con gli scalcinati uffici comunali
dell'acqua, negli ultimi anni poco piu' che depositi per vetrini e
contatori ma, non siamo per nulla persuasi che il salto di
`qualità'consista nello sfarzo estetico e negli arredamenti ammiccanti
dell'attuale moderna sede del Fiora a Grosseto. Né, tanto meno, dai 56
addetti all'organizzazione `pensante' del servizio, tra staff e
dirigenti.
E' fuori discussione tuttavia che la gestione `pubblica' (in economia)
del ciclo dell'acqua si è concretizzata, in moltissimi casi, in una
lunghissima serie di sprechi, inadempienze e in una condizione
clientelare che, indifferentemente, ha dilagato dalla realizzazione
delle nuove utenze fino all'assunzione del personale di servizio.
Lavori di riparazione fermi per giorni e giorni per la mancanza di uno
scavatore o perché le finanze comunali, vuote, impedivano il semplice
acquisto di nuove condutture. Vuoto e smarrimento totale negli uffici
tecnici al pensionamento dell'ultimo operaio addetto all'acquedotto,
vera e propria memoria storia e patrimonio di conoscenze locali
sull'acqua. Poiché, è il caso di sottolinearlo, buona parte dei Comuni
sono del tutto sprovvisti di una banca dati in grado di fornire una
mappatura dettagliata della dislocazione delle fonti idriche quando, e
non sono i casi meno frequenti, non si è neppure in grado di indicare
con esattezza il pozzetto a cui allacciarsi.
La realtà quotidiana per paesi del grossetano quali Sorano, Pitigliano,
Manciano, è fatta quasi esclusivamente di rituali ordinannze le quali,
all'avvicinarsi dell'estate, impongono una sfilza di divieti e limiti
all'uso dell'acqua. Non rispettati e disattesi in massa.
E perché poi non annaffiare l'orto o lavare l'automobile quando è a
conoscenza di tutti la `storia' che racconta come, l'acqua del Fiora, da
giugno serve per irrigare i campi da golf di Punta Ala, e lavare i
panfili a Porto S.Stefano?
Non è questa quindi la dimensione pubblica che vogliamo difendere, ed è
sintomatico come oggi, tra i paladini di questa svendita, ritroviamo
coloro che, nel corso degli ultimi anni, hanno contribuito-per
inefficenza ed arroganza- al disastro della gestione diretta del bene
acqua: che si tratti di acqua per usi civili, termali, agricoli.
Certo che, cosi' come sta configurandosi, il passaggio ai privati
determinerà (e i casi di Arezzo e Chianciano lo confermano) una
amplificazione di alcuni dei tratti piu' negativi del recente passato.
Una società per azioni non è un istituto di beneficenza, per sua stessa
natura la sua azione è volta all'ottenimento del massimo profitto. E
allora, ci si preoccuperà sempre piu' di vendere la maggiore acqua
possibile (l'obbiettivo dell'ATO 6 è di portare l'attuale dotazione
media di 149 litri/ab. x g a 177 dopo i primi tre anni; a 185 dopo
tredici anni, ed a 210 dopo 20 anni), indirizzando i flussi nelle zone
dove, in base ai parametri relativi ai meccanismi tariffari, il prezzo
dell'acqua sarà piu' elevato.
Le innovazioni tecniche, nel Piano d'Ambito, sono tutte rivolte
all'ottimizzazione e alla crescita dell'offerta acqua, a scapito degli
interventi e degli incentivi mirati al risparmio delle risorse, nonché
alla prevenzione e `l'educazione' al consumo.
Non a caso, tra i fattori che possono determinare aumenti di tariffa,
mentre si prevedono le voci `ammortamento impianti' di una riserva
potabile inquinata ( se l'acqua fa proprio schifo, è difficle venderla),
non vi sono analoghe considerazioni riguardo le coperture dei costi
necessari per attuare interventi di prevenzione e salvaguardia,
Interventi, quest'ultimi, necessariamente da estendere sull'intero
territotio in cui si trova la risorsa idrica.
Di fronte a queste analisi, dove sono presenti solo alcuni degli
elementi caratterizzanti la strategia del Piano d'Ambito rivolta ``ad
un'attenta programmazione e pianificazione di una nuova iniziativa
imprenditoriale'', le giustificazioni degli amministratori, non reggono.
Solo la gestione dell'acqua, affermano, verrà privatizzata, rimarranno
pubbliche le proprietà delle reti distributive. Ma, a parte il pericolo
concreto, considerando la lunghezza delle concessioni di gestione, che
si perdano nella collettività le necessarie conoscenze e competenze per
gestire gli impianti (oggi ancora in larga misura affidati
all'esperienza pratica di personale locale), chi puo' scommettere-
stante i dilaganti orizzonti liberisti- sulla capacità e sulla volontà
del ceto politico di mantenere l'adeguato controllo sui privati?.
E, chi controllerà chi, se la legge individua nell'ATO l'organismo
preposto a questa vigilanza, visto che, paradosso
nell'assurdità,quest'ultimo dovrebbe controllare proprio chi lo finanzia
e che entra in società con un buon 40%?
In base a quali argomenti poi si afferma che solo attraverso la
privatizzazione il servizio diverrà efficiente, razionale, al passo con
i tempi? Non certo basandosi sulla situazione generale degli altri paesi
europei. Stati come l'Olanda, la Danimarca, la Svezia, operano tutt'ora
in regime di gestione diretta delle acque e, non vi sono disposizioni
dei governi verso la privatizzazione.
Non omogenea la realtà francese, dove gestione pubblica e privata
convivono, tanto che le stesse grandi multinazionali francesi, agiscono
e si arricchiscono, piu' all'estero che in casa propria.
La scelta della privatizzazione dell'acqua, in un panorama generale
contrassegnato dalle dismissioni pubbliche dei principali servizi
sociali è, fuori dalle righe, ideologia pura, applicata ad un modello di
sviluppo che consuma oltre che merci e prodotti, le stesse prerogative
essenziali della convivenza civile.
L'Italia, sesta potenza industriale del mondo, è il paese dove un terzo
dei cittadini non ha regolare accesso all'acqua potabile, con punte del
88,4% in Molise e Calabria, dell'82,4% in Campania, del 71% in Abruzzo.
Cattiva gestione delle risorse, eccessivo sfruttamento delle falde,
inquinamento, stanno, fin da adesso, restringendo le possibilità per le
collettività di attingere direttamente alle riserve idriche locali.
Non c'è dunque `solo' il problema della quantità, ma anche quello della
qualità dell'acqua.
Nel comprensorio dell'Amiata, (terra di mercurio e geotermia) dove si
trovano le sorgenti del Fiora, è urgente un monitoraggio popolare
autogestito il quale, sulla base dell'esperienza e delle lotte dei
minatori di Campiano per l'inquinamento del Merse, sia capace di
abbattere i muri di omertà e disinformazione intorno all'uso e allo
stato di qualità del fiume Fiora.
Dagli anni '60 l'ENEL ha intrapreso su questo territorio lo sfruttamento
intensivo della geotermia per la produzione di energia elettrica, con
conseguenze sull'ambiente e sulla salute dei cittadini coperte dalle
comparse istituzionali locali, da sempre succubi del potere e della
strafottenza dell'Enel Green Power. Su tutto questo, dati inoppugnabili,
ci dicono come dal'87 al '98 questo grande serbatoio delle riserve
idriche naturali per le province di Grosseto, Siena e Arezzo, ha perso
un terzo della sua portata (circa 10 milioni di mc all'anno). Quali le
possibili cause?
In una pubblicazione ufficiale dell'Enel del dicembre 1988 (`References
Notes on Geothermal Area Tuscany and Latium) in cui l'Amiata viene
considerata area di ricarica dell'acquifero regionale, quindi
idraulicamente collegato, si evidenzia come ``in quest'area, studi
idrogeologici e sondaggi hanno mostrato che il serbatoio geotermico è
localmente in contatto -attraverso camini vulcanici e faglie- con
l'acqua fredda contenuta nelle vulcaniti''.
Sulla falsariga di queste osservazioni, uno studio della Regione Toscana
datato 11/12/2001 presentato dall'Assessore all'Ambiente e Tutela del
Patrimonio Tommaso Franci, afferma come non sia da escledere ``che lo
sfruttamento geotermico in atto, con relativa riduzione delle pressioni,
comporti in aumento della ricarica, per altro difficilmente
quantificabile, a favore dell'acquifero regionale''.
In altre parole, riducendo la pressione nell'acquifero profondo, si
produce un travaso di acqua dall'acquifero superficiale che alimenta le
varie sorgenti naturali, all'acquifero profondo, sfruttato dall'Enel per
la geotermia.
Se a tutto cio’ aggiungiamo (come fa notare lo stesso documento
regionale) il rilevamento in alcune sorgenti di "problemi di
inquinamento,in relazione ai parametri tossici, da nitrati di
mercurio, la presenza di ferro maggiore della C.M.A nei pozzi e nelle
captazioni in galleria di miniera ad Abbadia S.Salvatore, la presenza
di arsenico in alcune sorgenti 11microgrammi/litro, il C.M.A è
10-", ce ne è a sufficienza per iniziare nel comprensorio
dell’Amiata e del Fiora, una battaglia ampia, che metta l’acqua al
centro del risveglio sociale delle comunità locali.
Forum Sociale Amiata Fiora