|

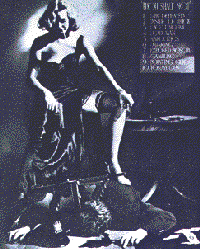 Il
primo elemento contestuale comune ai tre film è costituito dal
precedente letterario. Ritorno dal nulla è tratto dai
Basket-ball Diaries di Jim Carrol, Delirio e paura a Las Vegas
dal racconto di Hunter S. Thompson, e Trainspotting dal romanzo
di Irvine Welsh. Se ci si ricorda dell’adattamento del romanzo
di Nelson Algren L’uomo dal braccio d’oro (Otto Preminger,
1955), di Bright Lights, Big City (James Bridges, 1988), tratto dal
romanzo di Jay McInerney, o ancora del burroughsiano Pasto nudo (David
Cronenberg, 1991), i nostri tre film non fanno che confermare la regola
secondo cui un lungometraggio che tratti di droga deve necessariamente
basarsi su di un’opera letteraria, scritta da un fruitore esperto.
Lo scrittore tossicomane conferisce così legittimità (necessaria?)
al cinema della stupefazione. Di solito i registi negano di assumere
droghe anche quando lo fanno, perché ciò li mette in difficoltà
presso gli studios. Il rischio economico rappresentato da un regista
strafatto è enorme, mentre quello d’utilizzare l’opera
di uno scrittore tossicodipendente, qualche anno dopo lo scandalo, è
nullo. Hunter S. Thompson, Jim Carrol, Irvine Welsh (autore di Acid
House ed Ecstasy) sono senza dubbio degli specialisti in materia di
droga. Non si potrebbe dire altrettanto di Terry Gilliam, Scott Kalvert
e Danny Boyle. Ritorniamo al contesto dei tre film. In Ritorno dal
nulla siamo negli anni Sessanta con un eroe preadolescente, Leonardo
di Caprio. Delirio e paura a Las Vegas è ambientato nel
1971 e vede come protagonista Hunter S. Thompson, all’epoca trentaquattrenne,
interpretato da un Johnny Depp, più giovane di cinque anni. Infine,
in Trainspotting, l’azione si svolge ai nostri giorni, e
il personaggio di Mark «Rent-boy» Renton (Ewan McGregor) può
avere ventiquattro o venticinque anni. Il
primo elemento contestuale comune ai tre film è costituito dal
precedente letterario. Ritorno dal nulla è tratto dai
Basket-ball Diaries di Jim Carrol, Delirio e paura a Las Vegas
dal racconto di Hunter S. Thompson, e Trainspotting dal romanzo
di Irvine Welsh. Se ci si ricorda dell’adattamento del romanzo
di Nelson Algren L’uomo dal braccio d’oro (Otto Preminger,
1955), di Bright Lights, Big City (James Bridges, 1988), tratto dal
romanzo di Jay McInerney, o ancora del burroughsiano Pasto nudo (David
Cronenberg, 1991), i nostri tre film non fanno che confermare la regola
secondo cui un lungometraggio che tratti di droga deve necessariamente
basarsi su di un’opera letteraria, scritta da un fruitore esperto.
Lo scrittore tossicomane conferisce così legittimità (necessaria?)
al cinema della stupefazione. Di solito i registi negano di assumere
droghe anche quando lo fanno, perché ciò li mette in difficoltà
presso gli studios. Il rischio economico rappresentato da un regista
strafatto è enorme, mentre quello d’utilizzare l’opera
di uno scrittore tossicodipendente, qualche anno dopo lo scandalo, è
nullo. Hunter S. Thompson, Jim Carrol, Irvine Welsh (autore di Acid
House ed Ecstasy) sono senza dubbio degli specialisti in materia di
droga. Non si potrebbe dire altrettanto di Terry Gilliam, Scott Kalvert
e Danny Boyle. Ritorniamo al contesto dei tre film. In Ritorno dal
nulla siamo negli anni Sessanta con un eroe preadolescente, Leonardo
di Caprio. Delirio e paura a Las Vegas è ambientato nel
1971 e vede come protagonista Hunter S. Thompson, all’epoca trentaquattrenne,
interpretato da un Johnny Depp, più giovane di cinque anni. Infine,
in Trainspotting, l’azione si svolge ai nostri giorni, e
il personaggio di Mark «Rent-boy» Renton (Ewan McGregor) può
avere ventiquattro o venticinque anni.
È evidente che la giovane età degli attori, la loro notorietà,
le rispettive interpretazioni, hanno contribuito al successo delle pellicole
presso un pubblico giovane, se non addirittura giovanissimo. Di fatto,
siamo di fronte a tre racconti morali rivolti ai giovani, anche se ciò
appare paradossale nel caso di Delirio e paura a Las Vegas, che
sembra voler conciliare un pubblico che va dai più giovani fans
di Johnny Depp ai reduci degli anni psichedelici, oggi prossimi alla
sessantina.

Ritorno
dal nulla
La
ricostruzione dell’universo di Jim Carrol in Ritorno dal nulla
ha dato luogo a una seria ricerca della «misura», con un triplice
obiettivo: calibrare la personalità dell’eroe in modo che
il pubblico vi si identifichi, far confluire gli eventi della sua vita
in un’unica storia esemplare e, infine, addolcire il più
possibile i contorni delle scene di sesso raccontate nel suo diario.
Nel film, piuttosto che ritrovare i personaggi originali, per quanto
riguarda gli amici di Jim ci si deve accontentare di Mickey, che ne
riassume i tratti positivi, e di Pedro, che incarna tutti gli amici
pericolosi. I personaggi di Reggie e Neutron non hanno il loro omologo
nel libro. Questa redistribuzione dei ruoli è specifica di Ritorno
dal nulla, visto che gli altri due film ripropongono grosso modo
i personaggi originari. Il personaggio di Jim Carrol perde gran parte
del suo carattere, fino ad apparire come un patetico giocatore di basket,
mentre era una star nazionale. Il suo talento poetico è messo
in secondo piano, mentre, nel testo, riesce a farsi pubblicare fin dall’età
di sedici anni.
Il suo ruolo nella banda è relativamente banale, mentre nel libro
è chiaro che Jim è dotato di un potere carismatico. Alcune
scene sono state aggiunte per dare un’immagine di miseria: Jim
che vomita davanti a sua madre, la sua cacciata dalla squadra e lo sfottò
di una vecchia prostituta.

Delirio
e paura a Las Vegas
Delirio e paura
a Las Vegas si svolge in un fuori-contesto. Prima di tutto perché
Las Vegas è una non-città, e poi perché la corsa
di Raoul Duke è un non-evento. Se Duke e dr. Gonzo vanno a Las
Vegas, è soprattutto un’occasione in più per calarsi.
Non c’è solo la roba per provocare l’ebbrezza, ci sono
anche gli alberghi di lusso e gli spettacoli. Il legame tra la fascinazione
delle scenografie urbane e quella degli effetti dell’acido è
evidenziato in una scena in cui i motivi architettonici costituiscono
il punto di partenza delle visioni. È inutile domandarsi se Duke
e dr. Gonzo si droghino solo occasionalmente. Evidentemente si calano
anche a casa loro. Il breve viaggio in Delirio e paura a Las Vegas
appare così come una parentesi nella noia, un ultimo tentativo
di godimento fantasmatico nel momento in cui le utopie degli anni Sessanta
svaniscono.

 Trainspotting Trainspotting
In Trainspotting
si avverte l’influenza del cinema social-realista britannico, benché
Danny Boyle ne prenda abilmente le distanze. Il film riflette lo squallore
di un suburbio scozzeseÉ che l’eroina, a seconda dei momenti, rende
accettabile o intollerabile. L’ambiente è veritiero, potente
e quasi brutale come in Zola. Ma questo non riuscirebbe a giustificare
la tendenza del film a fare dell’eroina il capro espiatorio del
degrado. Come negli altri due film, lo sfondo politico è totalmente
eliminato. Peggio, il film rappresenta un mondo diviso in due, tra marginali
e cittadini integrati.
I tipi di droghe differiscono sensibilmente da un film all’altro.
In Ritorno dal nulla, troviamo, in ordine di apparizione, dello
smacchiatore da sniffare, cocaina, eroina, anfetamine che risultano
essere dei sedativi, poi ancora dell’eroina. In Delirio e paura
a Las Vegas c’è da perdersi con i mix, tanto che è
meglio riprendere l’elenco iniziale di Duke, posto in esergo: acido,
anfetamine, cocaina, etere, marijuana, mescalina, nitrato d’amile
(popper), tranquillanti. Infine, in Trainspotting ci si limita
all’eroina e ai suoi vari sostituti, che a loro volta costituiscono
una impressionante sequela. Aggiungiamo che questi cocktail sono più
o meno tutti mescolati a birra e talvolta ad alcolici strong, di cui
Duke è particolarmente amante. Quel che emerge da questi elementi
è, prima di tutto, la quasi totale assenza della cannabis e la
preminenza dell’eroina nei due film. La cosa sorprendente è
che, di fronte all’eroina, non si incontra mai il benché
minimo eroe.

Tra
decadenza e purificazione
Veniamo dunque ai risultati.
Delle due l’una: il regista dirige l’attore, e si ottiene
una rappresentazione di terza mano, o l’attore si dirige da solo,
e si ha diritto di aspettarsi almeno un’interpretazione convincente.
Nicolas Cage, per Via da Las Vegas (Mike Figgis, 1995), ha adottato
con successo la seconda soluzione. Idem Leonardo di Caprio. Johnny Depp
ha scelto d’imitare Duke nel pieno senso del termine, cioè
nei fatti. Ha passato sei mesi in casa sua a vivere proprio come lui.
Per quanto riguarda Trainspotting, per non caricare un solo attore
di tutta la tensione, Danny Boyle filma l’estasi sul volto dei
quattro personaggi. Gli attori del film riconoscono volentieri, considerando
il loro passato, di non aver avvertito l’esigenza di farsi di eroina
per girare il film. Johnny Depp, dal canto suo, ha il vantaggio di impersonare
Duke, e non un qualunque altro divoratore di acidi. Il problema non
è più quello di apparire credibile, bensì di creare
un atteggiamento coerente con i pensieri del personaggio sotto l’effetto
delle sostanze. Ne risulta che Johnny Depp recita la «para»
da maestro e riesce, assistito dal dr. Gonzo, a creare il malessere
che pervade progressivamente tutto il film.
Le droghe usate da Duke hanno come effetto d’insieme lo stravolgimento
del sistema nervoso. Al contrario, l’eroina di Jim e di Rent-boy
placa. Le une orientano il soggetto verso il futuroÉ Questa differenza
nel rapporto del soggetto col tempo si ritrova anche nel film. Tanto
in Trainspotting quanto in Ritorno dal nulla, si tratta
di rompere il circolo vizioso, perfino mortale, dell’eterno riciclaggio
del presente eroinomaniaco. Il che, nei due film, sfocia nella vecchia
dialettica tra decadenza e purificazione: quando Rent-boy si immerge
nel water della toilette, invece di annegare in un torrente di merda,
scivola in un’acqua azzurra luminosa. Quanto a Jim, lui trova dappertutto
sul suo cammino da una parte gli indizi del suo tracollo e dall’altra
i segnali che gli consentirebbero di interromperlo. Basket-ball Diaries
e Trainspotting propongono entrambi una via di scampo contro
l’eroina, attraverso l’astinenza. Una volta di più,
i cineasti si rivelano incapaci di interrogarsi sulla presenza dell’eroina
nelle strade e sulla sua assenza nelle farmacie, sulle ambiguità
politiche connesse al proibizionismo, sulle complicità intorno
al traffico.
Dopo la rivolta e il disgusto, è l’amarezza che domina in
Delirio e paura a Las Vegas. Nonostante la grande creatività
degli effetti speciali e la bravura degli attori, questo film «uscito
troppo tardi» non mantiene tutte le promesse. In particolare, non
trasmette niente, non fa capire nulla della disperazione politica che
pervade il racconto, la fedeltà al quale avrebbe consentito al
film di divenire una metafora. Un quarto di secolo dopo, la maggioranza
silenziosa, i politici irresponsabili e la guerra sono sempre lì:
retrospettivamente c’era e c’è ancora qualche ragione
per essere paranoici.
|

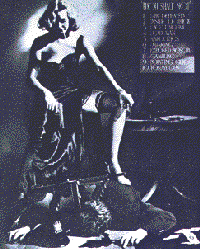 Il
primo elemento contestuale comune ai tre film è costituito dal
precedente letterario. Ritorno dal nulla è tratto dai
Basket-ball Diaries di Jim Carrol, Delirio e paura a Las Vegas
dal racconto di Hunter S. Thompson, e Trainspotting dal romanzo
di Irvine Welsh. Se ci si ricorda dell’adattamento del romanzo
di Nelson Algren L’uomo dal braccio d’oro (Otto Preminger,
1955), di Bright Lights, Big City (James Bridges, 1988), tratto dal
romanzo di Jay McInerney, o ancora del burroughsiano Pasto nudo (David
Cronenberg, 1991), i nostri tre film non fanno che confermare la regola
secondo cui un lungometraggio che tratti di droga deve necessariamente
basarsi su di un’opera letteraria, scritta da un fruitore esperto.
Lo scrittore tossicomane conferisce così legittimità (necessaria?)
al cinema della stupefazione. Di solito i registi negano di assumere
droghe anche quando lo fanno, perché ciò li mette in difficoltà
presso gli studios. Il rischio economico rappresentato da un regista
strafatto è enorme, mentre quello d’utilizzare l’opera
di uno scrittore tossicodipendente, qualche anno dopo lo scandalo, è
nullo. Hunter S. Thompson, Jim Carrol, Irvine Welsh (autore di Acid
House ed Ecstasy) sono senza dubbio degli specialisti in materia di
droga. Non si potrebbe dire altrettanto di Terry Gilliam, Scott Kalvert
e Danny Boyle. Ritorniamo al contesto dei tre film. In Ritorno dal
nulla siamo negli anni Sessanta con un eroe preadolescente, Leonardo
di Caprio. Delirio e paura a Las Vegas è ambientato nel
1971 e vede come protagonista Hunter S. Thompson, all’epoca trentaquattrenne,
interpretato da un Johnny Depp, più giovane di cinque anni. Infine,
in Trainspotting, l’azione si svolge ai nostri giorni, e
il personaggio di Mark «Rent-boy» Renton (Ewan McGregor) può
avere ventiquattro o venticinque anni.
Il
primo elemento contestuale comune ai tre film è costituito dal
precedente letterario. Ritorno dal nulla è tratto dai
Basket-ball Diaries di Jim Carrol, Delirio e paura a Las Vegas
dal racconto di Hunter S. Thompson, e Trainspotting dal romanzo
di Irvine Welsh. Se ci si ricorda dell’adattamento del romanzo
di Nelson Algren L’uomo dal braccio d’oro (Otto Preminger,
1955), di Bright Lights, Big City (James Bridges, 1988), tratto dal
romanzo di Jay McInerney, o ancora del burroughsiano Pasto nudo (David
Cronenberg, 1991), i nostri tre film non fanno che confermare la regola
secondo cui un lungometraggio che tratti di droga deve necessariamente
basarsi su di un’opera letteraria, scritta da un fruitore esperto.
Lo scrittore tossicomane conferisce così legittimità (necessaria?)
al cinema della stupefazione. Di solito i registi negano di assumere
droghe anche quando lo fanno, perché ciò li mette in difficoltà
presso gli studios. Il rischio economico rappresentato da un regista
strafatto è enorme, mentre quello d’utilizzare l’opera
di uno scrittore tossicodipendente, qualche anno dopo lo scandalo, è
nullo. Hunter S. Thompson, Jim Carrol, Irvine Welsh (autore di Acid
House ed Ecstasy) sono senza dubbio degli specialisti in materia di
droga. Non si potrebbe dire altrettanto di Terry Gilliam, Scott Kalvert
e Danny Boyle. Ritorniamo al contesto dei tre film. In Ritorno dal
nulla siamo negli anni Sessanta con un eroe preadolescente, Leonardo
di Caprio. Delirio e paura a Las Vegas è ambientato nel
1971 e vede come protagonista Hunter S. Thompson, all’epoca trentaquattrenne,
interpretato da un Johnny Depp, più giovane di cinque anni. Infine,
in Trainspotting, l’azione si svolge ai nostri giorni, e
il personaggio di Mark «Rent-boy» Renton (Ewan McGregor) può
avere ventiquattro o venticinque anni.
