|
|
Legislazione italiana:
i retroscena
|
 Intro
Intro |
 Testo Unico D.P.R. n° 309/90
Testo Unico D.P.R. n° 309/90 |
 Il referendum del '93
Il referendum del '93 |
 L'istituzione penitenziaria
L'istituzione penitenziaria |
 Alcune puntualizzazioni
Alcune puntualizzazioni |
 Conclusione
Conclusione |
Intro
Innanzitutto un grande saluto a tutti
i fumatori incolumi e curiosi ma anche e soprattutto a tutti i perseguitati,
consumatori abituali e non, vittime di tale inaudita e patetica guerra
attuata dal nostro governo (sulla scia di altri simpatici ed estremamente
civili paesi quali gli Stati Uniti) contro l’innocenza di un comportamento
potenzialmente deviante solo quando lo si combatte, lo si attacca; ostinatamente,
con tenacia, eppur senza risultati.
Questo era il giudizio che l’illuminista
Beccaria
già nel 1746 dava di tutti coloro che pensavano di poter modificare
i costumi con la legge e la repressione: " nelle
infinite e oppositissime attrazioni del piacere e del dolore, non possono
impedirsele dalle leggi umane i turbamenti e il disordine. Eppure questa
è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in
mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire
i delitti che ne possano nascere, ma egli è crearne dei nuovi, egli
è un definire a piacere la virtù e il vizio, che ci vengono
predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti se ci dovesse essere
vietato tutto ciò che può indurci a delitto? Bisognerebbe
privare l’uomo dall’uso dei suoi sensi".
In questa sede noi non ci occuperemo
dettagliatamente di tutte le droghe come non ci occuperemo del panorama
internazionale e di tutte quelle tesi che cercano di far capire come mai
venga ancora sostenuto ed incentivato dai proibizionisti cosmopoliti un
progetto burocratico che più fallimentare non si può trovare
sulla faccia della terra sotto ogni profilo, sotto ogni aspetto (moralismi
ultraterreni, posizioni politiche dissennate ed interessate, vetuste ipocrisie,
interessi economici di multinazionali petrolchimiche, farmaceutiche … );
ma neppure del perché legalizzare sia la soluzione più ovvia
oltre che l’unica efficace o di come significhi restituire naturalità
ad un comportamento costantemente demonizzato offrendogli la possibilità
di inserirsi in un contesto culturale maturo, più responsabile,
destinato a crescere ("il proibizionismo crea una barriera di difesa, ma
al di là della barriera c’è vuoto di conoscenza", G. Arnao).
A noi interessa, in prima analisi,
soprattutto un aspetto del fenomeno così vasto, ossia il consumo,
in qualsivoglia quantità, specialmente quando questo venga equiparato
allo spaccio ed abbia una rilevanza penale oltre che amministrativa.
In seconda analisi interessa invece
l’Italia, il paese dove siamo nati e viviamo, dove siamo sottoposti a torture
psicologiche insensate con il nostro assenso passivo, nella totale impossibilità
di reagire, un paese dove rappresentiamo le future generazioni, quindi
l’unica possibilità di cambiamento.
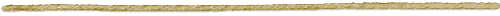
|
|
| Testo
Unico D.P.R. n° 309/90. Aspetti generali.
Cominceremo da cose penso ormai note
a tutti. La nuova disciplina degli stupefacenti, la legge "Craxi-Jervolino-Vassalli"
n° 162 approvata il 26 giugno 1990 e poi inserita assieme alle precedenti
nel testo unico sulle sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza con decreto
del Presidente della Repubblica n° 309 del 9 ottobre del 1990, è
una delle leggi punitivo-repressive più severe nel panorama internazionale
pur contenendo interessanti innovazioni atte a modificare l'assetto e i
compiti istituzionali affidati al carcere.
Essa cambia radicalmente la strategia
istituzionale nella lotta alla diffusione delle tossicodipendenze rispetto
alla vecchia legge
n° 685 del 1975. Quest’ultima in merito alla liceità
del consumo di stupefacenti, pur dichiarando illecito l’uso delle droghe
leggere che di quelle pesanti sanciva la non punibilità per l’utilizzazione
personale di modica quantità di sostanze stupefacenti. La
nuova legge ribaltò questa impostazione dichiarando non tollerabile
il consumo e la detenzione di droga a nessun titolo e per nessun tipo,
sostituendo il vecchio concetto di modica quantità stabilito, di
volta in volta, discrezionalmente dal giudice con il concetto di quantità
non eccedente la dose media giornaliera fissata
invece da un apposito decreto ministeriale, il quale ha condotto finora
in carcere migliaia di tossicodipendenti abituali (per esempio: il D.M.
Sanità del 14 luglio del 1990 prevedeva che chi fosse stato
sorpreso con una dose di Eroina pura superiore ai 100 milligrammi o di
Cocaina superiore ai 150 milligrammi fosse considerato piccolo spacciatore
quindi passibile di arresto).
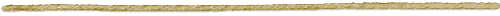
|
 |
| Il
referendum del '93. Uno sterile successo.
Successivamente, con il referendum
del 18 aprile del 1993 si riformò in parte il testo suddetto annullando
alcune norme sulla punibilità dei consumatori di droga. Soltanto
però chi avesse avuto un’immagine deformata della qualità
della popolazione tossicomanica può essersi stupito del fatto che
il referendum popolare non abbia avuto alcun effetto sostanziale sulla
popolazione penitenziaria o , ancor più ingenuamente, averlo solo
scongiurato: era infatti noto che la portata repressiva dell’articolo 76
(Sanzioni
penali in caso d’inosservanza), tradotta in posti di carcere, era
sempre stata equivalente a zero e che quindi, nella pratica, nessun consumatore
per il solo fatto di essere tale espiava la pena prevista da tale disposizione.
Tra l’altro si abrogò anche
il I comma dell’articolo 72 (Attività
illecite) che recitava: "E’ vietato l’uso personale di sostanze
stupefacenti ".
Venne così introdotto un dubbio
principio sulla non punibilità per il consumatore: dubbio perché,
come vedremo, le cosiddette sanzioni
amministrative (art. 75) rappresentano una forte privazione coercitiva
della libertà del cittadino (le segnalazioni ai prefetti per le
violazioni dell’articolo 75 sull’uso personale di sostanze proibite hanno
raggiunto all’inizio del 1996 la cifra di 108.176, mentre le sanzioni effettivamente
inflitte sono state 26.688, di cui 17.314 dopo il colloquio nucleo operativo
tossicodipendenze e 9.374 per mancata presentazione al colloquio), e in
secondo luogo perché la dose media giornaliera, viste le sue catastrofiche
ripercussioni, deve essere assolutamente individuata con altre modalità
(le violazioni dell’articolo 73, quello che stabilisce le pene
per la produzione e il traffico di stupefacenti e include fra le
sostanze vietate anche la Cannabis e i suoi derivati, hanno riguardato
nel 1995 circa 20.000, vale a dire circa il 36% dei detenuti).
Con tale referendum, comunque, la
battaglia antipunizionista ha ottenuto, allo stato, il suo risultato più
elevato senza tuttavia che il Parlamento abbia saputo esprimere soluzioni
legislative adeguate a quel voto. Il suo esito, se non altro, dimostrò
che la scelta repressiva, ispiratrice di quel testo, era stata largamente
bocciata dai cittadini del nostro paese e che tale impostazione, severamente
proibizionista, non poteva non lasciare il campo, anche da un punto di
vista democratico, ad una visione dei problemi collegati al consumo degli
stupefacenti più pragmatica. Siamo stanchi di ripeterlo: la punizione
non potrà mai assolvere la funzione di deterrente all’uso di tali
sostanze.
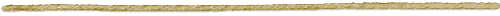
|
 |
| L'istituzione
penitenziaria: il problema dei tossicodipendenti detenuti e degli interventi
terapeutici.
Quindi, nonostante l’esito del referendum
del 1993, l’impianto del testo unico sugli stupefacenti rimane fortemente
penalizzante, ribadendo la sua "anima ispiratrice": per l’elevato livello
delle pene, per la sostanziale equiparazione tra detenzione e spaccio e
fra droghe leggere e droghe pesanti. Non c’è dunque da meravigliarsi
che la legge antidroga sia responsabile per oltre la metà degli
ingressi in carcere e I TOSSICODIPENDENTI
COSTITUISCANO STABILMENTE OLTRE UN TERZO DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA.
A fronte di questa criminalizzazione
del consumo di droghe e della tossicodipendenza la legge 162 proponeva
nel tentativo di alleggerire la situazione carceraria due soluzioni: l’affidamento
in prova speciale e la sospensione della pena per programmi terapeutici
(art. 76 lettera h, art. 120 e seguenti). Tale via venne poi ribadita nel
1993 dall’allora Ministro Martelli che elevò il tetto di pena al
di sotto del quale era possibile accedere a questi istituti: venne così
introdotta una sostanziale disparità fra l’affidamento in prova
ordinario e quello per tossicodipendenti, purtroppo solo apparentemente
a favore di questi ultimi. Un ultimo piccolo passo in questo senso, è
stato poi recentemente fatto con l’approvazione della legge "Simeone-Saraceni".
Attualmente però, molto spesso
l' insieme degli interventi di carattere socio-riabilitativo e psicologico,
anche ammesso che riescano a realizzarsi in pratica, sono già fortemente
viziati dalla struttura culturale di fondo del T.U. 309/90 che antepone
il momento punitivo e sanzionatorio rispetto a quello dell' aiuto e della
risocializzazione.
Ci sarebbe molto da dire sulla "ratio"
e la "rilevanza simbolica" di questo sistema, che da un lato stigmatizza
senza appello come deviante il semplice consumatore e il tossicodipendente;
dall’altro, accentuando la "specialità" premiale delle alternative
terapeutiche al carcere, ribadisce lo stereotipo del "tossico" quale persona
parzialmente responsabile delle sue azioni, ovvero incapace di intendere
e di volere. Fece scalpore, all’inizio di quest’anno, una sentenza della
corte costituzionale che riconfermò la validità degli articoli
94 e 95 del codice penale: aggravanti per i reati commessi dai "consumatori
abituali" (coloro che indulgono a piaceri illeciti) e addirittura la non
imputabilità per i tossicodipendenti "cronici", equiparati a malati
di mente senza via di scampo.
Ma cosa si intende per imputabilità?
In quale relazione è con il concetto di responsabilità
penale?
Quest' ultima si riferisce all'esistenza
di una causalità materiale e psichica tra l'evento e l'individuo.
Nessuno può essere punito per un fatto che non è conseguenza
della sua azione o omissione (art. 40 c.p.) e per un'azione commessa senza
coscienza e volontà (art. 42 c.p.): un certo fatto deve essere riferito
ad una certa azione o omissione e ad un certo comportamento cosciente dell'
individuo. Con tale categoria giuridica, si evidenzia l'obbligo astratto,
di chi è genericamente dotato della capacità di comprendere
la propria azione, di subire una pena: l'accertamento della causalità
materiale e psichica tra individuo ed evento è di pertinenza del
giudice il quale, esaminando il fatto, le modalità e le motivazioni,
stabilisce se quell'individuo è responsabile penalmente.
Tale concetto astratto si sostanzia
attraverso quello d'imputabilità.
Secondo l'art. 85 c.p. è
imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere, di comprendere
i dati della realtà e di agire secondo le proprie idee e i propri
desideri: la mancanza,anche temporanea, di una sola di queste capacità
comporta la non imputabilità.
In particolare per capacità
d'intendere si è soliti riferirsi alla capacità di comprendere
ciò che si sta facendo (natura intrinseca del fatto), l'illegalità
dell'azione commessa (natura antigiuridica del fatto) e la possibilità
di una reazione antisociale (natura antisociale del fatto); per capacità
di volere ci si riferisce ai poteri volitivi, ossia alla "capacità
dell'individuo di autodeterminarsi".
Volendo soffermarsi un attimo a riflettere,
la rappresentazione dell’uso di droghe e della dipendenza che emerge dal
codice fascista del 1930 non è poi molto distante da quella della
legge attuale: è solo estremizzata poiché il tossicodipendente
è trattato come un soggetto totalmente irresponsabile, cui solo
a rigori si aprirebbero le porte dei manicomi criminali.
Ora dovrebbe apparire senza veli la
violenza estrema, superiore a qualsiasi pena, insita nel togliere ad un
individuo il bene supremo di essere se stesso, soggetto responsabile -
appunto - delle proprie scelte, nel bene e nel male; e sospettoso potrebbe
rivelarsi allora, l’umanitarismo paternalistico di quanti si "stracciano
le vesti" per far uscire dal carcere tali soggetti svuotati della loro
dignità, senza spendere una parola per attenuare i rigori della
legge penale che in carcere li ha condotti.
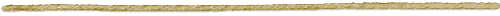
|
 |
| Alcune
puntualizzazioni.
Quale è stato allora, sotto
questo profilo il risultato pratico di tale sistema?
E’ ben vero che è progressivamente
aumentato il numero di detenuti tossicodipendenti che ha scelto, si fa
per dire, di sottoporsi a programmi in strutture socio-assistenziali ma
ciò non ha affatto significato la diminuzione dei soggetti in carcere,
creando la disillusione di un sistema globale, costituito da due vasi comunicanti,
che ancorché restringersi si espande. Il che è spia significativa
dell’ambiguità di questo circuito alternativo terapeutico che impropriamente
si definisce come tale.
Sul versante della depenalizzazione
ci si limita invece a registrare quanto è stato già sancito
da svariate sentenze della corte di cassazione (anche se naturalmente non
mancano sentenze di pareri contrari) relative ad una interpretazione più
elastica e meno ortodossa relativa agli articoli 73 e 74 inerenti la coltivazione
ad uso personale e il consumo di gruppo, non senza sottolineare gli obblighi
sanzionatori derivanti dalle convenzioni internazionali; con un generico
accenno ad una "riconsiderazione critica" delle sanzioni amministrative
per il consumo personale (art.75) ed una ancor più generica eventualità
di riformulazione dell’ipotesi di lieve entità per lo spaccio (art.
73 comma 5). E’ da ricordare inoltre che da annoverare tra i possibili
reati vi è anche la cessione gratuita a terzi, la cosiddetta "cessione
amichevole", per la quale può essere imputato per spaccio anche
chi semplicemente regala una modica quantità ad un amico oppure,
arrivando all’esasperazione, come sancito da una clamorosa sentenza
della Corte di Cassazione del 1997, chi "passa uno spinello al proprio
vicino".
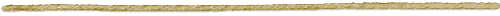
|
 |
| Conclusione.
Il governo Prodi, anche alla luce delle
conclusioni della II conferenza nazionale sulle droghe e sulle tossicodipendenze
tenutasi a Napoli nel marzo del 1997 ha, solo in linea di principio, accettato
una politica di riduzione del danno che preveda la depenalizzazione totale
di tutti gli atti finalizzati al consumo personale dei derivati della Cannabis,
compresa la coltivazione domestica, e la costituzione di un fondo sociale
per la tossicodipendenza per consentire di ampliare il più possibile
l’integrazione tra interventi sociali (cosiddetti enti ausiliari) e sanitari,
rendendo i dibattiti e le elaborazioni prodotte in quell’occasione, solo
delle astratte ed interessanti dichiarazioni.
Sono state infine recentemente consegnate
al presidente della Camera le firme raccolte in calce ad una proposta di
legge d’iniziativa popolare che punta alla liberalizzazione della Cannabis
e alla depenalizzazione di tutti i comportamenti legati al consumo di droghe,
non riconducibili allo spaccio.
Noi più esattamente vogliamo:
-
Il superamento del regime sanzionatorio
nei confronti del consumo di droghe;
-
La prevenzione del disagio per i soggetti
maggiormente esposti al consumo di droghe;
-
La sperimentazione limitata e controllata
nella somministrazione delle sostanze stupefacenti;
-
La riforma delle strutture operanti in
materia di tossicodipendenze;
-
LA LEGALIZZAZIONE DELLE DROGHE LEGGERE.
Con riguardo alla legalizzazione i tempi
non sono ancora del tutto maturi, esistendo purtroppo delle gigantesche
barriere sul piano dei principi, delle soluzioni tecniche, dei vincoli
internazionali, da non essere ancora completamente attuale; ma qualcosa
da un po’ di tempo si sta muovendo e non solo nel nostro ristretto ambito
nazionale. |
 |
|
|