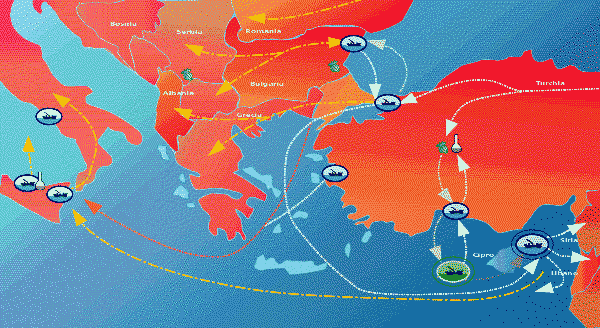|
|
|||
BALCANI: IL FUOCO E LA POLVERE
|
|||
|
Zona di frontiera tra il mondo turco, l’Europa occidentale e il mondo slavo, i Balcani sono sempre stati propizi ai «servizi segreti» di ogni genere, agli «scambi informali» ad alto livello e ai traffici di droga. La guerra in Kosovo ha rimescolato le carte, cambiando i tracciati della via balcanica attraverso cui transita buona parte dell’eroina e della cannabis destinate all’Europa. I kosovari, le cui reti familiari coprono l’intera Europa, s’impongono come i nuovi attori in questo gioco ad alto rischio. Michel Koutouzis, dell’OGD, fa il punto su questa evoluzione |
|||
 |
|
||
|
«Stupefacente!» – La storia delle droghe è anche storia di conflitti; nei Balcani, questa storia sembra muovere i primi passi. Michel Koutouzis – Effettivamente, ciò che succede nei Balcani è tipico di quei legami tra storia delle droghe e storia dei conflitti. I Balcani, come entità politica nascono con il crollo di due grandi imperi: l’ottomano e l’austro-ungarico. Così, negli anni Trenta del secolo scorso, la Croazia apparteneva all’Impero austro-ungarico, la Serbia aveva ottenuto l’indipendenza, mentre la Bosnia-Erzegovina, una parte dell’Albania e una piccola zona della Macedonia, facevano parte dell’Impero ottomano. Ormai è caduta la più moderna frontiera tra mondo occidentale e Impero sovietico. Questa frontiera presentava delle particolarità molto marcate: per esempio, la Grecia confinava con un Paese filocinese (Albania), un Paese filosovietico (Bulgaria) e un Paese che praticava la terza via al socialismo (Iugoslavia). In generale, la regione permetteva i contatti all’interno del mondo socialista e con l’Occidente. Questa funzione di comunicazione e di contatto tra il mondo occidentale e quello orientale ha creato, a poco a poco, legami molto stretti tra i differenti Paesi della regione, contatti ampiamente utilizzati sia dai sovietici sia dagli americani, ogni volta ch’era necessario mantenere aperto il dialogo tra i blocchi. I Balcani infine, come l’Austria, sono stati a lungo un centro importante per gli agenti segreti, i tiri mancini, gli scambi informali ad «alto livello» ecc. È dunque uno spazio mobile, impregnato di una cultura dello scambio, ma attraversato da diverse frontiere storiche. Nonostante questa volontà di relazioni strette, ci sono già, tra le due guerre, pulizie etniche in questa regione! Sì. Oggi si parla di pulizia etnica; negli anni Venti-Trenta si diceva di voler far coincidere le popolazioni con le frontiere nazionali. Di fatto, questa politica sviluppò un andirivieni di popolazioni bulgare, greche, turche, serbe, macedoni, albanesiÉ con due eccezioni che, oggi, sono causa di conflitto in questa regione e alimentano questa nozione di «purificazione etnica»: la Bosnia-Erzegovina, e una vasta zona tra l’Albania e la Macedonia, cioè il Kosovo. Con la fine del comunismo, questi due territori che non erano stati chiaramente definiti ci cadono sulla testa. Non è in quello stesso periodo che certi Paesi, derivati dagli Imperi ottomano e austro-ungherese si lanciano nella produzione di droghe? All’epoca in cui si definiscono le frontiere della regione, e in cui l’Impero ottomano si trasforma in Turchia, vedono la luce i primi accordi internazionali su un tema molto particolare: il divieto delle droghe. In effetti, quando in Francia, Svizzera, Germania nascono i primi cartelli dell’industria chimica, che ottengono il monopolio per l’esportazione e lo sfruttamento della morfina, Paesi come la Iugoslavia o la Turchia sono esclusi dagli accordi e formano la prima federazione anti-cartello dell’industria chimica. Inoltre, questi due Paesi conservano la memoria della cultura del papavero e della cannabis, e anche in Grecia la canapa è rimasta prodotto d’esportazione fino al 1947. Risultato: dopo la Seconda Guerra mondiale tra questi Paesi si definiscono percorsi formali e informali, che ancor oggi si chiamano «strada dei Balcani». E ben presto, le prime grandi filiere di eroina passeranno di lì, dalla Turchia alla Sicilia, attraverso la Bulgaria. Queste prime reti italo-turche, che costituiscono la «French Connection», sono formate con la partecipazione dei servizi segreti e delle banche, poiché permettono anche scambi informali politici ed economici. Questa versione iniziale della «strada dei Balcani», inizialmente marittima, diventa terrestre con la partecipazione della Bulgaria. La Iugoslavia soprattutto, per la sua volontà di non affiliarsi a Mosca pur non integrandosi nel mondo occidentale, si presta in modo ideale, e «la strada dei Balcani» passerà per forza attraverso questa terra di nessuno. Esistono in questa zona punti di passaggio obbligato, assi privilegiati dai trafficanti? Uno dei luoghi sacri lungo questa strada è Banja Luca. Di fatto, la Bosnia-Erzegovina diventa un punto di passaggio di grande interesse, poiché permette di penetrare nelle regioni settentrionali della Iugoslavia e di raggiungere l’Austria, l’Italia e l’Ungheria. Tuttavia la direttrice centrale che sbocca sul litorale adriatico resta fondamentale. Questa «strada dei Balcani» si sposta continuamente, secondo la situazione geopolitica internazionale, i conflitti locali, le contraddizioni Est-Ovest e quelle interne a Iugoslavia, Bulgaria, Turchia. Oggi, dato il conflitto in atto nell’ex Iugoslavia, la strada passa per la Romania, l’Ungheria, l’Albania e soprattutto per la Macedonia, piccolo Paese molto povero e facilmente destabilizzabile che fa da ponte fra la Bulgaria e l’Albania. L’Albania diventa un centro di esportazione molto importante. Non si tratta più di semplici corrieri, come agli inizi degli anni Novanta, ma di «baroni» che prendono in mano la maggior parte del traffico: i Fari, clan kosovari o albanesi. Esaminando le reti kosovare, l’Observatoire Géopolitique des Drogues ha elaborato, sette anni fa, il concetto di «circuito breve». E oggigiorno arriviamo a gradi di sofisticazione nei quali le maggiori catene di distribuzione, avendo compreso l’importanza di questi circuiti brevi, non litigano più, e si astengono dall’investire la distribuzione nelle strade come fanno coi narcoturisti in Olanda. Questi circuiti brevi creano essi stessi il loro minicircuito di distribuzione. E se voi moltiplicate i minicircuiti all’infinitoÉ Così oggi si hanno grandi organizzazioni latino-americane, turche, balcaniche, non solo albanesi, che si sono installate nei punti di arrivo dei narcoturisti che vengono, in treno o in aereo, per acquistare un chilo di eroina o mezzo chilo di coca ogni quindici giorni. Lei parla di questa zona, e particolarmente dell’Albania, come di un centro importante per la distribuzione delle droghe verso l’Europa. Questa zona non è diventata anche produttrice di droghe, in particolare di oppio e di cannabis? Ciò che si era dimenticato, la guerra ce l’ha ricordato! In Bosnia-Erzegovina, come in Macedonia, e perfino nel Sud della Serbia, il papavero – che era stato sradicato negli anni Cinquanta non soltanto dalla terra ma anche come cultura tradizionale dalla memoria degli abitanti – viene reintrodotto dalla guerra. Dopo il conflitto in Bosnia, le coltivazioni di papavero e di cannabis si moltiplicano in tutta l’area come un’alternativa alla crisi. Un altro esempio molto interessante è il dislocamento della cannabis greca del Peloponneso e della Tracia, che prende piede in Albania. Attraverso i rapporti intrattenuti col loro Paese d’origine dai 300 mila albanesi che lavorano in Grecia, e di fronte a una repressione che nella repubblica ellenica resta costante, i produttori hanno preferito trasferirsi in un Paese ove non si corrono rischi. Vi hanno importato i loro saperi e i semi, consentendo una mutazione della marijuana albanese, la quale, una volta di qualità molto scadente, ha raggiunto un livello accettabile per i mercati internazionali. Ma il problema delle coltivazioni è un problema marginale, soprattutto per le coltivazioni di cannabis. Nello spazio di un paio d’anni sono stati creati un milione e mezzo di ettari di cannabis in Russia, e non saranno i ventimila ettari balcanici a cambiare la distribuzione. Con ottantamila ettari in Sudafrica e ventimila ettari nello Zimbabwe, l’Africa è diventata il primo produttore mondiale di erba; e ciò non ha impedito alla gente di dormire, ché anzi dormono meglio. Il problema della produzione non è molto grave; è il problema del traffico che è più inquietante, poiché il traffico presuppone che si chiudano gli occhi su attività ben altrimenti destabilizzanti che la produzione di cannabis. Il fatto è che ora l’Albania è entrata nella logica capitalista senza far distinzione tra lavatrice e cannabis, tra eroina e qualunque altra cosa. Si fa in modo di trovare ciò che la gente chiede. Questi baroni balcanici sono quindi trafficanti multiprodotto? In effetti, sì.
Se fino a una decina d’anni fa la «strada dei Balcani»
era monopolio di alcune organizzazioni mafiose turche, oggi abbiamo
una esplosione di attori, di prodotti, di organizzazioni; e nello
stesso tempo un consumo locale rilevante che pone problemi. La maggior
parte dei trafficanti sono multiprodotto, cosa che non vuole affatto
dire che non si siano creati imperi grazie a una sola sostanza. Per
esempio, si sa benissimo che le differenze tra Pale e Banja Luca erano
soprattutto una questione di contrabbandieri: tra chi trafficava in
petrolio e chi trafficava in sigarette. Non c’era altra posta
in gioco sul piano politico; si trattava soprattutto di un conflitto
mercantile. Una parte della diaspora kosovara, che si è dispersa un po’ in tutti i Paesi occidentali, non ha ampiamente partecipato all’installazione di queste reti balcaniche a partire dagli anni Novanta? Nella Iugoslavia di Tito il Kosovo aveva uno statuto autonomo. I soggetti avevano quindi la capacità di viaggiare in tutto il mondo. Così si è creata, a partire dagli anni Settanta e durante tutto il decennio successivo, una importante diaspora kosovara ai quattro angoli della Terra. In Canada, in Australia, in Europa e negli Stati Uniti, come per altre diaspore, i kosovari praticavano illeciti e tessevano legami con altri gruppi «etnici» come dalle parti di Vancouver con le triadi cinese e vietnamita che distribuiscono l’eroina bianca (la «China White») o in Australia con la yakuza giapponese che smercia le anfetamine. Il vantaggio dei kosovari sulle altre minoranze nei Balcani consiste nell’anteriorità della loro presenza all’estero, nell’aver sviluppato affari e nel fatto di essere alla testa dell’insieme del «movimento» albanese. Così, in occasione del crollo del governo socialista in Albania, saranno loro a prendere in carico i rifugiati albanesi e a usarli. I primi grandi traffici kosovari riguardavano i passaporti. Con la fine del comunismo, gli albanesi non sono più considerati rifugiati politici, mentre i kosovari conservano questo «status» per evidenti ragioni, allorché Belgrado sopprime l’autonomia della regione. I kosovari venderanno dunque allegramente i passaporti iugoslavi agli albanesi affinché possano andare a vivere in Germania, Svezia, Francia ecc. Allo stesso tempo utilizzano la diaspora albanese per sostenere il loro sforzo bellico o, almeno, per ottenere il ritorno allo statu quo in Kosovo. Oggi la comunità albanofona rappresenta la seconda minoranza implicata nel traffico di droga dopo i turchi, con il 14-18% degli arresti di grandi e medi spacciatori di eroina in Europa. Quando il progetto politico in Kosovo era ancora un progetto di sviluppo economico attraente per gli investitori stranieri, e perciò un modo per inserirsi nella Iugoslavia da posizioni di forza, questo traffico aiutava a costruire strade, tralicci per l’energia elettrica, ad acquistare vetture, tirar su case ecc. Con l’opzione militare il traffico serve soprattutto allo sviluppo degli armamenti, tanto più che anche a questo proposito si registra un’anteriorità dei kosovari. Elemento già da tempo centrale nel traffico, dopo una leggera diminuzione verso il ’92-93, lo scambio armi-droga torna oggi a svilupparsi. Con ciò non voglio dire che i reparti dell’uck si finanzino così, dal momento che hanno diversi altri modi per farlo. La leadership kosovara nel traffico di droghe, soprattutto di eroina, ha avuto conseguenze sui mercati locali e internazionali delle droghe? Finora quella dei Balcani è stata una strada che portava morfina-base dal Paese di trasformazione (la Turchia) verso i Paesi di consumo. Era un circuito ermetico. I Paesi attraversati dalla «strada dei Balcani», qualunque ne fosse la direttrice – poco importa se marittima o terrestre, se da nord o da sud, se dal mar Nero o dalla Moldavia –, in generale non avevano accesso ai prodotti. All’inizio degli anni Novanta i kosovari sono stati i primi a capire che tutti questi Paesi rappresentavano un immenso mercato. Hanno cominciato a vendere eroina sulla piazza, ottenendo «buoni risultati». Oggi hanno una clientela che varia dai 15 ai 20 mila tossicomani nella sola Macedonia, Paese che conta due milioni di abitanti. Moltiplicate queste cifre per 10, 20 o 30 volte per la Bulgaria, la Serbia, la Bosnia. E c’è anche una tossicomania nata dalla guerra stessa, che ha portato lo speed, la coca e tutte le droghe del «miliziano», come in Libano. Oggi è disponibile l’intera gamma dei prodotti. Adesso, in tutto questo spazio – i Balcani, il Caucaso, la Russia – non ci troviamo più di fronte al tradizionale dualismo in base al quale, per esempio, gli americani, adepti soprattutto della performance, cercano gli eccitanti, mentre gli europei, più ghiotti di stone, consumano ero ed erba. In quelle regioni si ha una combinazione molto bizzarra in cui si mescolano un’atmosfera da dopoguerra, da dopo-la-fine-dell’Impero russo, l’anima slava, il bisogno di espedienti, l’iperattività per uscire dalla crisiÉ col risultato che la gente consuma qualunque tipo di droga. Infine, in tutti i Paesi dell’Est, le droghe di sintesi esistono da lungo tempo e le altre, quelle che noi chiamiamo «le vecchie droghe» (eroina, cocaina, haschisch), stanno arrivando adesso. La fede assoluta nella scienza, che è una delle numerose perversioni del socialismo in questi Paesi, ha favorito dopo la Seconda Guerra mondiale una cultura della «droga di sintesi», ancora tenace oggigiorno. Così all’inizio di aprile, durante un corso di formazione presso la Corte suprema russa, un magistrato mi ha chiesto del tutto seriamente: «Ma, per farla finita con le droghe, perché non inventarne una che inibisca la voglia di assumerne altre?». Questa è gente che ci crede! Queste reti e gli uomini che le dirigono potrebbero dunque avere un ruolo chiave nell’avvenire politico del Kosovo e di tutta la regione? In Bosnia-Erzegovina sono già nati piccoli mostri: signori della guerra, come l’ormai defunto Arkan, pregiudicati che controllano a volte brigate speciali di 500 uomini. Veri e proprî signori della guerra che si vestivano, agli inizi degli anni Novanta, come in un film di Mad Max. Un modello cinematografico! Le loro jeep erano esattamente uguali a quelle del film. La loro visione del mondo era la visione di un mondo post-nucleare. E, in realtà, essi vivevano davvero una situazione del genere; anche se la Bomba non era scoppiata, la crisi post-atomica c’era. Nessun punto di riferimento, nessuna economia! Per essi era normale agire come nei film del dopo-Bomba. In Bosnia, col ritorno della pace, gli attori sono semplicemente diventati più ricchi e più efficienti. La natura dei loro traffici è cambiata, con un maggior numero di prodotti, quantità più cospicue, nonché una maggiore integrazione nel mercato legale. Ed è esattamente ciò che sta succedendo ora in Kosovo. Ci sono decine di gruppi serbi, albanesi, o kosovari; miliziani serbi o membri dell’uck, signori della guerra che nell’arco di tre o quattro anni saranno sindaci o prefetti. Hanno accumulato a sufficienza, detengono il monopolio dei traffici di petrolio, sigarette, elettrodomestici e certamente di tutti i prodotti portatori di valore aggiunto, cioè quelli illegali. E hanno la solidità economica per muoversi in grande, concependo le loro attività come delle multinazionali, grazie ai contatti di cui godono in Europa, America o Australia. |
|||
| precedente | |||