|
|
|||
CIA: LA MADRINA
|
|||
Crack e CIA: Intervista a Gary Webb «Revolutionary Worker» – Secondo lei, perché il suo esposto ha suscitato tanto clamore? Che cosa ha davvero attirato l’attenzione della gente e inquietato a tal punto il governo? Gary WEBB – Semplicemente il fatto che noi abbiamo scoperto dove arrivava questa cocaina. Durante gli anni Ottanta, erano già stati pubblicati un discreto numero di articoli, anche sulla stampa a grande tiratura, a proposito della Contra che avrebbe spacciato cocaina negli Stati Uniti. Ciò che noi siamo riusciti a stabilire è il luogo in cui la merce veniva venduta; ed era nei ghetti, principalmente a Los Angeles. Abbiamo così potuto anche mostrare gli effetti di tutta questa storia: l’orribile epidemia di crack che da Los Angeles si era diffusa in centinaia di altre città statunitensi negli anni seguenti. Penso che sia stato questo che più di tutto ha fatto infuriare la gente. È interessante, perché all’inizio della sua inchiesta lei insisteva da un lato sulle migliaia di giovani neri condannati a lunghe pene detentive per aver venduto cocaina e dall’altro sull’assenza di questa droga nel mercato delle comunità nere finché i nicaraguensi della Contra, sostenuti dalla CIA, non la fecero arrivare fino a South-Central, L.A. Personalmente, sono convinto che si tratti semplicemente di una questione di tempo. Ricordate, nella stessa epoca, in Colombia si formavano i cartelli. Di colpo la cocaina sparì dalla circolazione. I volumi si gonfiarono, i prezzi calarono. Penso perciò che abbiamo trovato la spiegazione. Prima dell’inizio degli anni Ottanta, costava cara per tutti. Con la nascita dei cartelli, i prezzi crollarono perché la produzione era in aumento. Cosa che comunque non spiega ancora come mai se ne trovasse a South-Central. Ciò che noi abbiamo spiegato è come questa cocaina a buon mercato sia arrivata a South-Central, attraverso l’intermediazione del cartello legato alla Contra su cui ho condotto l’inchiesta. Che cosa ha appreso sulla relazione tra il cartello e la proliferazione del crack nella comunità nera? Ecco! Il know-how per la fabbricazione del crack era nell’aria già da un po’. Già dalla fine degli anni Settanta esistevano qua e là ricette sul modo di convertire la polvere in crack, scaldandola con della soda. L’unico problema era che, non essendoci abbastanza cocaina, risultava troppo caro. Quando si è cominciato a importare cocaina a buon mercato in quantità, chi sa come produrre il crack ha di colpo l’opportunità per farlo. È una materia prima a tutti gli effetti: costoro hanno fornito la materia prima di ciò che è divenuto il problema del crack. Eccola, la relazione. Non sto dicendo che la CIA ha inventato il crack, o che la Contra l’ha fatto arrivare. Essi hanno soltanto immesso la polvere sul mercato, ma i clienti della strada sapevano come trasformarla in crack pur non avendo mai potuto farlo, in mancanza delle quantità necessarie. Una delle cose che lei ha rivelato, è il volume di cocaina che di colpo si rende disponibile. L’uomo alla testa di questo cartello, Norwin Meneses, era uno dei più grossi trafficanti di cocaina in America latina. Egli trattava direttamente con gli altri cartelli; aveva un accesso illimitato alla cocaina, ed era capace di farne entrare tonnellate nei vari Paesi illegalmente. Se volete crearvi un mercato a Los Angeles, vi conviene averne molta, di roba. Che cosa ha saputo del modo in cui questi personaggi hanno potuto far entrare tanta cocaina negli Stati Uniti? Avendo molti mezzi
a disposizione, cambiavano i percorsi ogni volta che ne veniva scoperto
uno o che una maglia veniva localizzata. Potevano far arrivare la
coca in auto o in camion. All’inizio degli anni Ottanta, si servivano
dei cargo colombiani, che navigavano lungo le coste degli Stati Uniti.
E questi cargo facevano scalo a Los Angeles, a San Francisco, a Portland,
a Seattle, giusto il tempo per attraccare e scaricare. La cosa più
interessante è quando hanno incominciato a utilizzare aerei
dell’aviazione militare salvadoregna, verso il 1984-85. Esisteva
una base aerea in Salvador, che era utilizzata per i rifornimenti
ai Contras. La cocaina era caricata sugli aerei salvadoregni fino
a una base aerea nel Texas, dove veniva scaricata, per essere indirizzata
altrove. Ha un’idea dei quantitativi in questione? L’avvocato di un trafficante mi ha rivelato che non erano rare le spedizioni superiori alla tonnellata. Avevano a disposizione di grossi aerei da trasporto utilizzati per l’invio degli aiuti umanitari alla Contra; cosa che sembrerebbe coinvolgere il programma nhao sotto il diretto controllo del Dipartimento di Stato. Di che programma si trattava? Del Nicaraguan Humanitarian Assistance Office (Ufficio per l’Assistenza Umanitaria al Nicaragua), istituito per distribuire 27 milioni di dollari in aiuti umanitari, dopo che il Congresso aveva votato la chiusura dei crediti militari. L’amministrazione Reagan tergiversò e mise in piedi l’nhao, i cui aerei furono adoperati per le cosiddette spedizioni varie. Forniture militari e non. Inoltre, l’avvocato di Danilo Blandon mi ha spiegato che per il viaggio di ritorno, dopo aver consegnato le forniture, ritornavano negli Stati Uniti con carichi di diverse tonnellate. Niente male: in un C-130 di cocaina ce ne sta un bel po’! E quanta gente doveva tenere gli occhi ben chiusi quando queste partite di coca venivano scaricate nelle basi militari americane? Come si distribuiva? Non credo che ciò avvenisse alla luce del sole. La coca era generalmente impacchettata in coperte militari imbottite color kaki. Quando si comincia a scaricare un aereo militare pieno zeppo di equipaggiamenti e si vedono coperte militari imbottite qua e là nessuno ci fa caso. Penso che perfino gli equipaggi degli aerei potevano esserne all’oscuro. Tutto ciò di cui si ha bisogno è un uomo di fiducia all’interno della base aerea di Ilopongo, in Salvador, per fare il carico. Dopo, a nessuno verrà in mente di perquisire un aereo militare che rientra negli Stati Uniti da una missione. Quali erano allora le agenzie governative implicate nell’invio della cocaina verso gli usa e nella sua distribuzione? È difficile a dirsi, perché i trafficanti non avevano legami diretti con loro. Si tenevano sempre a debita distanza. Ho scoperto legami con il Dipartimento di Stato, con il Consiglio di sicurezza nazionale, la CIA e la DEA. Ognuna di queste agenzie era implicata in svariati modi. Siamo in possesso di prove significative secondo le quali membri del cartello in questione erano in contatto con funzionari delle suddette agenzie proprio mentre questo traffico di cocaina era al suo apice. Tali agenti non sono stati mai inquisiti. Che legami ha scoperto circa la DEA? La DEA era in rapporto con Norwin Meneses, il capo del cartello. Egli stesso lavorava per quest’agenzia già da qualche anno. Ecco perché non è mai stato arrestato negli usa: era protetto. Ha saputo qualcosa di nuovo, nel quadro della sua inchiesta circa i legami tra la CIA e l’operazione nel suo insieme? Uno dei legami che abbiamo scoperto passava attraverso un agente del Costa Rica. Abbiamo incontrato un corriere di questa rete, che lavorava per l’organizzazione di Meneses, a San Francisco. Questi ha identificato l’agente, ce ne ha fornito il nome e ha aggiunto che, secondo lui, controllava la distribuzione dei fondi, che trasportava personalmente. Esistevano anche corrieri gestiti da un agente della CIA, che era il loro finanziatore quasi esclusivo. Quest’uomo era Enrique Bermudez, il comandante della fdn, un’unità militare della Contra. Abbiamo anche ottenuto prove che qualcuno, a Washington, qualcuno corrispondente perlomeno a un alto funzionario della CIA a Washington, possedeva precise informazioni sul traffico che si svolgeva nella base aerea salvadoregna. La CIA sembra sempre operare in modo da poter in seguito negare il suo coinvolgimento. È la loro prassi. Esatto. Non beccherete mai la CIA in flagrante! Troverete persone stipendiate dall’agenzia che domandano ad altri di fare qualcosa. Proprio come nel nostro caso. Avete un agente straniero, Enrique Bermudez, che chiede a due uomini, la cui professione, guarda caso, è lo smercio della cocaina, di fare qualcosa per un esercito finanziato dalla CIA, sulla strada maestra della politica estera degli Stati Uniti. È dunque molto difficile credere che costoro facessero tutto ciò di testa loro. Io non ho mai incontrato trafficanti di cocaina generosi, neanche un po’. Ha un’idea dell’ammontare delle somme che entrarono alla fine nelle casse della Contra, grazie alla vendita di cocaina? Nel 1982 e nel 1983, all’epoca cioè in cui questo corriere lavorava per loro, egli stimava che questa somma fosse tra i 5 e i 6 milioni di dollari. [...] L’emendamento Boland, grazie al quale il Congresso soppresse i crediti che la CIA destinava alla Contra, è del 1984. Ma questi finanziamenti ripresero grazie alla reinstallazione di Meneses in Costa Rica. Danilo Blandon cominciò a fornire a Eden Pastora, uno dei comandanti della Contra, caserme, camion e soldi. Ma non abbiamo la più pallida idea delle somme che riguardano questi ultimi anni. Mi sorge il dubbio che la Contra non abbia mai ricevuto gran parte di questi narcodollari. Con tutta la cocaina venduta dalle nostre parti, se i soldi fossero andati interamente alla Contra, questa non avrebbe solo vinto la guerra, ma preso il potere in tutta l’America Centrale. Milioni di dollari? Non si sputa mica su 5 o 6 milioni di dollari. Quindi lei afferma anche di aver trovato legami con il Dipartimento di Stato. Ciò rientra nel quadro? Ciò fa parte del resto dell’inchiesta. Ancora inedito. Ma ci sono state stranissime riunioni, con certi funzionari del Dipartimento di Stato implicati in vicende di grande interesse. Dall’inizio della sua inchiesta, si è assistito a una campagna molto intensa per screditarla e impedirle l’accesso ai mass media. Può parlarcene Una campagna che mi sembra trionfale. Ma il dado ormai è tratto. Se guardate indietro, al momento degli scandali della CIA durante gli anni Settanta, rivelati da un esposto di Seymour Hersh, o dal lavoro di Daniel Schore per la cbs, troverete che entrambi si sono ritrovati oggetto della stessa campagna diffamatoria. Può descrivere per i nostri lettori cosa le è capitato? Be’, ho visto giornalisti scrivere che non avevo alcuna prova a sostegno di quanto avanzavo; che niente di quanto affermavo era fondato. C’è stato un articolo del «Washington Post», secondo cui l’inchiesta insinuava che la CIA avesse mire sull’America nera. Era una campagna di disinformazione molto sottile che cercava di far credere alla gente che questi articoli dicessero altro da ciò che in realtà dicevano. O per far loro dire altro da ciò che noi avevamo inteso. «Va be’, dopo tutto non ci sono prove», questo era quanto la gente avrebbe dovuto pensare. Si tratta di pura e semplice propaganda. Ho proposto un libro e c’è stata una fuga di notizie verso il «Los Angeles Times». Questi che cos’hanno fatto? Molto semplicemente, ne hanno censurato una parte pubblicando poi il resto sul loro giornale, in modo da farmi passare per un teorico del complotto. Che cosa significa, secondo lei, la presenza del capo della CIA a un meeting a South-Central, Los Angeles? Dimostra quanta paura avesse la CIA di questa storia: non avevano mai fatto una cosa del genere. Il capo della CIA che appare in pubblico e risponde a delle domande! Non si può certo dire che abbia poi risposto, ma almeno è stato obbligato a fingere di provarci. Questo ci dà l’esatta misura dell’allarme a Washington. Parlando dei diversi attacchi subìti, ha utilizzato il termine campagna di disinformazione. Può dirci di più in merito? Negli anni Ottanta, esisteva la «Gestione della Percezione». Si trattava di un programma istituito all’interno stesso del Dipartimento di Stato, da esperti in propaganda della CIA con l’obiettivo di: a) rilevare, ponendoli nell’impossibilità di nuocere, tutti i giornalisti critici verso la guerra della Contra e che lavoravano intorno al coinvolgimento della Contra nel traffico di cocaina; b) intimorire i redattori e gli altri giornalisti tentati di seguirne l’esempio. Ci sono molte similitudini, se guardate bene i risultati ottenuti negli anni Ottanta, con quanto succede oggi. C’è gente incaricata di propalare dicerie sul vostro conto. Sono gli agenti di Accuracy in Media, l’organizzazione di Reed Irvine, gli stessi, dunque, che oggi si svegliano per dire che dietro questa storia della CIA non c’è niente, che è tutto inventato. Gli stessi agenti, dunque, che erano montati sugli spalti negli anni Ottanta per sostenere che a El Mozote non era successo niente [un’unità speciale, addestrata dall’esercito americano, procedette allo sterminio della popolazione del villaggio di El Mozote, in Salvador, trucidando più di 300 tra uomini, donne, vecchi e bambini, ndr], che la notizia del massacro era una bufala e che il reporter del «Times», Raymond Bonner, era un simpatizzante comunista. Gli stessi. E una delle cose che s’impara, occupandosi delle agenzie d’informazione, è riconoscere il loro modo di operare. Le persone cambiano ma le procedure restano. La «Gestione della Percezione» degli anni Ottanta era uguale a quella praticata oggi. La grande stampa è ormai convinta che alla base della nostra inchiesta non ci sia nulla di concreto. Anche se nessuno, di fatto, è riuscito a scoprirvi degli errori. Perché allora, malgrado questi attacchi, sia personali che diretti contro i suoi reportage, continuare a rischiare per raccontare questa storia? Perché è vera. È la base di tutta questa storia: la verità. E si diventa per forza giornalisti per questa verità. Se pensassi che si tratta di favole, o se fossi convinto di essermi sbagliato, lo direi: «Ho fatto un errore». Ma non mi sto sbagliando. La gente deve conoscere questa storia non solo per capire quanto è successo, ma anche perché, perdiana, dovrà pur esserci un responsabile! È criminale quanto è accaduto. Si continua ad arrestare gente per traffico di cocaina. E proprio questo affaire ha fatto entrare tonnellate su tonnellate di cocaina negli Stati Uniti. Nei ghetti dei downtown. Ma nessuno finora è ancora stato punito per questo, a parte gli abitanti dei quartieri presi di mira. [...] Devono comparire ancora quattro puntate, vero? È come se non esistessero. Nessuno le pubblicherà mai. Può farcene un sunto, a grandi linee? Si tratta principalmente di sapere chi, nel governo degli Stati Uniti, era al corrente. E anche di conoscere i legami fra altre agenzie governative e i cartelli della droga. Le loro attività in Costa Rica, in Salvador. I vani sforzi dei poliziotti di Los Angeles per portare quei tipi lì davanti alla giustizia, come si sono fatti imbrogliare e prendere per il naso. Il coinvolgimento di Oliver North nel giro dei trafficanti di droga del Costa Rica, in ogni caso il coinvolgimento della sua rete. Esistono molte informazioni su questo aspetto. Tutto inutile... «Revolutionary Worker», n. 912 22 giugno 1997

18, 19 e 20 agosto 1996: il «San
José Mercury News» pubblica una serie di tre articoli
di Gary Webb. Nessun quotidiano nazionale li riprende. Ma le radio
locali della comunità nera, sì. Lo splendido sito
internet che il «San José Mercury News» dedica
a The Dark Alliance, in cui, per la prima volta nella storia del
giornalismo, i testi degli articoli vengono pubblicati con le relative
fonti, in immagini e sonoro, viene assalito dalle connessioni...
fino a un milione al giorno! Bisogna aspettare ottobre perché
la stampa reagisca! Il «Washington Post» apre il fuoco
per tentare di smentire Gary Webb. Poi è la volta del «New
York Times», ma è al «Los Angeles Times» che
spetta la pubblicazione
questa campagna: dal 20 al 22 ottobre,
una serie di tre articoli lunghi come quelli di Gary Webb. La denuncia
unanime della stampa benpensante induce il caporedattore del «San
José Mercury News», Jeremy Ceppo, a ritrattare. In seguito,
Gary Webb va in pensione, e pubblica nel 1998, presso le edizioni
Seven Stories, il suo libro The Dark Alliance.
Michael Levine, il dissidente che la DEA ha bandito
«High Times» – Perché un ex agente della DEA interviene in una radio? M. Levine – Perché si assiste alla totale abdicazione dei media, che non svolgono più il loro ruolo, per quanto minimo, di controllo. Io ero il funzionario americano di grado più elevato nel cono Sud. Ebbene, voi non potete immaginare peggiori tradimenti verso il popolo americano di quelli cui mi è toccato di assistere! E voglio parlare del sostegno fornito dalla CIA e dai suoi collaboratori alla presa del potere in Bolivia da parte di narcotrafficanti e ricercati nazisti. Ci vuole parlare del 1980 quando, dopo il «colpo di Stato della cocaina», l’economia sudamericana della droga è diventata un’industria di grandi proporzioni... È esatto. Ciò che voglio dire è che tutto si svolgeva sotto gli occhi dei mass media. «Newsweek» aveva pubblicato un articolo sulla situazione boliviana talmente lontano dalla realtà, che ho fatto la più grande stupidata della mia vita inviando alla redazione una lettera con intestazione dell’ambasciata in cui dicevo: «Voi siete totalmente inseriti dentro il programma, la verità è che la CIA ci ha tradito». Dov’è stato l’errore? I giornalisti non mi hanno mai chiamato e io mi sono ritrovato con una inchiesta interna sul groppone. E chi si è reso conto che qualcosa andava veramente storto nella copertura degli avvenimenti in Bolivia? Sentite questa! «High Times», articolo di Dean Latimer (agosto 1981). Ve lo riassumo. Diceva, per sommi capi: «Il governo ha lavorato di lima fin nei dettagli di questo colpo di Stato, e non cerca nemmeno di metterlo al suo attivo. C’è qualcosa che non torna». E ciò si riferisce a... All’affaire Roberto Suarez, che mi hanno sabotato in ogni modo. E «High Times» è stato il solo organo di stampa ad aver fiutato la pista giusta. Se avessi scritto a loro invece che a «Newsweek», avrebbero svelato il caso. Riprendiamo dall’inizio. Com’è entrato nella DEA? Quand’ero nella
polizia militare, per una storia del cazzo, un giorno un tipo mi
ha piantato una pistola nello stomaco e ha premuto il grilletto.
Il colpo non è partito. Questa vicenda ha provocato in me
un profondo cambiamento. Ho voluto vivere a cento all’ora.
Pensavo allora che avrei potuto diventare il James Bond degli agenti
infiltrati. Ero bravo nelle infiltrazioni. Parlavo correntemente
lo spagnolo. Conoscevo la strada. Da giovane ero stato un teppista,
arrestato due volte prima dei sedici anni. Ora, ero pagato per andare
a zonzo nel Bronx come da ragazzino. Nel 1965, ero uno dei pochi,
insieme a quelli del fisco, che potevano comprare dei numeri della
bolita, la lotteria clandestina ispanica. Potevo spacciarmi per
chi volevo. Facevo tutto questo senza un vero scopo, giusto come
un gioco che poteva offrirmi una dose di brivido. Fino al momento
in cui scopro che proprio mio fratello, David, era scimmiato di
eroina. Lei era dunque nella DEA fin dalla creazione dell’agenzia? Sì. Nel 1970
sono stato trasferito dall’ufficio ATF (1) alla brigata di
investigazione sulle droghe pesanti alle dogane. Ed è là
che per la prima volta ho avuto a che fare con la CIA. È
stato in occasione del processo Governo degli Stati Uniti vs. Liang-Sae
Tiw et al. Il caso iniziò il 4 luglio 1971, con un arresto
all’aeroporto Kennedy di New York. Il tipo arrestato è
diventato un mio informatore. Faceva venire l’eroina da Bangkok,
in Thailandia. Abbiamo messo le mani sui suoi associati, che organizzavano
la distribuzione su scala nazionale, in una palude della Florida.
E sono andato a infiltrarmi in Thailandia per incontrare il loro
contatto a Bangkok. I signori mi adoravano, ci tenevano a portarmi
con loro fino a Chiang Mai. Ma le cose cominciano ad andar male.
Io non riesco a ricevere i fondi per l’operazione: seguo questo
tipo della mafia, che mente come un cavadenti, e loro cominciano
seriamente a pensare di sopprimermi. Da parte mia, inizio a dare
in escandescenze con i miei superiori. Risultato, a mezzanotte mi
portano all’ambasciata degli Stati Uniti. Vi incontro il capo
delle dogane americane, Joey Jenkins, e un tipo calvo in camicia
guayabera che mi dice: «Lei non andrà a Chiang Mai».
Dopo che se n’è andato, Jenkins si gira verso di me
e mi mormora all’orecchio: «Quel tipo è della CIA».
Allora, eseguendo gli ordini, arresto quello con cui facevo affari
e chiudo il caso. Ho perfino ricevuto una medaglia speciale dal
Dipartimento del Tesoro. Ma non sono riuscito né ad andare
a Chiang Mai né ad arrestare i fornitori. Parecchi anni dopo,
mentre lavoravo per conto della DEA, che aveva in carico le fazioni
tribali del Triangolo d’Oro, ne ho di nuovo sentito parlare.
Era proprio questa rete, che mi si era impedito d’intaccare,
a introdurre l’eroina negli Stati Uniti nascondendola dentro
i cadaveri dei soldati rimpatriati. Ma all’epoca, tutto ciò
che sapevo è che mi si impediva di realizzare il più
grosso sequestro di eroina di tutti i tempi. Nel frattempo suo fratello si è suicidato. Sì, nel 1977. Lasciando scritto: «Non posso più sopportare le droghe». Aveva 34 anni. Il mio desiderio di azione si è decuplicato, del tipo: «Gliela faccio vedere io a quei figli di puttana». In Sudamerica il suo bersaglio era Roberto Suarez, il «re della cocaina». Sì, anche lui mi adorava. Io gli ho parlato solo al telefono, ma lui mi dava del «comandante», lo stesso titolo attribuito a lui. Fu arrestato anni dopo, ma la mia operazione era stata sabotata. La nostra finta famiglia mafiosa si era installata in una casa a Miami. Si fingeva di avere un pacco di grana, e non si aveva un soldo. Teatrino. Il nostro budget per l’intera operazione ammontava a 2500 dollari, subito finiti. In un rapporto della DEA (Operation Hun: A Chronology) sta scritto che esistevano prove sufficienti per incolpare l’intero governo boliviano. E la CIA ha bloccato tutto perché metteva in pericolo i loro programmi. Nel rapporto, si legge: «un’altra agenzia», il solito eufemismo. Io mi spacciavo
per un compare mezzo siciliano mezzo portoricano, Miguel Luis Garcia,
e loro hanno abboccato. Pagai 9 milioni di dollari a José
Gasser e Alfredo «Gutucci» Gutierrez attraverso una banca
di Miami, mentre i nostri aerei sorvolavano la giungla boliviana,
e i nostri ragazzi misero le mani su una mezza tonnellata di pasta
di coca. Regolai i dettagli del contratto con Roberto Suarez dopo
Buenos Aires e saltai su un aereo per Miami. Gli si misero sotto
gli occhi i 9 milioni in contante. Il tutto non durò più
di due ore. Quelli dei desaparecidos? Sì. Mi è difficile dirvi quanto li odio quei signori là. Ma io ero un miracolato, non un nazi. Così, già prima di sostenere la Contra in Nicaragua, la CIA proteggeva i cartelli sudamericani? Ho cercato di appurarlo. Ho scoperto che il padre di José Gasser era stato uno dei fondatori della Lega anticomunista mondiale. E che era in contatto con la CIA dall’inizio degli anni Sessanta. Per il mio primo colpo portato a segno in Bolivia, che «Penthouse» ha definito la più grande truffa di tutti i tempi, avevamo bisogno dell’aiuto del governo boliviano. A quell’epoca, nel 1980, era al potere Lidia Gueiler. Era alla testa di un governo liberale, proibizionista convinta, e ci ha aiutato. Tanto che i trafficanti sono poi andati a raccontare ai loro corrispondenti della CIA che Lidia Gueiler era una militante di sinistra. Ecco perché il governo degli Stati Uniti ha sostenuto la «rivoluzione» in Bolivia: facendo venire degli argentini, sbloccando fondi segreti ecc. Tutti sanno che i trafficanti di droga sono capitalisti. Sono sempre anticomunisti! [Risate]. Chi finì in prigione, dopo l’operazione Hun? M.L.: Il pesce più
grosso, «Papo» Mejia, uno degli assassini più dementi
mai nati in Colombia. E quella bellissima donna, Sonia Atala, la
«Regina della cocaina» boliviana. Vendeva più cocaina
lei di qualunque altro essere vivente. Disponeva di truppe scelte,
e un potere di morte su chiunque, dappertutto e sempre. Nel 1980,
di fatto, salì al potere. Nel 1982 rimasi completamente paralizzato
dalle inchieste e dagli attentati contro di me. Mi trasferirono
al Quartier Generale della DEA. Venni pedinato, il mio telefono
fu messo sotto controllo. Tappa successiva, mi domandarono se ero
pronto ad accettare una missione di infiltrazione. Avrei fatto patti
col diavolo pur di riuscire ad allontanarmi dal Quartier Generale
della DEA. Domandai: «Di che affare si tratta?», e mi
risposero: «Quella donna, Sonia Atala. Vogliamo che tu ci vada
a vivere insieme». Aveva deciso di collaborare. Il suo potere
era diventato tale che il «ministro della cocaina» della
Bolivia, Luis Arce Gomez (cugino di Roberto Suarez), l’aveva
presa di mira e cercava di toglierla di mezzo. Dopo aver incassato
due milioni di dollari da Papo Mejia, i suoi fornitori rifiutarono
di effettuare la consegna. Papo le disse: «O mi restituisci
i soldi, o ti uccido tutta la famiglia». Adesso erano i colombiani,
oltre ai boliviani, a volerle fare la pelle. Lei andò direttamente
alla DEA. E si pensò a me come suo compagno. Cosa intende per «truppe scelte naziste» a sua disposizione? Intendo dire mercenari europei addestrati da Klaus Barbie («il macellaio di Lione», ufficiale della Gestapo ricercato). La sua villa a Santa Cruz, in Bolivia, era soprannominata la «casa della tortura». Aveva spesse mura e tutto l’equipaggiamento necessario. E lei abitava con quella donna a Tucson? Sì. Allora lei vendeva droga. Si è fatta pizzicare mentre vendeva a due infiltrati della DEA, due agenti del Texas, che sono stati obbligati a non arrestarla. È tutto scritto nero su bianco in The Big White Lie. I nomi, le date, i luoghi e i momenti.è Ci ha fatto l’amore? No. Potevano sottopormi in ogni istante alla macchina della verità.. L’operazione Trifecta fu il vostro tentativo successivo per far cadere la mafia colombiana? Esatto. Il nostro obiettivo era la Corporacion, organizzazione nata dalla rivoluzione. Noi avevamo anche preso di mira l’intero governo messicano, inclusa l’équipe del futuro presidente Carlos Salinas. E, una volta di più, dovevamo renderci conto che il Dipartimento di Giustizia faceva tutto il possibile per insabbiare la faccenda. Fino a far sì che il ministro della Giustizia, Edwin Meese chiamasse il suo collega messicano per avvertirlo! Ancora una volta, perché? Il futuro presidente, Salinas, assicurava ai nostri politici l’appoggio al NAFTA (2). Nello stesso tempo, i suoi subordinati raccontavano a me, «Luis Miguel Garcia», padrino di mafia mezzo siciliano, che una volta al potere Salinas, il Messico si sarebbe spalancato al traffico. Ed è andata proprio così. Esattamente! E tutto questo è disponibile in un video. Ma se gli americani avessero saputo del nocciolo della faccenda, niente nafta! Avete comunque arrestato il colonnello Jorge Carranza, figlio del fondatore del Messico moderno. Esatto, il figlio di Venustiano Carranza, il George Washington messicano! Stava seduto davanti a me in alta uniforme, e mi assicurava che avrei potuto far cadere il governo. E intanto il video filmava. E che ne è stato di tutta quella gente? Sono tutti liberi. Carranza è stato assolto in appello. Io ho scritto un memoriale che racconta come il governo abbia fatto di tutto per demolire l’affaire. Se mi si fosse lasciato andare avanti, avrei incontrato i veri padrini della Corporacion, in particolare il ministro della Difesa messicano, Arevalo Guardoqui. Mi era stato combinato un appuntamento con lui, sempre sotto l’occhio della telecamera! Perché non è successo niente? Bisogna chiederlo a loro. Io sono andato alla trasmissione di McNeil e Lehrer, e il vero capo della DEA, Terry Burke, si è rifiutato di rispondere in onda alle mie accuse. Ha detto: «Voi capite, questo ragazzo è implicato in un affare commerciale», un riferimento al mio contratto editoriale, probabilmente. Oggi, Luis Arce Gomez e Roberto Suarez sono entrambi in prigione. Sì. Arce Gomez negli USA e Roberto Suarez in Bolivia. Se si può chiamare quella una prigione! Vive nel lusso. Nel suo romanzo, Triangle of Death, molti personaggi sono riconoscibili, li si è già incontrati in altri suoi libri. Il fatto è che non si tratta veramente di immaginazione. Il Triangolo della morte è il vero nome dell’organizzazione creata da un ex capo della Gestapo, Augusto Ricord. Costui è stato condannato a morte in contumacia in Francia. Metteva in atto operazioni in Paraguay col sostegno della CIA. Volete una prova della potenza di quest’organizzazione? Un’inchiesta delle dogane, iniziata con una partita di eroina ordinata dalla mafia italiana al Triangolo della morte, si concluse con incriminazioni in tutto il mondo. Ma il Paraguay si rifiutò fermamente di consegnare Augusto Ricord, finché Nixon non minacciò un’invasione. Allora cedette. La nostra prima reazione fu di farne dono alla Francia. Ma non lo volevano! Ci dissero: «L’avete voi, tenetevelo!». Incriminato negli USA e condannato a una pena detentiva, nel giro di due anni è stato rilasciato. È rientrato in Paraguay ed è morto in libertà. Avete dunque le prove di tutto, perché allora farne un romanzo? Nessuno legge altro. La gente è persuasa che le storie narrate da Tom Clancy siano vere. Ho visto gente piangere alla rappresentazione teatrale di Clear and Present Danger. Io mi trattenevo per non urlare: «È una menzogna, è tutta propaganda!» ma la gente ci crede. Allora abbiamo deciso di scrivere un thriller che mettesse in scena la vera CIA, perché adesso so che la gente avrà più paura di questo che di tutti i documentari del mondo! Suo figlio Keith era nella polizia di New York. È stato ucciso in servizio. Il 28 dicembre 1991. Stava cercando di impedire un furto. L’uomo che ha ucciso mio figlio era uno scimmiato di crack che aveva già ucciso altri due uomini, imprigionato due volte, e due volte rilasciato. Di recente lei ha pubblicamente proposto al governo della Costa Rica di arrestare Oliver North perché risponda alle accuse di traffico di droga davanti alla giustizia di quel Paese? La Corte Suprema
degli Stati Uniti ha deciso che i nostri agenti potevano intervenire
in altri Paesi per arrestare persone che avessero infranto le nostre
leggi. Ebbene, Oscar Arias, premio Nobel e presidente costaricano,
ha proibito a vita l’ingresso nel suo Paese a Oliver North,
per associazione a delinquere allo scopo di far transitare dal Costa
Rica la droga destinata agli Stati Uniti! Io ho portato questa logica
fino in fondo: visto che gli USA avevano legalizzato arresti di
questo tipo, ch’io avevo già praticato per conto della
DEA, sarei stato felice di farne approfittare il Costa Rica!
(1)
Bureau for Alcohol, Tobacco and Firearms: un corpo di polizia specializzato
in alcol, tabacco e armi da fuoco. L’intervista a Michael Levine appare per gentile concessione della rivista «High Times».
|
|||
| precedente | |||

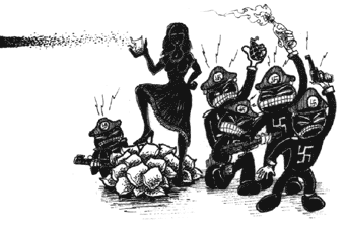 La
«guerra alle droghe», proclamata da Ronald Reagan all’inizio
degli anni Ottanta, per quanto assurda, sembrava giustificarsi alla
luce della tragedia del crack, che distruggeva letteralmente interi
pezzi delle maggiori città americane, oltre alle vite di
chi vi abitava. La crudeltà delle droghe, fino ad allora
riscontrabile negli effetti dell’eroinomania, diventava incontestabile
di fronte ai danni distruttivi del crack. In realtà a sponsorizzare
il crack era allora la CIA, sotto la direzione dello stesso Reagan.
Già si sapeva, fin dallo scandalo dell’Irangate, che
la CIA, e più particolarmente la cellula di Oliver North,
direttamente connessa alla Casa Bianca, aveva finanziato i ribelli
anticomunisti affidando loro una parte del flusso della cocaina
che, dalla Colombia, irrigava gli Stati Uniti. Il rapporto della
commissione Kerry (1989) non lascia alcun dubbio al riguardo. Nel
1996, Gary Webb pubblicò su un quotidiano della Silicon Valley,
il «San José Mercury News», una serie di articoli
che riferivano dei risultati di un anno di ricerche: The Dark Alliance.
Per portare a termine questa inchiesta, realizzata con la collaborazione
del corrispondente del suo giornale in Nicaragua, Webb aveva viaggiato
e intervistato molti personaggi, ma si era basato soprattutto sulle
carte giudiziarie pubblicate a proposito di affari in corso o recenti.
Fu così che si apprese come la CIA proteggesse una rete di
trafficanti nicaraguensi che faceva arrivare la cocaina dalla Colombia
a South-Central, Los Angeles. Essi rifornivano in modo particolare
Freeway Rick, leggendario DEAler che fece fortuna col boom del crack,
oggi in prigione con una condanna all’ergastolo. L’ondata
di crack era un fenomeno di marketing che aveva lo scopo di smaltire
rapidamente grossi quantitativi di coca, destinandola non più
ai ricchi, ma ai poveri, un enorme mercato conquistato a passo di
carica. Ciò coincide con gli anni in cui Reagan era alle
prese con il veto del Congresso usa, che gli proibiva di sovvenzionare
i Contras in Nicaragua.
La
«guerra alle droghe», proclamata da Ronald Reagan all’inizio
degli anni Ottanta, per quanto assurda, sembrava giustificarsi alla
luce della tragedia del crack, che distruggeva letteralmente interi
pezzi delle maggiori città americane, oltre alle vite di
chi vi abitava. La crudeltà delle droghe, fino ad allora
riscontrabile negli effetti dell’eroinomania, diventava incontestabile
di fronte ai danni distruttivi del crack. In realtà a sponsorizzare
il crack era allora la CIA, sotto la direzione dello stesso Reagan.
Già si sapeva, fin dallo scandalo dell’Irangate, che
la CIA, e più particolarmente la cellula di Oliver North,
direttamente connessa alla Casa Bianca, aveva finanziato i ribelli
anticomunisti affidando loro una parte del flusso della cocaina
che, dalla Colombia, irrigava gli Stati Uniti. Il rapporto della
commissione Kerry (1989) non lascia alcun dubbio al riguardo. Nel
1996, Gary Webb pubblicò su un quotidiano della Silicon Valley,
il «San José Mercury News», una serie di articoli
che riferivano dei risultati di un anno di ricerche: The Dark Alliance.
Per portare a termine questa inchiesta, realizzata con la collaborazione
del corrispondente del suo giornale in Nicaragua, Webb aveva viaggiato
e intervistato molti personaggi, ma si era basato soprattutto sulle
carte giudiziarie pubblicate a proposito di affari in corso o recenti.
Fu così che si apprese come la CIA proteggesse una rete di
trafficanti nicaraguensi che faceva arrivare la cocaina dalla Colombia
a South-Central, Los Angeles. Essi rifornivano in modo particolare
Freeway Rick, leggendario DEAler che fece fortuna col boom del crack,
oggi in prigione con una condanna all’ergastolo. L’ondata
di crack era un fenomeno di marketing che aveva lo scopo di smaltire
rapidamente grossi quantitativi di coca, destinandola non più
ai ricchi, ma ai poveri, un enorme mercato conquistato a passo di
carica. Ciò coincide con gli anni in cui Reagan era alle
prese con il veto del Congresso usa, che gli proibiva di sovvenzionare
i Contras in Nicaragua. 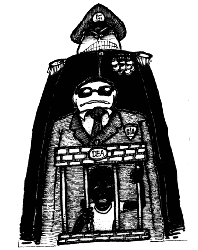 E
con gli anni della «guerra alle droghe». Da una parte
venivano arrestati a tutto spiano – come accade tuttora –
i neri e gli ispanici dei ghetti, il più delle volte per
infrazioni alle leggi sugli stupefacenti. Dall’altra li si
riforniva della roba che avrebbe fatto loro commettere i crimini
per cui li si imprigionava! Questo incredibile cinismo merita attenzione.
Passiamo la parola a Gary Webb e Michael Levine. Ex poliziotto della
«narcotici», Levine è anche testimone a carico
nella grande istruttoria informale che il popolo ha aperto contro
lo Stato criminale. Sua è la chiusa: «ho passato praticamente
tutta la mia vita di adulto all’interno di questo sistema,
credendo fermamente che il fine giustificasse i mezzi. Sono arrivato
a imparare che questo modo di pensare è quanto di peggio
ci possa capitare; è proprio questo modo di pensare che rischia
di distruggere le nostre libertà». E lungo il percorso,
quante vite distrutte?
E
con gli anni della «guerra alle droghe». Da una parte
venivano arrestati a tutto spiano – come accade tuttora –
i neri e gli ispanici dei ghetti, il più delle volte per
infrazioni alle leggi sugli stupefacenti. Dall’altra li si
riforniva della roba che avrebbe fatto loro commettere i crimini
per cui li si imprigionava! Questo incredibile cinismo merita attenzione.
Passiamo la parola a Gary Webb e Michael Levine. Ex poliziotto della
«narcotici», Levine è anche testimone a carico
nella grande istruttoria informale che il popolo ha aperto contro
lo Stato criminale. Sua è la chiusa: «ho passato praticamente
tutta la mia vita di adulto all’interno di questo sistema,
credendo fermamente che il fine giustificasse i mezzi. Sono arrivato
a imparare che questo modo di pensare è quanto di peggio
ci possa capitare; è proprio questo modo di pensare che rischia
di distruggere le nostre libertà». E lungo il percorso,
quante vite distrutte? 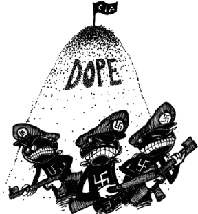 del
pezzo forte in
del
pezzo forte in Michael
Levine ha alle spalle una carriera di venticinque anni come agente
infiltrato al servizio di quattro agenzie federali americane nei
cinque continenti. Egli è diventato il più noto e
aspro fra i critici della Drug Enforcement Administration (DEA).
Dal Triangolo d’Oro alle Ande, tutti i suoi sforzi per mettere
le mani sui pezzi grossi del traffico sono stati, come ci spiegherà,
sabotati dai burocrati della DEA e dalle pressioni della CIA. La
storia delle sue operazioni contro la mafia boliviana della cocaina
è raccontata dettagliatamente nei suoi libri Deep Cover (Delacorte,
1990) e The Big White Lie. Il suo ultimo libro, Triangle of death
(Dell, 1996), scritto in collaborazione con la moglie, Laura Kavanau,
è un giallo basato sulla sua esperienza professionale. È
anche ospite fisso della trasmissione radiofonica settimanale Expert
Witness, in onda sulla radio newyorkese wbai-fm, nei cui studi è
stata realizzata questa intervista.
Michael
Levine ha alle spalle una carriera di venticinque anni come agente
infiltrato al servizio di quattro agenzie federali americane nei
cinque continenti. Egli è diventato il più noto e
aspro fra i critici della Drug Enforcement Administration (DEA).
Dal Triangolo d’Oro alle Ande, tutti i suoi sforzi per mettere
le mani sui pezzi grossi del traffico sono stati, come ci spiegherà,
sabotati dai burocrati della DEA e dalle pressioni della CIA. La
storia delle sue operazioni contro la mafia boliviana della cocaina
è raccontata dettagliatamente nei suoi libri Deep Cover (Delacorte,
1990) e The Big White Lie. Il suo ultimo libro, Triangle of death
(Dell, 1996), scritto in collaborazione con la moglie, Laura Kavanau,
è un giallo basato sulla sua esperienza professionale. È
anche ospite fisso della trasmissione radiofonica settimanale Expert
Witness, in onda sulla radio newyorkese wbai-fm, nei cui studi è
stata realizzata questa intervista. 
