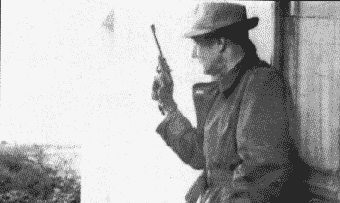|
|
|||
BURROUGHS
In Francia, Les Éditions Du Seuil hanno recentemente pubblicato Gentleman Junkie. la vie et l’oeuvre de William S. Burroughs, saggio bio-bibliografico firmato dall’americano Graham Caveney e ampiamente illustrato. Bel libro, anche se la stampa, un nero spento su sfondo acquerellato rossastro, rende la lettura assai faticosa e finisce col dare al lettore la sensazione di avere la mixomatosi. Ignoro se Burroughs abbia potuto vedere questo libro prima della sua morte, ma l’idea di un testo che procuri la mixomatosi al suo lettore l’avrebbe sicuramente fatto ridere di gusto. Era proprio nel suo stile. A margine di questa pubblicazione, «Stupefacente!» ha ritenuto giusto richiamare le prese di posizione, sulle diverse droghe, del solo drogato giunto allo status di leggenda vivente nell’arco di questo mezzo secolo segnato dalla globalizzazione del fenomeno di consumo delle droghe
|
|||
|
«Burroughs non ha creato solo metafore, bensì generazioni intellettualmente attive dotate di uno spirito loro proprio.»
William Seward Burroughs (non sopportava di vedere scritto il suo cognome senza l’iniziale del suo secondo nome) nasce il 5 febbraio 1914 a Saint Louis, Missouri, in piena Bible Belt (la cosiddetta «Cintura biblica», gli Stati ultra-puritani che formano il «cuore» degli usa), dentro quella che lui chiama «società matriarcale malsana». Figlio di un commerciante timorato (erede dell’inventore delle macchine calcolatrici che portano il suo nome, ma le cui fortune familiari si erano volatilizzate nel crollo della Borsa del 1929) e di una bigotta terrorizzata dalle funzioni corporali ma affascinata dalla magia, WSB inizia a scrivere già all’età di otto o nove anni. Il suo primo testo si intitola Autobiografia di un lupo. Già a quest’epoca, il suo aspetto gracile e il suo look inquietante lo fanno passare per «un cane assassino di greggi». Più tardi, laureato a Harvard, tenta inutilmente di farsi assumere dai Servizi segreti. Negli anni Quaranta, si trasferisce a New York, dove lavora come sterminatore di scarafaggi. Qui il suo giovane amico Kerouac lo sprona a scrivere, attività che gli ripugna. Il suo primo romanzo, Junkie (La scimmia sulla schiena), viene tuttavia pubblicato nel 1953. Qualche decennio dopo, l’autore lascia dietro di sé una trentina di opere di fiction, una mezza dozzina di saggi o di libri di evasione, un’autobiografia e una discografia che comprende otto album. Howard Brookner gli ha dedicato un film documentario nel 1983. Il papa dell’underground, guru della Beat generation, maestro della controcultura, nonno dei punk e «musa» dell’heavy metal ha scoperto come liberarsi del proprio corpo il 23 agosto 1997, all’età di 73 anni.
Nel
suo Gentleman Junkie Graham Caveney afferma che i più grandi
fan di Burroughs non hanno ritenuto necessario leggerne i libri. Questo
atteggiamento è senza alcun dubbio ovvio in un contesto in cui
il marketing prevale continuamente sull’opera. Vendendo così
un autore di cui, presumibilmente, nessuno è obbligato a reggere
la lettura, la bottega letteraria recupera comunque il più infrequentabile,
il più detestabile, il più ignobile, diranno alcuni, dei
romanzieri politicamente scorretti.
L’apporto principale di Burroughs romanziere Burroughs è probabilmente l’unico romanziere del suo tempo che abbia evocato intimamente la vita quotidiana di un drogato. «L’intossicazione è una malattia metabolica e non un problema per la polizia più che la tubercolosi o l’avvelenamento da radio». Ha così fornito una serie di riferimenti culturali a una popolazione tradizionalmente deprivata del diritto di parola (se non di pensiero) – e questo sembra essere effettivamente l’apporto principale, se non cardinale, delle sue fiction. La sua cruda visione del mondo dei tossici gli ha d’altronde permesso di formulare una critica radicale del Sistema corrotto, ossessionato dal controllo ma obbligato a generare il caos per raggiungere i suoi fini: moltiplicare all’infinito gli strumenti di controllo. In ultima analisi, la proliferazione degli strumenti di controllo ordita dagli Stati non mira ad altro che ad accrescere l’alienazione e l’oppressione, «criminalizzando» consistenti fasce di popolazione – a cominciare dai fruitori di sostanze illecite –, continuando con i fumatori di... tabacco e altre sostanze inebrianti. Così, il sistema funziona a circuito chiuso, circolo vizioso perfetto che genera sempre più caos mentre moltiplica gli strumenti di repressione. E se noi tutti siamo incastrati in questo ingranaggio, il junky rimane la vittima tipo, l’antieroe sociale per eccellenza.
Negli
Stati Uniti dell’immediato dopoguerra, essere un drug-addict (tossicomane),
un dope fiend («demone della droga») era peggio che essere
comunista o gay.
Essendosi
distaccato dall’eroina grazie al trattamento di apomorfina del
dottor Dent, del quale non smetterà poi di farsi promotore (con
grave danno dell’Accademia di medicina e dell’industria farmaceutica,
il cui ovvio interesse non è la salute ma la malattia), Burroughs
sperimenta i funghi allucinogeni durante l’«estate psichedelica»
del 1961, poi l’LSD nell’autunno dello stesso anno –
il tutto, grazie, ovviamente all’ineffabile Timothy Leary. Rispetto
all’LSD, Bill è tuttavia lontano dal manifestare lo stesso
entusiasmo di Leary. Definisce come «progetto pestilenziale»
le sue esperienze di disseminazione a tutto campo. «I giovani sono
spinti deliberatamente in vicoli ciechi [...], cullati in morbosi stati
d’amore, di armonia con il Tutto e di accettazione di qualunque
cosa.» In quest’epoca «pionieristica», William non
è affatto al suo primo incontro con gli allucinogeni più
radicali.
Il
vaccino capace di seppellire il virus della droga nelle profondità
del passato, è stato effettivamente scoperto: è il trattamento
ad apomorfina [...]. Testimonianza a proposito di una malattia, introduzione
al Pasto nudo.
L’unica
sostanza psicoattiva che incontra il favore di WSB è alla fine
la cannabis. «Senza dubbio, questa droga è utilissima all’artista
perché attiva associazioni libere altrimenti inaccessibili. Devo
molte scene del Pasto nudo proprio alla cannabis.»
Leggere la maggior parte dei romanzi
di Burroughs è considerato a buon diritto un esercizio arduo,
ma il lettore curioso potrà ripiegare su fiction più brevi,
come Le ultime parole di Dutch Schultz, oppure Sterminatore!, raccolta
di novelle buttate giù velocemente, di facile lettura. Il primo
romanzo, Junkie (La scimmia sulla schiena) è scorrevole come
un romanzo giallo un po’ particolare. Comunque, a chi volesse prendere
di petto Burroughs si suggerisce naturalmente Il pasto nudo. Il segreto
per abbordarlo sta nel consiglio che un secondino messicano aveva dato
all’Autore dopo che questi aveva ucciso la moglie con un maledetto
colpo di pistola: «Necesita mucha calma y resignation».
A mo’ di conclusione: WSB, premio Rebel 1999 Un tardivo comunicato proveniente dal pianeta Lurida Topaia ci informa che il 32 dicembre scorso è stato attribuito a William S. Burroughs per l’insieme della sua opera il premio Rebel per la letteratura 1999. Stamattina un vecchio topo di fogna mi ha consegnato il verdetto ufficiale della giuria, appositamente drogato, come esige la legge del luogo. Per un ritardo dovuto a un interminabile sciopero dei tecnici del subcosmo, la povera bestia incaricata di portare il messaggio, a noi altri abitanti della profonda TransPlutonia, fu obbligata a servirsi di parte del dispaccio come dose personale, strappando disgraziatamente il commento del vincitore. Citando un brano di The Job, Burroughs avrebbe probabilmente dichiarato: «È quando cade ogni interesse, che scompare la vergogna»... O ancora, come scrive in My Education (l’autobiografia pubblicata negli Stati Uniti nel 1994): «Per diventare uno scrittore venerato, basta sintonizzarsi, con il proprio posto riservato in un ristorante discreto e molto raffinato. Magari anche all’Accademia. Perché no?». In ogni caso, alle onorificenze Burroughs ha preferito «immergersi nei bassifondi della società, veloce, agile, micidiale come un barracuda»... Probabilmente così «la vergogna scomparirebbe». Quale vergogna? Quella di essere un pornografo, perdio, e anche peggio...: un junky, il Junkie, rappresentante adulterato di una banda di Terrestri con i quali non c’è ombra di empatia: «Molto semplicemente, non posso sopportare gli indigeni di questo pianeta». Quanto alla leggenda, Paul Bowles dice di lui: «Imparando a conoscerlo, ho capito che la leggenda esisteva malgrado lui e non per sua volontà: se ne fotteva».
Fonti (per sapere tutto su Burroughs... senza averlo mai letto)
|
|||
| precedente | |||