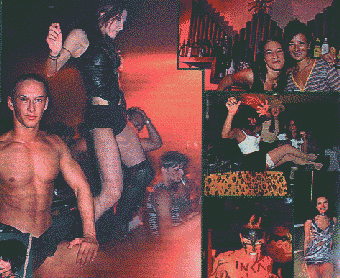Qualche domanda

 Siamo
alle solite, di nuovo sentiamo parlare di droghe e sostanze a sproposito.
Mesi e mesi di lavoro buttati via per qualche articolo di giornale
disinformato e bugiardo. Di nuovo l’emergenza, la repressione,
le morti, i presunti colpevoli. Di nuovo i luoghi comuni, la forca,
le bugie, le grida e lo sdegno. Poi il silenzio, appena trovata un’altra
emergenza. Di nuovo buio e oscurantismo. Le droghe, si sa, sono un
argomento spinoso. Soprattutto l’ecstasy che, con la sua diffusione,
causata anche dalla lotta alla droga delle potenze occidentali negli
anni Novanta, ha notevolmente cambiato le rotte commerciali del narcotraffico,
collegando da vicino i cartelli e i produttori (non dimentichiamoci
che l’MDMA è prodotta in laboratori clandestini della
civilizzata e unita Europa), dando vita, secondo le parole del dott.
Gatti del Ser.T di Milano, a “una nuova rivoluzione industriale”.
Si gioca con la pelle dei ragazzi, si fa campagna elettorale, si spendono
soldi. Il governo italiano dal 1990 a oggi ha speso ben 2 mila miliardi
per il fondo antidroga con i risultati che conosciamo; peggio ha fatto
l’allora presidente americano George Bush, che con la sua amministrazione
diede vita all’operazione War on Drugs: 17 miliardi di dollari
investiti; risultato: 1% di consumatori di cocaina in meno!. Chi lavora
da anni nel campo dell’informazione sugli effetti e i rischi
delle cosiddette nuove sostanze non può che essere indignato
per come la questione è stata trattata. E allora facciamo un
po’ di chiarezza, un piccolo passo indietro è necessario
per poter ripuntualizzare le nostre strategie.
Siamo
alle solite, di nuovo sentiamo parlare di droghe e sostanze a sproposito.
Mesi e mesi di lavoro buttati via per qualche articolo di giornale
disinformato e bugiardo. Di nuovo l’emergenza, la repressione,
le morti, i presunti colpevoli. Di nuovo i luoghi comuni, la forca,
le bugie, le grida e lo sdegno. Poi il silenzio, appena trovata un’altra
emergenza. Di nuovo buio e oscurantismo. Le droghe, si sa, sono un
argomento spinoso. Soprattutto l’ecstasy che, con la sua diffusione,
causata anche dalla lotta alla droga delle potenze occidentali negli
anni Novanta, ha notevolmente cambiato le rotte commerciali del narcotraffico,
collegando da vicino i cartelli e i produttori (non dimentichiamoci
che l’MDMA è prodotta in laboratori clandestini della
civilizzata e unita Europa), dando vita, secondo le parole del dott.
Gatti del Ser.T di Milano, a “una nuova rivoluzione industriale”.
Si gioca con la pelle dei ragazzi, si fa campagna elettorale, si spendono
soldi. Il governo italiano dal 1990 a oggi ha speso ben 2 mila miliardi
per il fondo antidroga con i risultati che conosciamo; peggio ha fatto
l’allora presidente americano George Bush, che con la sua amministrazione
diede vita all’operazione War on Drugs: 17 miliardi di dollari
investiti; risultato: 1% di consumatori di cocaina in meno!. Chi lavora
da anni nel campo dell’informazione sugli effetti e i rischi
delle cosiddette nuove sostanze non può che essere indignato
per come la questione è stata trattata. E allora facciamo un
po’ di chiarezza, un piccolo passo indietro è necessario
per poter ripuntualizzare le nostre strategie.

Qualche
numero
L’MDMA fu sintetizzata
nel 1898 e brevettata dalla Merck nel 1914 come farmaco dimagrante.
Solo alla fine degli anni Settanta si ha un uso ricreazionale e di
socialità della sostanza. Tra il 1975 e il 1980 viene usata
in psicoterapia come coadiuvante della relazione tra paziente e terapeuta.
Nel 1985 la dea statunitense la mette al bando dopo una discutibile
ricerca su cavie animali (neurotossicità e danni cerebrali
permanenti è l’altrettanto discutibile responso). L’uso
in psicoterapia dura comunque fino al ’92 (addirittura fino al
’93 in Svizzera). Per quanto riguarda l’Italia, nel ’91
viene segnalato il primo paziente al Ser.T di Padova (diretto dall’equipe
del dottor Schifano, all’avanguardia in Italia nella prevenzione
dei rischi da abuso di “nuove” sostanze) per problemi dovuti
all’assunzione di MDMA e nel ’92, sempre in Veneto, il primo
morto accertato (overdose, 16 pastiglie ingerite).
Che non sia un fenomeno emergenziale del nuovo millennio, almeno per
quanto riguarda l’Europa, è dimostrato dal Criminal Justice
Act varato nel 1995 in Inghilterra che vietava l’organizzazione
di raves illegali per far fronte al dilagare del consumo di metanfetamine
(ma anche per imbrigliare una generazione che aveva scelto di autorganizzarsi
anche il divertimento); all’epoca veniva stimato che erano ben
500.000 le compresse consumate nei week-end inglesi. In Italia le
cifre non toccano questi livelli (e neanche le misure repressive),
comunque, secondo una recente indagine, sono circa 100 mila le persone
tra i 15 e i 25 anni che fanno uso di MDMA.
Il mai dimenticato Primo Moroni fece un’indagine in due fasi,
nel 1989 e nel biennio ’91-92, sulle trasformazioni produttive
del Nord-Est italiano disegnando già allora una situazione,
per quanto riguardava i consumi di nuove sostanze, perlomeno preoccupante.
Diecimila furono le persone contattate. Il quadro che ne veniva fuori
era molto significativo: lavoratore giovane con una settimana lavorativa
di 50-60 ore (sia dipendente, che autonomo, che in nero), alta percentuale
di abbandono scolastico, vita in famiglia almeno fino ai 30 anni (il
70% degli intervistati), lavoro just in time, dipendenza da uno stile
di vita, esibizione delle merci (auto di grossa cilindrata, vestiti
firmati) per compensare lo status lavorativo e sociale e per annullare
la propria condizione di dipendenza lavorativa. Questa categoria sociale
fu seguita da Moroni e dagli altri ricercatori nei luoghi dove consumavano
il loro tempo libero (bar e discoteche per lo più). Fu rilevato
un considerevole consumo delle sostanze, o forse è meglio dire
un policonsumo visto che nel corso di una serata (costo della serata
200-250 mila lire, che fa circa un milione al mese) venivano tranquillamente
mischiati alcol, cocaina e le prime pasticche di ecstasy sul mercato.
Primo Moroni concludeva la sua ricerca affermando che l’ecstasy
era una droga legata a filo doppio con la società post-fordista,
era un naturale complemento a questa situazione (ti sballi nel week-end,
poi torni tranquillo al lavoro, poi ti risballi nel week-end e così
via). Questa ricerca pioneristica già ci permetteva di affermare
che la dipendenza da MDMA non è fisica (non dà crisi
di astinenza) ma psicologica (dipendenza da un modello di vita, da
uno status, da un evento).

Qualche
domanda
Ma che cosa sta succedendo? Chi è
il colpevole delle morti degli ultimi mesi strumentalizzate dai media?
Esiste un’ecstasy killer? A che punto sono le ricerche sulla
presunta neurotossicità della sostanza? A chi giova questo
ennesimo allarmismo sociale?
Innanzitutto va precisato che tre sono i fattori decisivi circa l’assunzione
delle sostanze, grazie anche agli studi del ricercatore americano
dottor Charles Grob (Conferenza di Parigi 1997 sulla riduzione del
danno in Europa):
- 1) Il set cioè
l’umore, la personalità, le aspettative, lo stato d’animo
di colui che assume sostanze entactogene. L’MDMA funziona da
catalizzatore ed è evidente che persone che assumono questo
tipo di sostanze in condizioni fisiche e mentali precarie possono
incorrere in bad trip o avere conseguenze psichice rilevanti.
- 2) Il setting cioè
il terreno psichico, sociale e culturale ove si consuma l’esperienza.
Un conto è assumere xtc in un bosco, in una situazione tranquilla
e insieme ad amici, diverso è consumare all’interno
di una discoteca affollata, senza spazi di aerazione e con scarsa
possibilità di rinfrescarsi e di riprendersi (soprattutto
se si è fatto anche uso di alcol e di altre sostanze).
- 3) Il dosaggio,
in ogni ecstasy il principio attivo (MDMA) dovrebbe variare dai
100 ai 120 mg (1,5 mg per kg di peso corporeo della persona che
assume). Vi sono quindi delle differenze tra consumatori magri e
consumatori robusti, tra maschi e femmine ecc. Il problema è
che non si sa mai quanto principio attivo c’è in ogni
singola pasticca, e soprattutto da quali altre sostanze questa è
composta. L’ipotesi di allestire laboratori di analisi davanti
ai luoghi di consumo (discoteche, ma anche stadi e centri sociali)
è una soluzione che viene respinta dalle politiche proibizioniste
vigenti in Europa (con la sola eccezione dell’Olanda).
Molto importante, nell’assunzione
di composti psicoattivi (non dimentichiamo che le cosiddette nuove
droghe sono combinazioni di vecchie sostanze), è il rispetto
di due tempi fondamentali: “l’equilibrio neurofisico”
e “l’integrazione dell’esperienza” (Giorgio Samorini,
psiconauta in “Percorsi Psicoattivi”, seminario di studio
Leoncavallo, Milano 1997). Tra l’assunzione di un’ecstasy
e l’altra dovrebbero passare 40 giorni (per i funghi: 5-7 giorni;
per la mescalina: 15 giorni); è evidente che la combinazione
e la poliassunzione delle sostanze complica il rispetto dei tempi.
Sono i policonsumatori quindi i soggetti più a rischio dell’intera
vicenda; infatti alcuni referti di decessi attribuiti all’ecstasy
parlano di assunzione di più sostanze (alcol + xtc + eroina/cocaina).
Per questo, come dice il dottor Edo Polidori del Ser.T di Faenza,
“criminalizzare l’ecstasy significa distogliere l’attenzione,
confondere, non fare informazione corretta”. Anche perché
l’uso di ecstasy nell’arco della vita è transitorio
e non dà intossicazione cronica come alcol ed eroina (quindi
astensione dalla sostanza), ma acuta (quindi autocontrollo e regolamentazione
della sostanza); perciò bisogna fare in modo che il minor numero
di persone accusi problemi, muoia ecc. Importante è che tutti
coloro i quali hanno a che fare con questo fenomeno (operatori del
sociale e della notte, ravers, medici, sperimentatori, giornalisti
ecc.) cerchino di convivere con la sostanza, piuttosto che criminalizzarla.
Da una ricerca fatta nell’inverno dello scorso anno dal Ministero
degli Interni italiano e pubblicata sulla rivista «Reset»
emerge chiaramente che il luogo del consumo e dello spaccio per eccellenza
rimane la discoteca (il 79 % degli intervistati pensa che si possa
recuperare ecstasy in discoteca, un altro 45% afferma che ha visto
circolare droga in discoteca, lo stesso campione di intervistati considera
l’ecstasy una droga leggera: 23% le risposte in questo senso).
Diventa quindi irrinunciabile che nel processo di sensibilizzazione
e informazione sui rischi d’abuso delle nuove sostanze, la discoteca
venga investita, cambiata nell’architettura e nella mentalità
di chi la gestisce, ristrutturata. Sono contrario alla chiusura e
alla criminalizzazione delle discoteche, ma è ora che tutti
si diano una mossa per non essere schiacciati da una parte da politiche
proibizioniste fallimentari e colpevoli, dall’altra dal menefreghismo
e dall’approssimazione di coloro che gestiscono (controllano?)
il mondo della notte.
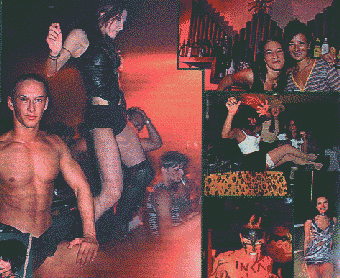

 Siamo
alle solite, di nuovo sentiamo parlare di droghe e sostanze a sproposito.
Mesi e mesi di lavoro buttati via per qualche articolo di giornale
disinformato e bugiardo. Di nuovo l’emergenza, la repressione,
le morti, i presunti colpevoli. Di nuovo i luoghi comuni, la forca,
le bugie, le grida e lo sdegno. Poi il silenzio, appena trovata un’altra
emergenza. Di nuovo buio e oscurantismo. Le droghe, si sa, sono un
argomento spinoso. Soprattutto l’ecstasy che, con la sua diffusione,
causata anche dalla lotta alla droga delle potenze occidentali negli
anni Novanta, ha notevolmente cambiato le rotte commerciali del narcotraffico,
collegando da vicino i cartelli e i produttori (non dimentichiamoci
che l’MDMA è prodotta in laboratori clandestini della
civilizzata e unita Europa), dando vita, secondo le parole del dott.
Gatti del Ser.T di Milano, a “una nuova rivoluzione industriale”.
Si gioca con la pelle dei ragazzi, si fa campagna elettorale, si spendono
soldi. Il governo italiano dal 1990 a oggi ha speso ben 2 mila miliardi
per il fondo antidroga con i risultati che conosciamo; peggio ha fatto
l’allora presidente americano George Bush, che con la sua amministrazione
diede vita all’operazione War on Drugs: 17 miliardi di dollari
investiti; risultato: 1% di consumatori di cocaina in meno!. Chi lavora
da anni nel campo dell’informazione sugli effetti e i rischi
delle cosiddette nuove sostanze non può che essere indignato
per come la questione è stata trattata. E allora facciamo un
po’ di chiarezza, un piccolo passo indietro è necessario
per poter ripuntualizzare le nostre strategie.
Siamo
alle solite, di nuovo sentiamo parlare di droghe e sostanze a sproposito.
Mesi e mesi di lavoro buttati via per qualche articolo di giornale
disinformato e bugiardo. Di nuovo l’emergenza, la repressione,
le morti, i presunti colpevoli. Di nuovo i luoghi comuni, la forca,
le bugie, le grida e lo sdegno. Poi il silenzio, appena trovata un’altra
emergenza. Di nuovo buio e oscurantismo. Le droghe, si sa, sono un
argomento spinoso. Soprattutto l’ecstasy che, con la sua diffusione,
causata anche dalla lotta alla droga delle potenze occidentali negli
anni Novanta, ha notevolmente cambiato le rotte commerciali del narcotraffico,
collegando da vicino i cartelli e i produttori (non dimentichiamoci
che l’MDMA è prodotta in laboratori clandestini della
civilizzata e unita Europa), dando vita, secondo le parole del dott.
Gatti del Ser.T di Milano, a “una nuova rivoluzione industriale”.
Si gioca con la pelle dei ragazzi, si fa campagna elettorale, si spendono
soldi. Il governo italiano dal 1990 a oggi ha speso ben 2 mila miliardi
per il fondo antidroga con i risultati che conosciamo; peggio ha fatto
l’allora presidente americano George Bush, che con la sua amministrazione
diede vita all’operazione War on Drugs: 17 miliardi di dollari
investiti; risultato: 1% di consumatori di cocaina in meno!. Chi lavora
da anni nel campo dell’informazione sugli effetti e i rischi
delle cosiddette nuove sostanze non può che essere indignato
per come la questione è stata trattata. E allora facciamo un
po’ di chiarezza, un piccolo passo indietro è necessario
per poter ripuntualizzare le nostre strategie.