COS’È LA CANAPA
DESCRIZIONE
La tassonomia ufficiale include la Canapa nella famiglia delle Cannabacee o Cannabinacee (Cannabaceae = Cannabinaceae) appartenente all'ordine delle Urticali (Urticales).
Queste sono generalmente piante legnose o erbacce con fiori poco appariscenti, che possono essere isolati o riuniti a gruppi. I fiori sono spesso unisessuali e le piante possono essere monoiche o dioiche. Varia è la morfologia del frutto: in alcune Urticali si hanno frutti secchi (es. canapa, ortica); in altre si hanno infruttescenze (es. albero del pane, fico, gelso). Le foglie sono munite di stipole e in varie parti della pianta possono comparire delle formazioni caratteristiche (es. ghiandolari nelle Cannabacee). L'importanza economica delle Urticali è legata alla produzione di fibre tessili, frutti, droghe, legname, ecc.
Alla famiglia delle Cannabacee appartengono piante erbacee erette o rampicanti, con foglie alterne o opposte. I fiori maschili sono disposti in pannocchie e hanno 5 tepali fusi alla base e 5 stami; quelli femminili sono riuniti in gruppi di 2/6 brattee formanti delle corte spighe. Ciascuno di essi è composto da un calice contenete un ovulo pendulo e da uno o due pistilli. Questa famiglia si suddivide in due generi: Cannabis e Humulus (es. Luppolo). Sono piante della flora spontanea dei paesi a clima temperato o, nel caso dell'Humulus, anche a clima temperato freddo dell'emisfero boreale. Tutte le specie di cannabacee, in misura maggiore la Canapa, attraverso le formazioni ghiandolari precedentemente citate, producono delle secrezioni contenenti lo stesso principio attivo: il delta-9 tetraidrocannabinolo (abbreviato in THC).
La maggior parte dei botanici segue la classificazione di D.E. Janichewsky (1924), un botanico sovietico che studiò vari esemplari di piante selvatiche e classificò la Canapa in tre diverse specie:
Cannabis sativa, alta fino a tre metri e dalla forma piramidale;
Cannabis indica, più bassa, con maggior numero di rami e foglie;
Cannabis ruderalis, alta al massimo mezzo metro e priva di rami.
Nel 1753, Linneo parlò esclusivamente di Cannabis sativa. La sua tesi è stata confermata dai canandesi Small e Cronquist nel 1976: in una proposta di classificazione alternativa a quella di Janichewsky, affermarono che esiste una sola specie molto variabile, C. sativa, con due sottospecie:
sativa, tipica dei paesi settentrionali e usata per fibra e olio;
indica, tipica dei paesi caldi e ricca di resina e THC.
La Canapa è una pianta annuale e dioica, ovvero esistono esemplari con fiori maschili ed altri con fiori femminili. In ambienti particolarmente ostili possono verificarsi casi d'ermafroditismo.
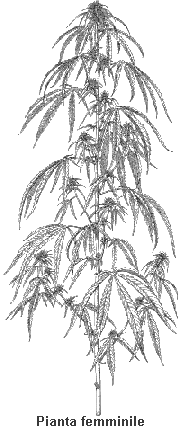
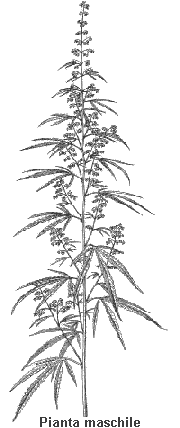
Essa
presenta una lunga radice a fittone e un fusto ruvido la cui
altezza varia da 80 cm a 3 m. In caso di crescita in masse fitte, le
piante sviluppano pochi corti rami con gli internodi lontani,
altrimenti esse presentano fitte ramificazioni, che in alcune varietà
possono essere lunghe come lo stelo centrale. Le foglie sono
opposte, picciolate, palmate, e sono composte da foglioline
lanceolate e seghettate. Inizialmente si sviluppano opposte poi,
durante la fioritura, alternate. Sono composte dapprima di una
fogliolina, poi di 3, 5, 7, fino a un massimo di 13, secondo la
quantità di luce quotidiana.
I fiori femminili, portanti il seme, sono composti da un calice contenete
un ovulo pendulo e da uno o due pistilli. E' nel calice che si trova la più alta concentrazione di resina ed è lì che in caso di fertilizzazione comincia a formarsi il seme. I fiori maschili, di colore bianco - giallognolo, giunti a maturazione rilasciano il polline e la pianta maschio, giunta alla fine del suo ciclo, muore.
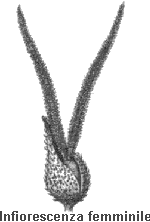
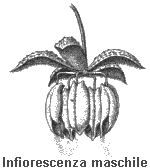
La Canapa risulta essere una pianta di notevole variabilità morfologica e fisiologica, con forme precoci e tardive, diverse per l'aspetto delle foglie e dei semi. La pianta predilige i climi temperati e l'assenza di vento, temperature di poco superiori allo zero per la germinazione, di 20° C per la fioritua e di 13° C per la maturazione. Si adatta a quasi tutti i terreni ma predilige quelli soffici, profondi e permeabili.

THC
|
Delta9-Tetraidrocannabinolo, delta-9-THC, Tetraidrocannabinolo. |
|
|
|
Punto di ebollizione |
200°C |
|
|
Solubilità
|
2,8 mg/ml a 23°C |
|
|
Peso
|
314,47 u.m.a. |
|
Descrizione - La Cannabis contiene centinaia di sostanze chimiche, delle quali circa sessanta appartengono alla classe dei cannabinoidi (i componenti psico-attivi). Chimicamente i cannabinoidi sono terpenoidi, cioè molecole non polari e quindi hanno bassa solubilità in acqua (è per questo motivo che il The di marijuana è leggero, n.d.r.). La concentrazione dei cannabinoidi psicoattivi varia dall'1% al 10% nelle piante e può arrivare fino al 60% nelle resine e negli olii e, tra le varie specie esistenti, il delta-9-Tetraidrocannabinolo è il più abbondante.
Effetti - La Cannabis sativa, se usata come droga, viene generalmente fumata. Gli effetti sono rapidi e durano fino a quattro ore. Tra questi i più comuni sono: benessere, felicità o euforia, dissociazione di idee, cambiamenti della percezione (vista, udito, tatto), rallentamento del tempo ; mentre raramente si verificano casi di allucinazioni.
Di solito c'è anche un aumento dell'appetito e possono esserci anche effetti negativi come ansia, panico o paranoia.
CANAPA IN ITALIA ED IN EUROPA
In un passato non così lontano, l'Italia è stata la seconda Nazione al mondo nella produzione di canapa. Nel corso del decennio 1903-1913, nel nostro paese a tale coltura erano destinati 79.477 ettari con un rendimento di 795.000 quintali annui. La nostra produzione era seconda solo a quella della Russia ma per la qualità della fibra, l'Italia era prima sul mercato internazionale. Nel 1958, iniziò la crisi, le fibre sintetiche sostituirono a poco a poco le fibre naturali e la canapa fu rimpiazzata totalmente dal nylon. Fino al 1964, in Campania, gli agricoltori si opposero alla recessione, ma tutto fu inutile: le navi fecero a meno delle corde e delle vele di canapa, le industrie tessili trovarono molto più vantaggioso l'uso del sintetico, gli oli vegetali vennero anch'essi sostituti con quelli sintetici e la cara, vecchia, canapa, che tanto aveva fatto per l'uomo, assunse il ruolo di “marijuana”, “droga”.
Negli ultimi anni però una serie di fattori d'origine diversa, ha riportato alla ribalta l'interesse per la canapicoltura, in diverse aree europee.
La Comunità Europea, con Regolamento del Consiglio n. 1308 del 29/06/70, ha previsto per i produttori di canapa da fibra, un aiuto economico fissato forfettariamente per ogni ettaro coltivato. L'aiuto è concesso solo a produzioni di canapa da fibra, ottenuta da sementi certificate ed iscritte in un elenco in cui figurano tutte quelle il cui peso di THC (tedraidrocannabinolo, sostanza psicoattiva), rispetto al peso di un campione a peso costante, non è superiore allo 0,3% (art.3, par. 1 Reg. C.E. 619/71 così come modificato dall'art.1 Reg. C.E. 2059/84).
In Italia, come dimostrato dalle ricerche condotte dagli scienziati dell'Istituto superiore di Sanità e di diversi Istituti Universitari fin dal 1984, una stessa varietà europea di canapa da fibra cellulosica, coltivata in regioni climatiche diverse, può presentare un tasso di sostanza stupefacente minore o maggiore a seconda della minore o maggiore influenza dei diversi fattori ecologici locali, ma la variazione del tasso rimarrà sempre entro limiti estremamente modesti e sarà tale da non indurre effetti psicotropi. L'Italia fino alla campagna '98, rappresentava una rarità nel quadro agricolo europeo, perché unica Nazione a non usufruire del premio comunitario di lire 1.440.000 per ettaro coltivato; tutto ciò per effetto del decreto legislativo 309\90 (legge Jervolino-Vassalli, art.26). La nostra legislazione ha il difetto di “fare di tutta l'erba un fascio” e quindi di confondere le acque invece di fare chiarezza, la canapicoltura è legale. Il testo di legge infatti fa menzione esclusivamente della Cannabis Indica, intendendo con questo termine (per altro non accettato in sede scientifica) un tipo di cannabis con alto contenuto di THC; contrariamente alla precisa distinzione presente nella normativa comunitaria che ha l'indiscutibile merito di non generare equivoci. In Europa, non essendoci altra distinzione possibile né da un punto di vista morfologico né sulla base di caratteristiche botaniche, è la canapa più ricca di THC ad essere vietata, salvaguardando così le varietà di canapa da fibra.
Nel corso di un secondo Convegno di studio “Le mille e… una canapa” svoltosi a Caserta il 4-5-6- dic. 1997, è pervenuta la circolare del Ministero delle Risorse Agricole, del 02\12\'97 prot.1° 0734, a firma del ministro Michele Pinto che dava il via alla coltivazione di 1.000 ettari di canapa già a partire dalla campagna 1998-99.Dal convegno è emersa la necessità di creare una filiera produttiva, in grado di organizzare in pochissimo tempo agricoltori, imprenditori, industriali, artigiani. Nasce una associazione nazionale per la canapicoltura, denominata “Assocanapa” il suo obbiettivo è la creazione di un coordinamento nazionale di tutte le energie sparse sul territorio e l'organizzazione delle stesse. Il primo scoglio da superare per la ripresa della coltura, è stato il reperimento in Italia del seme certificato. Un convegno tenutosi a Carmagnola (TO) nel Feb. 1998, ha sviscerato il problema. La canapicoltura poteva riprendere, ma i semi andavano acquistati in Francia (unica nazione fino ad allora, detentrice delle varietà che danno accesso al premio comunitario. Attualmente altre specie, ungheresi e rumene, sono state aggiunte). In Italia sono stati seminati circa 360 ettari di Canapa in diverse regioni: Piemonte, Emilia, Toscana, Marche, Campania. Quali sono le motivazioni? Quali sono i fattori che regolano le possibilità di successo? Qual è la situazione attuale e quali le prospettive?
PROSPETTIVE - Sono le stesse di tutte le altre colture alternative o a destinazione non alimentare. L'U.E., con una serie di successivi provvedimenti, sta tentando di disincentivare la produzione di eccedenze attraverso una serie di meccanismi fra i quali la riconversione produttiva, per ottenere materie prime di cui l'Unione è deficitaria. In tutti i paesi dell'U.E. si assiste ad un fiorire d'iniziative, di ricerche che riguardano principalmente le filiere dell'amido, dell'energia, delle fibre, degli oli tecnici, dei coloranti, dei dolcificanti e, in genere, di materie prime vegetali destinate all'industria.
Si tratta di produzioni di massa, con richiesta industriale di forti quantitativi e perciò coinvolgenti ampie superfici, o di richieste molto limitate, con forte valore aggiunto, di particolari produzioni, ricavabili perciò da colture di nicchia. Alcuni Paesi hanno destinato ampie risorse pubbliche, ma anche private, ed hanno perciò avviato una fase iniziale di sviluppo operativo. L'Italia nel settore è ancora alla fase preoperativa e prenormativa. Le motivazioni per sviluppare colture non alimentari non solo sono in sintonia con le direttive e le indicazioni della U.E., ma sono della più completa attualità. D'altra parte ciò appare ben chiaro dalle prime informazioni su Agenda 2000: si tratta di una vera e propria rivoluzione che potrà comportare notevoli variazioni nella redditività di colture tradizionali e quindi rendere interessanti colture non alimentari.
Inoltre gli impegni della Conferenza di Kyoto, sottoscritti anche dall'Italia, per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera giocano a favore di queste colture. La carta ambientale sarà forse la carta vincente, sia per la modalità di produzione che, per le caratteristiche dei prodotti ottenibili offerti al consumatore.
La canapa risponde molto bene sia da un punto di vista agronomico che ambientale. E' in grado di inserirsi nella maggior parte degli avvicendamenti praticati ed anche di costituire la base per soluzioni innovative. Come ben noto, la canapa è la tipica coltura rinettante, poiché per la velocità d'accrescimento e la capacità di selezionare la radiazione luminosa esercita una competizione vincente nei confronti della maggior parte degli infestanti. Va evidenziato che di grande interesse potrebbe rivelarsi l'introduzione della canapa non solo negli avvicendamenti, ma anche in terreni ritirati dalla produzione o comunque in zone deboli, quale potenziale depurative, competitive contro malerbe e contenitrici dell'erosione.
Quello che l'OMS non vuole farci sapere sulla marijuana
Funzionari dell'OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) a Ginevra hanno soppresso la pubblicazione di uno studio, considerato politicamente inopportuno, in cui si confermava quello che gli ormai attempati hippy sanno da decenni: la canapa indiana è meno pericolosa dell'alcol o del tabacco. Lo studio concludeva non solo che la canapa indiana fumata attualmente in tutto il mondo produce meno danni alla salute pubblica di quelli provocati da alcool e sigarette, ma addirittura che questo resterebbe vero anche se il consumo di marijuana aumentasse fino a uguagliare quello delle sostanze legali. Lo studio avrebbe dovuto essere pubblicato in una relazione sugli effetti dannosi della canapa indiana, pubblicata nel dicembre scorso dall'OMS, ma è stato eliminato all'ultimo minuto dopo un'estenuante discussione tra funzionari, gli esperti che avevano preparato la relazione e un gruppo di consiglieri esterni.
Lo studio sulla canapa indiana, il primo sull'argomento commissionato dall'OMS dopo quindici anni, era atteso con impazienza da medici e specialisti di tossicodipendenza. La giustificazione ufficiale dell'esclusione del confronto tra i derivati della canapa indiana e altre sostanze legali è che "l'affidabilità e la rilevanza per la salute pubblica di tali confronti sono opinabili". All'interno dell'OMS c'è chi afferma che il confronto era scientificamente valido e che a determinarne la cancellazione sono state le pressioni politiche. A quanto pare, sarebbero stati i rappresentanti dell'Istituto nazionale degli Stati Uniti per il controllo dell'abuso di stupefacenti (United States national institute on drug abuse) e del Programma internazionale delle Nazioni Unite per il controllo degli stupefacenti (United Nations internationai drug control programme) a mettere in guardia l'OMS rispetto all'eventualità che il confronto potesse giovare ai gruppi sostenitori della legalizzazione della canapa indiana. Uno dei ricercatori che ha preparato la relazione ha dichiarato: "Agli occhi di qualcuno, qualunque confronto di questo tipo è un sostegno alla legalizzazione della marijuana".
Un altro ricercatore, Billy Martine del Medicai College di Richmond, in Virginia, ha riferito che alcuni funzionari dell'OMS "sono andati fuori di testa" quando hanno visto le bozze della relazione. La parte esclusa, nella versione che ci è pervenuta, dice che il motivo del confronto "non è di promuovere l'uso di una droga al posto di un'altra, ma piuttosto di eliminare i due pesi e le due misure con cui finora sono stati valutati gli effetti della Cannabis sulla salute". Ciononostante, nella maggior parte dei confronti tra la canapa indiana e l'alcol, la droga illegale risulta preferibile a quella legale, o perlomeno equivalente. La relazione conclude, per esempio, che "nelle società evolute la canapa indiana sembra ricoprire un ruolo molto secondario nello scatenare la violenza, al contrario dell'alcol".
Opuscolo: [Pagina 1][Pagina 2][Pagina 3][Pagina 4][Pagina 5][Pagina 6]